







Una proposta per la vostra riflessione personale e di coppia.
Metteremo questi contributi all’inizio di ogni mese.
Si tratta di un cammino che vogliamo fare insieme.
Selva continua ... anche così
I vostri suggerimenti saranno benvenuti.
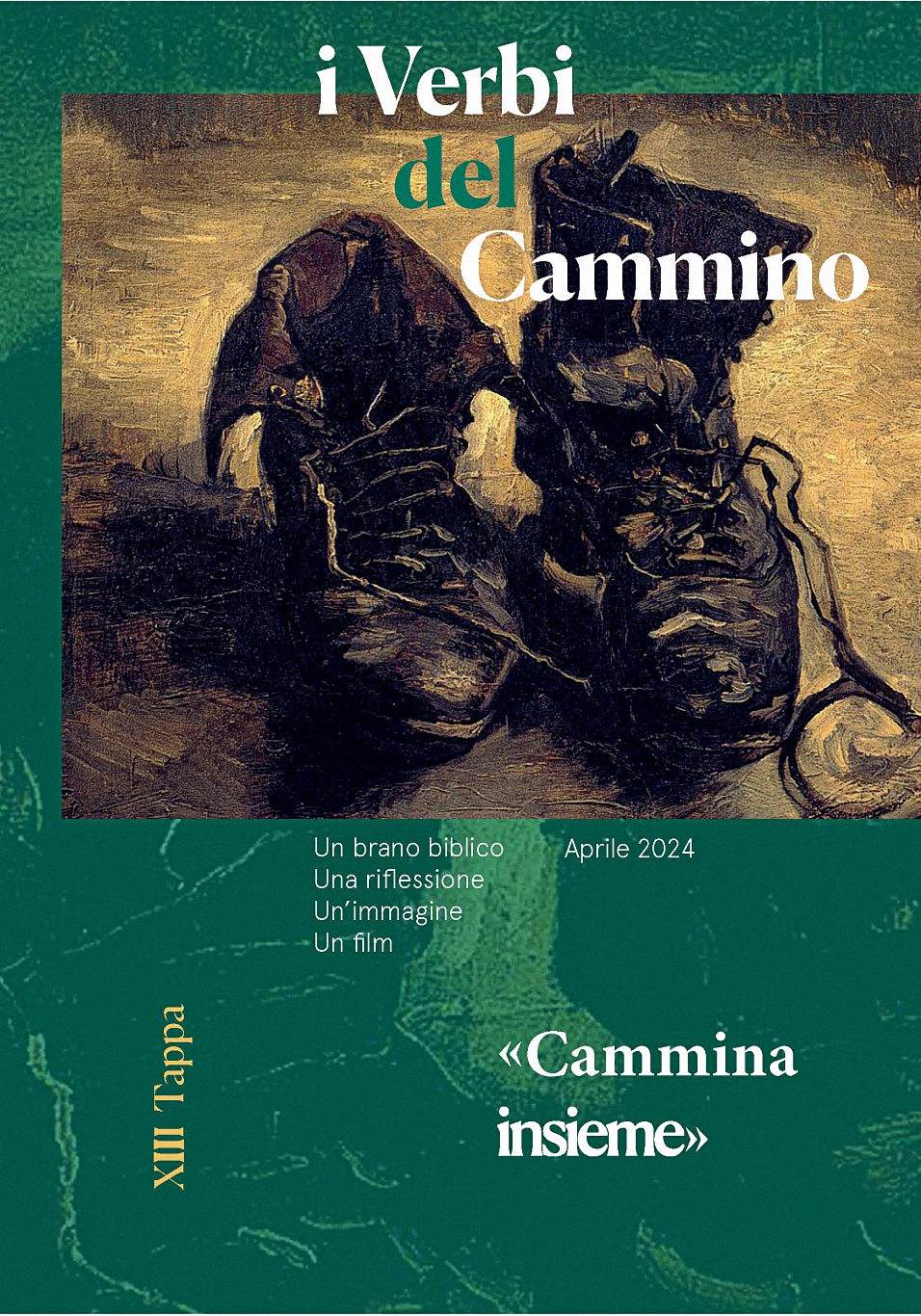
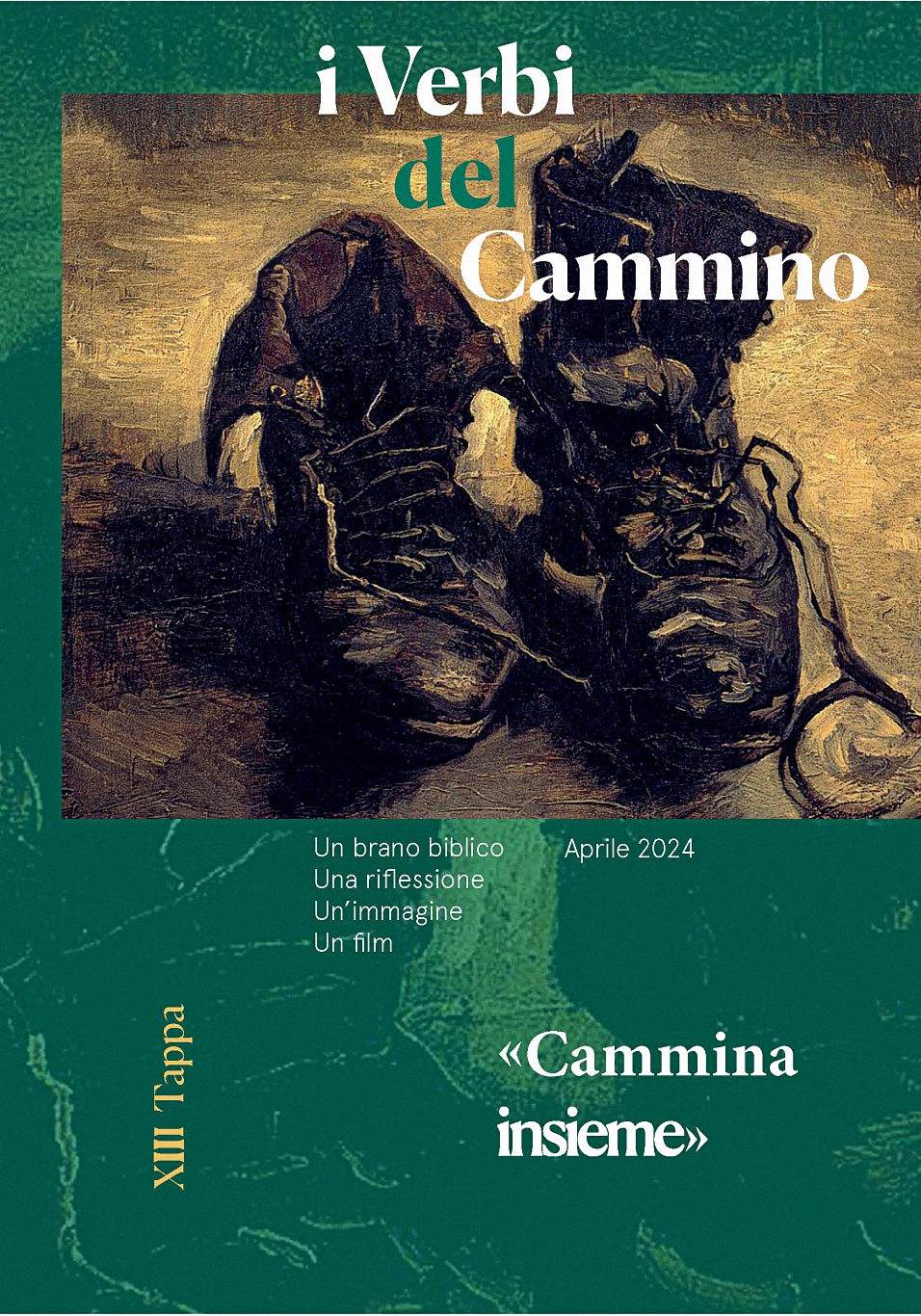
«Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia»
(Tobia 8,7)
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
«Ora disse: Un uomo aveva due figl»
Luca 24,13-35
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,
14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.
16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
17Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste;
18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?".
19Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;
20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.
21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute.
22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto".
25Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!
26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?".
27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
29Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro.
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.
32Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?".
33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
34i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".
35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
La seconda parte del Vangelo di Luca narra il cammino di Gesù a Gerusalemme, un cammino che comincia in 9,51 («[Gesù] indurì il volto per camminare verso Gerusalemme») e termina con i giorni della passione e morte di Gesù in croce.
L’evangelista aveva già narrato un viaggio a Gerusalemme dello stesso Gesù all’età di dodici anni, in compagnia dei genitori, un viaggio dal chiaro sapore programmatico («resistette Gesù, il figlio, a Gerusalemme»: 2,43).
Un primo aspetto che possiamo evidenziare è che Gesù cammina e cammina non come un vagabondo senza meta, ma come un pellegrino che ha sempre ben chiaro dove andare.
E la sua non è tanto una meta geografica, quanto l’orientamento, il senso stesso del suo vivere e del suo morire: rivelare agli uomini l’amore del Padre.
Non a caso le sue prime parole riguardano il Padre («Perché dunque mi cercavate? Non sapevate che bisogna che io sia nelle cose del Padre mio?»: 2,49) e le sue ultime parole sono dirette al Padre («Padre, nelle tue mani affido il mio spirito»: 23,46).
A maggior ragione sorprende che in questo brano, detto non a caso dei “Due di Emmaus”, Gerusalemme costituisca, almeno inizialmente, il punto di partenza, e non di arrivo, del cammino. Ma seguiamo il testo, pur solo per brevi cenni.
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,
14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
Perché Emmaus? Geograficamente è una località che non si riesce a collocare. Conosciamo però un’altra sua ricorrenza nella Bibbia. Nel Primo libro dei Maccabei (3,38-4,25) Emmaus è infatti il luogo in cui si è svolta una battaglia. Giuda Maccabeo ha condotto il popolo d’Israele alla vittoria sui generali seleucidi di Antioco (II sec. a.C.). Si è avverato quello che Giuda aveva predetto: «Allora tutte le nazioni sapranno che c’è chi riscatta e salva Israele» (4,11). Emmaus rappresenta perciò il luogo del successo, dei ricordi positivi, è il luogo dove attingere speranza.
15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.
16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
17Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste;
18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?".
19Domandò loro: "Che cosa?".
I due che si allontanano da Gerusalemme verso Emmaus fanno l’esperienza di non essere lasciati soli, di non essere abbandonati alla loro delusione e alla loro incomprensione. Gesù fa i loro stessi passi, si associa al loro cammino. I Due di Emmaus sperimentano così la verità, la profondità e la bellezza di quelle parole che, tramite il profeta Natan, il Signore aveva rivolto al re Davide: «sono stato con te ovunque sei andato» (2Sam 7,9). Pare una sequela capovolta, ma forse è la sequela autentica.
Quella di Gesù, che cammina fianco a fianco ai Due, è una presenza discreta: Gesù non parla di sé, non si impone (non lo riconoscono!) ma si interessa a ciò che quelle persone stanno vivendo. Innanzitutto, chiede e ascolta. Del resto non farà così anche con la Maddalena («Donna, perché piangi? Chi cerchi?»: Gv 20,15)? E non farà così anche con i sette sul lago di Galilea («Figlioli, non avete nulla da mangiare?»: Gv 21,5)?
«Solo chi ascolta può parlare» (Dag Hammarskjöld, Tracce di cammino, 34). Questo è lo stile del Signore, Uno che «cammina umilmente» con i suoi, “rovesciando” la prospettiva di Michea («Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio»: 6,8).
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
29Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro.
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.
32Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?".
33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
34i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".
35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Tornare a Gerusalemme significa anche tornare verso la comunità. Il Risorto compie la comunione. La vita comune è la conferma di essere stati incontrati dal Risorto.
Gerusalemme costituisce dunque la meta, ancora una volta non tanto da un punto di vista geografico, quanto da un punto di vista di vista esistenziale e profondo: la meta è la comunità, la vita fraterna resa possibile e vivibile già qui e ora dall’essere stati incontrati da Gesù Risorto.
Il camminare autentico è un camminare insieme: insieme a Lui e insieme agli altri. Importante è, come direbbe il Manzoni, «studiare il passo» perché nessuno venga lasciato indietro.
«Il nostro camminare è sempre un “cercare” amore, unico luogo dove ci sentiamo di casa e possiamo riposare. La Pasqua definitiva, che ci porta a casa, è l’amore del Figlio che lava i piedi dei fratelli, perché camminino come lui ha camminato» (Silvano Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Giovanni, p. 321. Commentando Gv 13,5).
Mi hanno sempre colpito con forza le prime parole che Dio rivolge ad Abramo all’inizio del capitolo 12 di Genesi: Vattene dalla tua terra, dalla tua famiglia e dalla casa di tuo Padre, verso la terra che io ti indicherò… Parole molto dure eppure cariche di una promessa tutta da capire e comprendere. Una promessa che implica un cammino, un mettersi in viaggio e sconfiggere così la sedentarietà e la stabilità dei luoghi certi e sicuri. Andare verso una meta e contemporaneamente andare verso se stessi verso una sempre nuova identità di se stessi. Ecco, personalmente il camminare mi richiama a questo orizzonte di senso e di valore perché camminare non è solo un buon esercizio per il nostro corpo, camminare è una vera e propria modalità di pensiero, anzi un modo di pensarsi. Un pensiero pratico che unisce movimento, instabilità, fermezza di intenti e motivazioni, allenamento e spirito gagliardo. Un gesto squisitamente umano eppure non così scontato. Perché camminare? Perché mettersi ogni volta di fronte ad un nuovo cammino e poi per arrivare dove? Forse dove siamo già? Non so se sono sulla strada giusta ma devo dire che una delle immagini più belle e luminose che mi richiama il camminare muovono da quell’ interrogativo che Gesù pone al cieco … cosa vedi? E lui.. vedo degli uomini come alberi che camminano. Non ci sarebbe bisogno di dire altro per capire a cosa ci richiama questa immagine: l’immobilità che diventa movimento, vita che diventa cammino.
Questo quadro è stato dipinto da Van Gogh quando si trovava a Saint-Rémy, in Provenza, durante il suo ricovero nell’ospedale psichiatrico. Il soggetto è piuttosto semplice, volutamente semplice. È come se Van Gogh avesse voluto lasciare appena accennati i suoi soggetti ricorrenti, gli ulivi e i cipressi, per dare maggior visibilità alla coppia in primo piano. Sia i cipressi, così tanto maestosi e turbolenti in molti altri dipinti, sia gli ulivi che qui vengono ridotti quasi a dei cespugli, fanno da discreto paesaggio all’incedere dei due personaggi presenti. Sopra di loro l’altro soggetto del dipinto, uno spicchio di luna crescente che, se pur spesso compare nei suoi quadri, qui è inserita in un cielo al crepuscolo ma ancora chiaro, non in un cielo notturno; una situazione forse un po’ arbitraria, ma in alcune rare circostanze fortunate una possibile combinazione di bellezza suggestiva, una carezza della natura alle umane vicende.
La donna e l’uomo sono stati rappresentati senza i lineamenti del volto, solo i capelli e la barba rossa di lui fanno pensare che Van Gogh abbia voluto in qualche modo rappresentare se stesso, ma al contempo ha preferito lasciare che ciascuno possa immedesimarsi in quel procedere affiancati e dialoganti, non ha dato un’identità precostituita perché non sia inteso il “chi” come soggetto del quadro ma il “che cosa” e “verso dove”. ■ Chiudo gli occhi e mi immagino un contesto in cui vorrei trovarmi a camminare che mi dica bellezza e serenità; collina, mare, montagna, un parco in città… In quel luogo sto procedendo con qualcuno, una persona o poche più, persone significative della mia vita, affetti importanti. Procediamo prima in silenzio, poi dialogando. Di cosa parliamo? Ascolto senza giudicare… ■ Metto in relazione questo mio/nostro procedere con il tempo anagrafico della mia vita. È importante avere sana consapevolezza del proprio qui ed ora, del tempo che si vive, delle proprie potenzialità, dal cammino fatto e di quello che ci può attendere. ■ Questo quadro è uno dei pochissimi di cui Vincent non ha scritto nulla in alcuna lettera tra quelle che mandava a suo fratello Theo in cui gli descriveva le sensazioni che intendeva rappresentare.
Tom (Martin Sheen) è un oculista californiano, con più di sessant’anni di vita alle spalle, è vedovo, ha uno studio privato ormai consolidato, conosce benissimo i propri pazienti di cui sa leggere gli sguardi oltre che gli occhi, aiuta gli altri a vedere meglio il mondo che lui ha visto poco. Oltre che dal lavoro, le sue giornate sono scandite dagli appuntamenti fissi con i vecchi amici del Country Club e dalle partite a golf. Tom ha un unico figlio quarantenne, Daniel (Emilio Estevez, figlio di Martin Sheen anche nella realtà), molto diverso da lui: è un uomo che ha scelto di vivere viaggiando per il mondo, senza nemmeno un cellulare che permetta di rintracciarlo. Dopo la morte della madre, Daniel ha rinunciato a un promettente percorso di studi accademici, con grande disappunto del padre, a favore di una libertà esistenziale per lui irrinunciabile. I due comunicano attraverso messaggi con i quali è soprattutto il padre a essere informato sugli spostamenti del figlio. Durante un’amena e pigra partita a golf con gli amici, Tom riceve una telefonata dalla gendarmerie francese: Daniel è morto a poca distanza da un paesino sui Pireni francesi, bisogna andare a occuparsi del riconoscimento del corpo e del destino della salma. Tom è distrutto, non si capacita di quanto è successo a suo figlio, parte per la Francia, ed è come se uscisse per la prima volta dal proprio guscio, fuori nel mondo, come avrebbe voluto per lui suo figlio. Consegnandogli le poche cose con cui suo figlio viaggiava, la polizia gli comunica che Daniel è morto per un incidente in montagna, un’improvvisa tempesta gli è stata fatale, proprio quando aveva appena iniziato il pellegrinaggio per Santiago di Compostela. Tom è smarrito, non sa che fare, il suo mondo non ha più senso. Fa cremare il corpo del figlio e, raccolte in una scatola le sue ceneri, decide di portarle con sé partendo per il Cammino di Santiago. In qualche modo, con lo zaino e con l’attrezzatura del figlio sulle proprie spalle, vuole intraprendere il pellegrinaggio insieme alle ceneri di Daniel, intende così far compiere al figlio il cammino che aveva appena iniziato. Per la prima volta Tom interrompe la routine della propria vita per dedicarsi a qualcosa di completamente diverso. Inizia da solo il suo cammino ma lungo la strada si affiancano a lui altri pellegrini provenienti da altri paesi e da altri percorsi di vita. Ogni pellegrino ha un motivo diverso per aver intrapreso il viaggio e, a mano a mano che si apre il cammino, chi cammina insieme deve aprirsi agli altri, anche scoprendo così ragioni per proseguire che fino a poco prima aveva ignorato. È in questo dinamismo tra percorso interiore ed esteriore che avviene il miracolo per i pellegrini: l’apertura del cuore e della mente verso una nuova consapevolezza. In questo racconto il paesaggio è più che una semplice cornice estetica, ne diventa parte integrante, è l’orizzonte sempre emozionante nel quale si spostano i personaggi di questo film: montagne nebbiose, campi di grano, fiumi impetuosi, strade polverose e assolate, è il Creato che nella sua varietà e bellezza accoglie le creature che lo attraversano. 1) Racconti di un pellegrino russo, Qiqajon, Bose 2005, p.23.↵ 2) Jean – Pierre Sonnet, Il canto del viaggio, Qiqajon, Bose 2009, p. 15.↵ 3) Christian Bobin, L’uomo che cammina, Qiqajon, Bose 1998, p.9.↵ 4) J. – P. Sonnet, Id, pp. 14-15.↵ 5) J. – P. Sonnet, Id, pp. 76-77.↵ • Regia: Emilio Estevez Maria Grazia e Umberto Bovani,
Due discepoli si sono messi in cammino. Vogliono prendere le distanze (molto più ampie e profonde degli undici chilometri di cui si parla) da Gerusalemme, da ciò che per loro quella città significa, e si dirigono verso Emmaus.
Non così Gerusalemme che ai loro occhi appare invece come il luogo della sconfitta, dell’insuccesso, del fallimento, della morte. Infatti a Gerusalemme hanno vinto i loro nemici e questa città costituisce perciò il luogo dei ricordi negativi.
Siamo in presenza quindi non tanto di una geografia fisica ma di una geografia interiore: camminare per lasciarsi alle spalle Gerusalemme è la raffigurazione di quel «noi speravamo» (v. 21) che di lì a poco i Due di Emmaus, quelli che Padre Ledrus definisce i due «disertori» (Temi per gli Esercizi spirituali, n. 48), diranno allo Sconosciuto che si è fatto loro compagno di cammino.
I due si allontanano da Gerusalemme, Gesù si avvicina a loro.
Egli ci incontra sulle nostre strade.
Il Risorto non abbandona i suoi: si fa vicino a tutti, anche a chi ha deciso di prendere le distanze da Lui. Gesù si fa ministro della consolazione: «considerare il compito di consolatore che Cristo nostro Signore svolge, paragonandolo al modo con cui gli amici sono soliti consolare gli altri» (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 224).
È il pastore che va in cerca della pecorella perduta: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta"» (Lc 15,4-6).
Di nuovo, con i Due di Emmaus si ripete quanto già aveva anticipato il capitolo secondo del Vangelo di Luca quando Gesù, dopo che i suoi non avevano compreso le sue parole, «scese dunque con loro (!) e venne a Nàzaret e stava loro (!) sottomesso» (2,51).
Gesù è disposto ad andare oltre. La sua è una disponibilità piena e commovente. Si fa nostro compagno di cammino, disponibile ad andare anche oltre ogni nostra fuga. «Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico: "Almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte", nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno; per te le tenebre sono come luce» (Sal 139,8-12). Nessun luogo è così lontano da impedire al Signore di raggiungerci e di camminare al nostro fianco. È davvero il Dio con noi (cf. Mt 1,23; 28,20). Questo ci rivela in profondità che forse la vera meta del Suo cammino, la vera Gerusalemme, è il cuore di ogni uomo, è il mio cuore.
Gesù si fa compagno di cammino e si fa compagno di mensa.
La parola spezzata lungo il cammino illumina il pane spezzato sulla mensa.
La risurrezione di Gesù è la rinascita dei Due di Emmaus ai quali di nuovo si aprono gli occhi.
La fuga da Gerusalemme si è trasformata nella possibilità di un nuovo incontro.
Impossibile rimanere fermi. Impossibile che Emmaus sia il traguardo. Alla conversione del cuore corrisponde l’inversione di marcia. Di nuovo i Due si mettono in cammino: stessa strada ma direzione opposta. Il biglietto di sola andata per Emmaus si trasforma in biglietto andata/ritorno (definitivo!) per Gerusalemme.
Il Signore incontra i Due di Emmaus e Simone perché si possano incontrare tra loro e con gli altri (Lc 24,33-34).
Il Signore incontra Saulo e Anania perché Saulo e Anania si possano incontrare (cf. At 9,3-6.10-17).
Il Signore incontra Pietro e Cornelio perché Pietro e Cornelio si possano incontrare (cf. At 10,1-27).
Una riflessione
Prega che sia lunga la via…non affrettare assolutamente il viaggio ci consiglia il poeta Kavafis nella sua bellissima poesia Itaca.
Perché il viaggio va gustato passo a passo senza cercare altre soddisfazioni integrative se non quella semplice, elementare, basilare di camminare e poi ancora camminare. Perché Io ti darò intelligenza e ti insegnerò la via per cui tu hai da camminare (Salmo 31). Non c’è bisogno di altro. Camminare apre scenari inediti di ricerca e conoscenza perché non ha bisogno di niente se non della nostra determinazione, del nostro corpo e della nostra umiltà.
… e mi inoltro sospeso, entro nell’ombra
dubito…mi smarrisco nei pensieri
è la nostra foresta inestricabile
ascoltare le foglie vive, i brividi
e la remota vibrazione. (Mario Luzi)
Metterci in cammino ci avvicina all’esperienza della Salvezza. Se volessimo leggere in senso ignaziano il camminare potremmo dirlo così: il cammino ci permette di riconsiderare la strada percorsa, riscoprirne il fondamento, puntare verso una possibile meta e dare così movimento ad una logica di Salvezza. Perchè la ragione del camminare non è mai nell’andare verso qualcosa ma sempre nel camminare verso qualcuno da riconoscere al proprio fianco e di fronte a sé. Non a caso la condizione ordinaria degli amanti è quella degli erranti, degli esiliati perché sempre nella storia con l’altro e con gli altri siamo chiamati a separarci da qualcosa così come siamo chiamati a incamminarci verso terre nuove.
Infine un semplice elogio dei nostri piedi, materia del nostro camminare. Il filosofo Maurice Merleau-Ponty ci dice che i piedi sono capaci di capire e pensare ancor prima che la testa colga le stesse cose. Addirittura in questo senso è possibile ricevere risposte a domande che ancora non sapevamo di esserci posti. Come dire che nei piedi è custodita una inedita sapienza. E credo che sia anche per questo motivo che nei testi biblici i piedi sono citati continuamente (più di trecento volte, 92 volte solo nel nuovo testamento!!) Nulla è mai citato casualmente nei testi biblici. Tutto è sempre molto misurato nella direzione di una prospettiva sapienziale.
Questo per dire che i nostri piedi hanno una valenza normativa per la nostra vita perché normano la nostra relazione con ciò che ci trascende e ci fanno intravedere un legame profondo tra terra e cielo, ci danno, appunto, risposte a domande che ancora non sapevamo di esserci posti. Imparare a camminare sulla terra senza nostalgia del cielo è una grande scuola, perché camminare sulla terra è cosa molto buona quando non si ha nostalgia del cielo, perché la terra non è altro dal cielo ed è sulla terra che si impara a comprendere il cielo.
Un’immagine

Vincent can Gogh | Paesaggio con coppia che cammina e luna crescente ,1889-1890
I loro gesti e i movimenti delle braccia fanno intendere che stanno parlando, quasi sembra di sentirli dialogare in quel silente paesaggio. In particolare lei ha un braccio animatamente alzato, un gesto che ricorda le braccia elevate che avrà Marta nel suo di poco successivo quadro “La resurrezione di Lazzaro”; un modo di procedere che esprime vitalità, partecipazione con tutto il corpo, un essere presenti lì in quel momento senza trattenimenti e distrazioni.
Corpi affiancati, passi affiancati, voci intercalanti, avvolti dalla luce calda del giorno che si avvia al termine. Ma nel cielo che si colora di un arancione che prelude alla notte, ecco già comparire uno spicchio bianco di luna crescente… a ricordar che tutto finisce per ricominciare, che ad ogni fine corrisponde un nuovo inizio e che quel nuovo inizio contiene in sé la promessa di una luna piena ancora più grande e luminosa.
A noi il saper cogliere questo messaggio in ogni calar del giorno e farci trovare vitali, in cammino, presenti nelle relazioni che contano, capaci di desiderare, credenti nella ciclicità degli eventi di vita e non arresi inermi a situazioni di morte. Proprio come ha fatto Van Gogh che mentre era ricoverato dipingeva il suo desiderio di camminare libero tra ulivi e cipressi con una donna al suo fianco.
Allora sì ha e avrà senso chiedere in preghiera di “giungere insieme alla vecchiaia”.
Entro nel quadro:
Perché il camminare sia vitale è importante che parta dal sapere da dove si parte e ogni tanto fare il punto per ricollocarsi. Proprio il libro di Tobia ci insegna, attraverso la storia dei suoi genitori, come non si sia mai così troppo avanti con l’età da poter giustificare un atteggiamento di paralisi e cecità. Così come gli eventi sorprendono Sara e Tobia con eventi di vita insperati, così anche vengono sorpresi gli anziani genitori che ritroveranno senso e desiderio per il loro procedere.
Provo a farlo, mettendo per scritto quanto emerso in questo tempo di riflessione, a modi di lettera, parole, versi… Poi affido il mio scritto in preghiera e se lo ritengo lo condivido con chi sta camminando con me.Un film

Emilio Estevez | Il cammino per Santiago (The Way) | 2011
Quella del pellegrino si può dire sia una condizione connaturata al popolo di Israele narrato nella Bibbia, così come è caratterizzante di chi si considera seguace di Cristo. In uno dei testi della spiritualità cristiana orientale ampiamente conosciuto e diffuso anche in occidente, troviamo queste parole iniziali: «Per misericordia di Dio sono uomo e cristiano, per opere gran peccatore, per vocazione pellegrino senza dimora, del ceto più umile, che va forestiero di luogo in luogo.» [ 1 ] . La storia spirituale di ognuno è rappresentabile come un viaggio di pellegrinaggio, fosse anche nel senso di un percorso nell’anima. Perfino nel più immobile dei percorsi, per chi è in cerca, è quantomeno il proprio punto di vista sull’esistenza che si sposta verso una prospettiva di maggiore consapevolezza. Tornando alla Bibbia, troviamo il movimento, come elemento tipico dell’essere umano, fin dall’inizio; già Adamo è homo viator: «questo primo esilio incornicia tutti gli altri e colora la condizione umana: dopo Adamo ogni uomo attraversa il tempo e lo spazio con la nostalgia di un paradiso perduto. Con la nostalgia, cioè con la speranza di pervenire a una terra, un giardino, una città, un luogo dove vedrà il suo essere compiuto.» [ 2 ] Nella Bibbia le vicende del popolo di Israele sono segnate dalle metafore del cammino, della via, del sentiero; lo sa anche il salmista: «mi insegnerai la via della vita» Sal 16, 11. E ritorna la condizione del pellegrino anche nella Prima lettera di Pietro: «vi esorto come gente di passaggio e stranieri» 1Pt 2, 11. Molto spesso nella Bibbia il camminare ha come meta una fonte, una sorgente verso la quale è orientato il cammino. Per il cristiano, la fonte verso la quale è orientato il cammino, consiste in Cristo. Egli è l’uomo che cammina: «Cammina. Senza sosta cammina. Va qua e poi là. Trascorre la propria vita su circa sessanta chilometri di lunghezza, trenta di larghezza. E cammina. Senza sosta. Si direbbe che il riposo gli è vietato.» [ 3 ] Come scrive Jean – Pierre Sonnet: «Il film sulla sua vita avrebbe potuto, per primo, intitolarsi La strada.» [ 4 ] La mistica del camminare, fatta di metafore, di cammini interiori ed esteriori, di terra battuta e sudore arriva fino a noi passandoci il testimone di milioni di pellegrini che si uniscono al corpo in cammino di Gesù. La spiritualità ignaziana pone nel cammino, inteso nelle diverse declinazioni semantiche della parola, una particolare attenzione. Già nel percorso terreno del fondatore della Compagnia di Gesù, si tratta di un elemento decisivo: «Ignazio di Loyola trascorse buona parte della sua vita sulle strade di Francia e Navarra; salì a Gerusalemme e ritornò. Eppure, è nella preghiera che questo “pellegrino”, come amava chiamarsi, ha percorso le vie più decisive della sua esistenza. Ebbe a cuore di condividere questi pellegrinaggi interiori, invitando chiunque desideri “meglio amare e seguire” Cristo a fare del libro dei vangeli l’itinerario della propria libertà […] Ignazio di Loyola lo aveva compreso, esporsi alle parole della Scrittura è divenire discepoli di un maestro itinerante, che ci precede sulla via che è lui stesso: “Io sono la via” (Gv 14, 16).» [ 5 ]
Note
IL CAMMINO PER SANTIAGO (The Way)
• Paese: USA, Spagna
• Anno: 2011
• Durata: 121 min
• Genere: drammatico
• Regia: Emilio Estevez
• Interpreti: Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger, Yorick van Wageningen, James Nesbitt.
• Visibile su: Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Film, RaiPlay.
A cura di
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
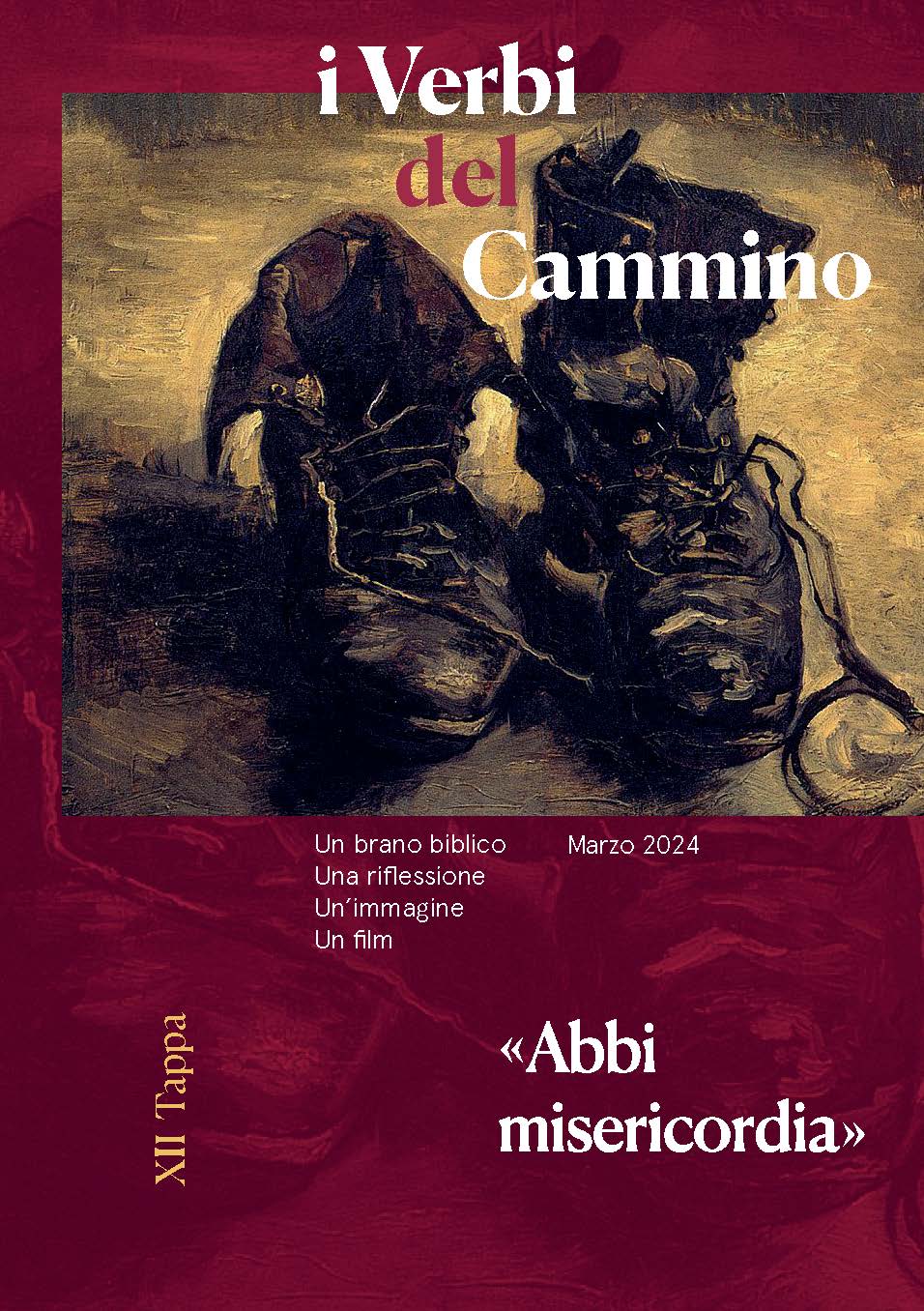
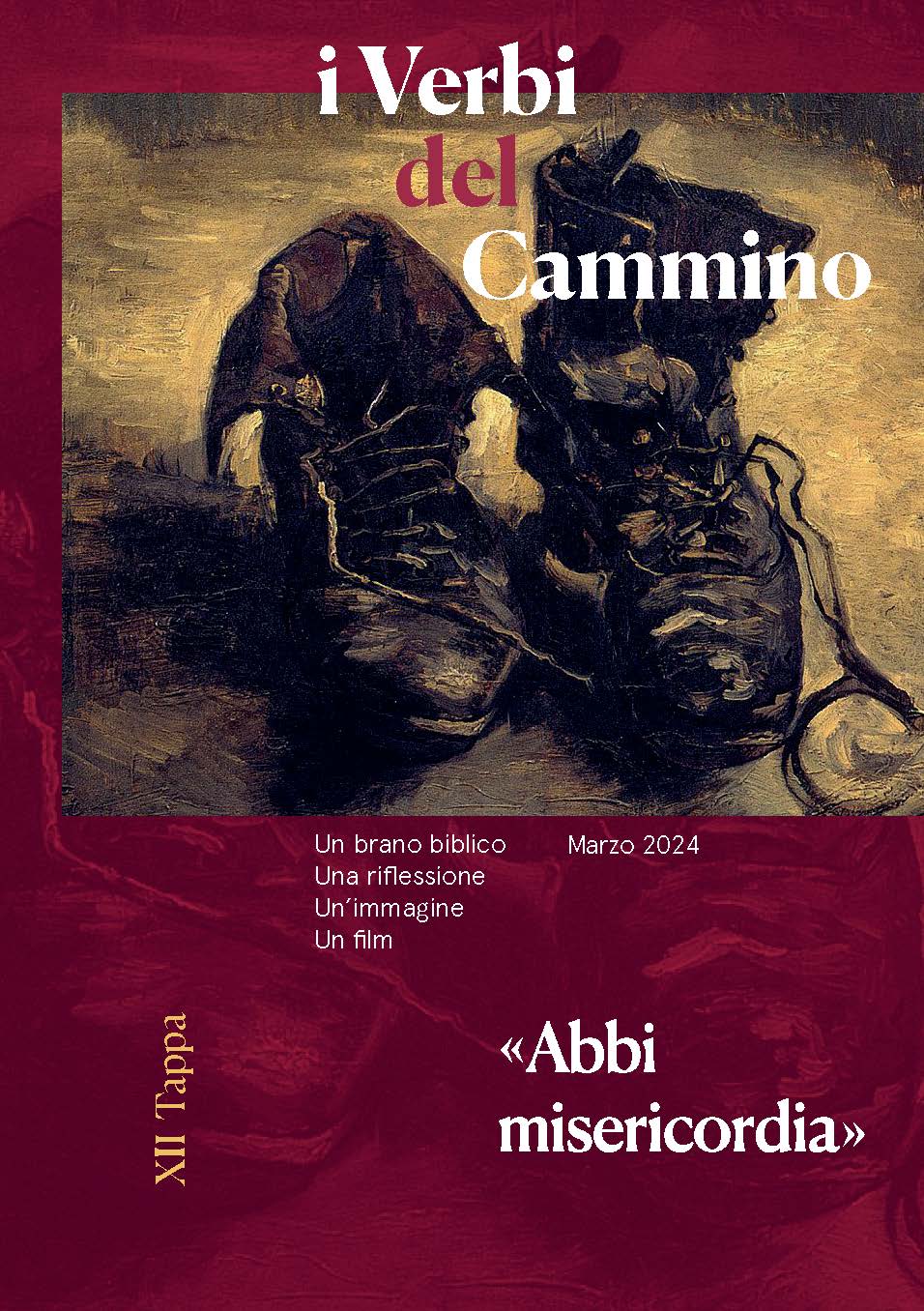
«Dégnati di avere
misericordia
di me e di lei»
(Tobia 8,7)
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
«Ora disse: Un uomo aveva due figl»
Luca 15,1-32 1Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo.
2I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro».
3Allora egli disse loro questa parabola:
4«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova?
5Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento,
6va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta.
7Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.
8O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova?
9E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta.
10Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». «Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto,
con la compassione e la misericordia. Conosciamo queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). Veniamo ora al testo lucano che suddividiamo in varie parti. IL CONTESTO
Una o tre parabole? Siamo in presenza di tre parabole, ma di un unico discorso. Le due prime parabole alludono e preparano la terza: la pecora smarrita (vv. 3-7) richiama il figlio minore, la moneta smarrita (vv. 8-10) il figlio maggiore, il “perduto in casa”. Vediamo ora i tre personaggi della terza parabola (vv.11-32) e le relazioni fra loro.< IL FIGLIO PIÙ GIOVANE IL FIGLIO MAGGIORE IL PADRE IL PADRE COL FIGLIO MINORE Il figlio minore comprende finalmente il cuore del padre perché, parlandogli, omette (o è il padre a interromperlo?) una frase del discorso che aveva preparato in precedenza: «trattami come uno dei tuoi salariati». Ha compreso che il cuore di suo padre è più grande della logica del “ciò che mi spetta”. La conversione non è tanto la condizione previa del perdono, bensì il suo autentico frutto. Capire e accogliere finalmente il padre è il vero ritorno, la vera conversione. IL PADRE COL FIGLIO MAGGIORE Prende l'iniziativa, esce verso di lui. Esce, non solo di casa. Poi lo chiama «figlio». Il maggiore, invece, non lo aveva chiamato «padre»: dicendogli che lo aveva servito tanti anni, dava a intendere che lo vedeva come un padrone. Il padre si aspetta che il figlio maggiore smetta di vivere una vita da schiavo: «Non sei più schiavo, ma figlio» (Galati 4,7). Affinché anche il fratello maggiore viva libero nella casa di suo padre è necessario che consideri e accetti come suo quello che è successo a suo fratello, che era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Si partecipa alla festa partecipando alla gioia del padre per il figlio ritrovato: qui mostriamo di aver conosciuto il padre. UNA PARABOLA SENZA FINALE? CONCLUDENDO Mi sono chiesto più volte cos’è misericordia, quasi fosse un’entità o una presenza. Le parole non saziano il desiderio di sapere, soprattutto si immobilizzano di fronte a qualcosa che percepiamo come superiore alle nostre forze. Della misericordia serve fare esperienza non serve riempirsene la bocca, serve fermare il tempo e chiedersi quando e dove o con chi ci è accaduto di vedere in atto la misericordia. Allora torno indietro con la memoria e vado a pescare qualcosa di sepolto, molto sepolto, quasi dimenticato. Mio nonno Alfredo i suoi ultimi anni di vita li trascorse in una casa per anziani a Cuneo. Non era certo felice della collocazione ma visse la sua condizione con benevolenza e lucidità. La sua mente fino alla fine, giunta a 92 anni, rimase lucida e chiara come un libro di storia aperto. Aderì al Fascismo da subito, fece la Marcia su Roma e aderì alla Repubblica di Salò dopo l’8 settembre del 1943. Dopo la guerra per le sue “partecipazioni” ad eventi che coinvolsero Le Brigare Nere scontò 12 anni di carcere e neanche a dirlo rimase fascista fino alla fine della sua esistenza. Ma ritorniamo agli ultimi anni della sua vita. Nella camera adiacente la sua nella casa-ricovero c’era un’anziana signora che anche lei aveva vissuto gli anni terribili della guerra e della resistenza, ma sul fronte decisamente opposto. Lina, così si chiamava, a differenza di mio nonno non aveva conservato una mente lucida ed attiva, ricordava poco e quel poco che ricordava era semplicemente un riaffiorare di volti molto velati e situazioni di vita scollegate tra loro. Mio nonno spesso passava il tempo ad ascoltarla cercando di ricomporre tasselli di un puzzle scomposto, ma senza mai contraddirla, senza mai imporle la sua verità storica, semplicemente la confermava nella sua esperienza così diversa dalla sua, ma così vera come la sua. Una verità che per entrambi era ormai solo da confermare e non da confutare…non c’era più nulla da confutare, da scandagliare in una presunta verità delle cose. Un atto di reciproca riconciliazione, un atto, al termine delle loro vite, di reciproca misericordia. Questo ricordo mi ha riportato alla mente una bella poesia della poetessa Patrizia Cavalli recentemente scomparsa. Un modo anche per ricordarla… Dolcissimo è rimanere e guardare nella immobilità Dolcissimo è rimanere Quando ha dipinto questo quadro Chagall aveva 88 anni e forse ancora nostalgia della sua patria, la Russia. Lui, ebreo, si è sentito libero di rappresentare questo passo del Nuovo Testamento, identificando in qualche modo l’abbraccio tra il padre ed il figlio ritrovato con un suo ritorno riconciliato tra le braccia del suo paese natale, Vitebsk, tante volte raffigurato nei suoi quadri. Anche qui infatti la strada, le case raffigurate, le cupole della cattedrale ortodossa sono della sua città. La condizione di ebreo errante in cui si identificava, emigrato in Francia, poi negli Stati Uniti per sopravvivere alla persecuzione, scampato a due guerre mondiali, tornato in Francia, tragicamente vedovo e poi risposato, passato dall’essere Moishe Segal ad un più occidentale Marc Chagall, gli ha comunque fatto sentire sempre vivo il suo legame con la sua terra e cultura d’origine. Quella stessa nostalgia che ha mosso l’abbraccio della parabola, in qualche modo. Il padre ed il figlio, uniti nell’abbraccio al centro della scena, sono vestiti degli abiti del suo tempo, contemporanei, per dire che in ogni tempo, in ogni giorno, è possibile che si compia l’attesa di quell’incontro. Anche il gallo è rappresentato per dire che ogni nuovo giorno può portare con sé quella novità tanto desiderata quanto quasi insperata, quasi temuta. Oltre la scena dell’abbraccio, illuminata dal giallo del sole che splende e scalda una nuova possibile vita, viene rappresentata la strada che conduce al paese, la strada da percorrere per tornare ad abitare la casa natale. Lì il figlio è chiamato a continuare il suo cammino. Lì, rinnovato dall’amore accogliente e gratuito del padre, può tornare con consapevolezza nuova ad abitare la quotidianità che lo attende.
Ispirato al poema di Victor Hugo, Povera gente, il film riprende luoghi e tipi umani che ricorrono nel cinema di Guédiguian: Marsiglia e la classe lavoratrice, in particolare quella operaia e portuale. Michel è un uomo di mezza età, più vicino ai sessanta che ai cinquanta, sindacalista in un’azienda del porto di Marsiglia. Lo incontriamo nel momento in cui, per cercare di evitare la chiusura della ditta in cui lavora e trovare un modo equo per ridurre il personale, decide di estrarre a sorte tra i dipendenti i nomi di chi dovrà lasciare il lavoro. Tra quelli che estrae, insieme ai nomi di colleghi di tutte le età, viene fuori anche il suo. Nonostante il ruolo di sindacalista gli permetta di tenersi fuori dal sorteggio, lui non si esime dal condividere questo destino con gli altri sorteggiati. Così, da un momento all’altro, si trova senza lavoro, anche se con la tutela della cassa integrazione, oltre che con la protezione di alcuni indennizzi previsti per un operaio della sua anzianità di servizio. Tuttavia, per lui e per la sua famiglia si tratta di un forte cambiamento anche da un punto di vista economico. Michel non si fa abbattere dalla nuova condizione, anche perché vive un’unione felice con sua moglie, Marie Claire, una donna energica che lavora come badante. Marie Claire ama e stima suo marito, ma è anche capace di parlargli con quella cruda schiettezza che lo aiuta a recuperare l’equilibrio quando in lui si affacciano i pensieri più cupi. • Regia: MAKOTO SHINKAI Maria Grazia e Umberto Bovani,
11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli.
12Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze.
13Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.
14Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
15Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci.
16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.
17Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
18Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te;
19non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni.
20Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
21Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
22Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi.
23Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;
26chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò.
27Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo.
28Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo.
29Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici.
30Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso.
31Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;
32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
In queste parabole, Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona.
In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono»
Papa Francesco, Misericordiae vultus n. 9, 11 aprile 2015).
1Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro".
Il contesto di queste parabole è la comunione di mensa di Gesù con tutti (!) i pubblicani e i peccatori.
Davanti a questo farisei e scribi «mormorano», termine che nel vangelo di Luca, oltre che nel nostro passo, compare altre due volte, sempre a proposito del comportamento di Gesù: quando accetta l'invito al banchetto del pubblicano Levi (5,30) e quando va a casa di Zaccheo, capo dei pubblicani (19,7).
Scribi e farisei, quegli stessi che convivono nel nostro cuore, pensano di onorare Dio separandosi dagli altri uomini e giudicandoli. Gesù invece fa il contrario, mostrando in tal modo una diversa concezione di Dio: ama i peccatori già prima del loro ravvedimento e della loro penitenza. Come sempre è in questione chi è Dio. Per replicare alle mormorazioni, Gesù racconta le tre parabole che parlano di Dio. Solo se si conosce Dio, si comprende il comportamento di Gesù. La prima e fondamentale conversione che ci è offerta consiste dunque nel cambiamento dell'immagine di Dio, è accettare Dio come un padre che ci ama gratuitamente (istruttiva e distruttiva al contempo è la menzogna del serpente in Genesi 3,1-5).
12Il più giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue sostanze.
13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.
14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci.
16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.
17Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati".
20Si alzò e tornò da suo padre […]
30ha divorato le tue sostanze con le prostitute.
Non sappiamo i motivi della richiesta del figlio più giovane, non ci vengono detti. Possiamo forse ipotizzare che una possibile ragione possa essere la sua relazione con il padre (del quale di fatto desidera la morte come si evince dal tipo di richiesta). La presenza del padre può essere avvertita come mortificante e l'allontanamento da quella casa come liberante.
La lontananza dal padre porta però di fatto il figlio minore a vivere relazioni disordinate con gli altri. Nel tempo della baldanza si comporta da padrone (cfr. le prostitute): gli altri sono cose, strumenti, oggetti al suo servizio; nel tempo dell'indigenza si fa schiavo, guardiano di animali immondi (cfr. il pascolare i porci). Non riesce nemmeno a cibarsi delle carrube. Perché non se le prende da sé? Perché ciò che sazia non sono tanto le cose, quanto la relazione con il donatore. Più che le carrube, il giovane sembra cercare una relazione, anche se forse non ne è ancora completamente consapevole.
Ed eccolo allora sulla via del ritorno verso la casa del padre, spinto più dai morsi della fame che da improbabili rimorsi di coscienza. Di fatto, la sua decisione di tornare a casa non è dovuta al desiderio di vedere il padre e di riconciliarsi con suo fratello, bensì alla paura di morire: si è reso conto che nella casa del padre nessuno muore di fame. Certo, lo chiama ‘padre’, ma non considera sé come figlio. Pensa forse che l'alternativa sia diventare come il fratello maggiore?
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;
26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo.
27Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo".
28Egli si indignò, e non voleva entrare […]
29egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici.
30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso".
Questo figlio rappresenta bene i mormoratori del secondo versetto, i presunti giusti. Sono sì dei credenti, ma non conoscono Dio (una situazione apparentemente paradossale, e però comune).
È rimasto a casa, ma non è felice: le sue sembrano le parole di un fallito, che forse invidia la scelta del fratello minore. Non ha mai lasciato la casa, ha sempre lavorato e obbedito al padre. Potremmo anche pensare che non si sbaglia del tutto a reagire a quel modo. Però, anche chi rimane in casa può perdersi... come la moneta della seconda parabola... Il fatto che scribi e farisei siano presenti lì dove è Gesù testimonia che, come il figlio maggiore è rimasto, almeno di fatto, nella casa del padre, così pure, almeno di fatto, scribi e farisei si trovano nella “casa di Gesù”. Ma questo non basta: non basta la semplice presenza (le varie “appartenenze”), occorre una precisa modalità di stare in questa casa.
Anche lui, come suo fratello, vive senza conoscere il padre e senza intendere come si vive in questa casa che non ha mai lasciato. La differenza sta nella reazione: il figlio minore prende le distanze da quella casa, il figlio maggiore cova la propria aggressività, all'esterno non la si nota. E però, appena il servo lo mette al corrente di ciò che è successo, sfoga la propria rabbia, rivelando ciò che porta nel cuore.
Dice al padre che da tanti anni lo serve (v. 29): se si ritiene servo e non figlio, significa che non si sente a casa propria. “Sì, servo il Signore... ma che fatica!”.
Accusa il fratello di aver sperperato le sue sostanze con le prostitute ma, quando rivela che si sarebbe atteso una ricompensa per il suo fedele lavoro – per lo meno un capretto per far festa con i suoi amici – certifica di avere nei confronti del padre lo stesso atteggiamento del minore.
11Ora disse: Un uomo aveva due figli
Il padre è la figura centrale della narrazione. Questo genitore è padre/madre, come se in lui si concentrassero sia l'uomo della prima parabola che la donna della seconda.
E i due figli sono il suo tesoro, il suo vero patrimonio.
12Egli divise tra loro le sue sostanze.
20Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
21Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio".
22Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi.
23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".
E cominciarono a far festa.
Il silenzio del padre alla richiesta del minore ci lascia forse perplessi: non gli interessa ciò che gli chiede suo figlio? Non gli interessa il patrimonio? È un padre debole, che non conta quasi niente e che fa tutto ciò che i suoi figli gli chiedono?
In realtà, come ci mostrerà il seguito della parabola, questo padre non cessa di amare il figlio che si è allontanato. Infatti lo vede tornare quando è ancora lontano: è un padre che non è ripiegato su se stesso, né sul proprio grande dolore. È un padre che guarda fuori di sé, che, dimentico di sé, è attento all'altra persona.
Questi versetti, che per certi aspetti richiamano quelli dell’abbraccio riconciliante fra Giacobbe ed Esaù (cfr. Gen 33,1-4) celebrano l’epifania dell'accoglienza gratuita da parte del padre: egli non sa ancora perché torna questo figlio, cos'ha fatto, con quali intenzioni stia tornando, ecc. Ma sembra che questo non gli importi. Non mette sotto processo il figlio... Lo attende, non per rimproverarlo, ma per una festa.
È un'accoglienza inattesa e piena che dissolve i dubbi che i primi versetti della parabola lasciavano sulla identità del padre. Un’accoglienza totale che non esige né pentimenti né propositi. A questo padre non interessa il passato del figlio: interessa il futuro. Nessuna rimostranza, nessun rimprovero, ma solo molta commozione e una gioia incontenibile. Il figlio tornato deve subito capire che nulla è cambiato: è ancora figlio, come sempre, e quella casa è rimasta la sua. È questo il volto del vero Dio che Gesù rivela.
Sostiamo a lungo contemplando con gli occhi e con il cuore questa scena. Certamente ne ricaveremo frutto.
28Suo padre allora uscì a supplicarlo […]
31Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;
32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"".
Lo stesso amore che lo ha spinto a correre incontro al figlio minore, spinge ora il padre a uscire e a pregare il figlio maggiore. Vorrebbe che entrambi scoprissero la sua paternità e la loro fraternità, ovvero il segreto e il senso della vita.
• Quale immagine ho di Dio nel profondo del mio cuore: come colui che io offendo o come colui che mi cerca?
Come il libro di Giona (un profeta, degno antenato del fratello maggiore del nostro brano), così anche questa parabola rimane senza il finale. Forza e, al contempo, “debolezza” dell'amore del padre: amore che, proprio in quanto tale, non può mai venire impedito ma che non può essere nemmeno imposto, ma solo proposto, offerto con verità e profondo rispetto. Un tale amore attende una libera risposta.
Perché il narratore (Gesù) ci racconta una storia senza finale? Forse perché noi entriamo e prendiamo posto in essa. Non dimentichiamo il contesto in cui viene narrata la parabola.
Come si concluderà la storia?
Tornerà nella casa il fratello maggiore, sedendosi alla stessa mensa con il più giovane?
Si siederanno a tavola gli scribi e i farisei, insieme con i pubblicani e i peccatori, e con Gesù?
E noi? … E io?
«Ogni giorno la comunità cristiana canta: “Ho ricevuto misericordia”.
Ho avuto questo dono anche quando ho chiuso il mio cuore a Dio; quando ho intrapreso la via del peccato; quando ho amato le mie colpe più di Lui; quando ho incontrato miseria e sofferenza in cambio di quello che ho commesso; quando mi sono smarrito e non ho trovato la via del ritorno. Allora è stata la parola del Signore a venirmi incontro. Allora ho capito: egli mi ama. Gesù mi ha trovato: mi è stato vicino, soltanto Lui. Mi ha dato conforto, ha perdonato tutti i miei errori e non mi ha incolpato del male. Quando ero suo nemico e non rispettavo i suoi comandamenti, mi ha trattato come un amico. Quando gli ho fatto del male, mi ha ricambiato solo con il bene. Non mi ha condannato per i misfatti compiuti, ma mi ha cercato incessantemente e senza rancore. Ha sofferto per me ed è morto per me. Ha sopportato tutto per me. Mi ha vinto. Il Padre ha ritrovato suo figlio. Pensiamo a tutto questo quando intoniamo quel canto. Fatico a comprendere perché il Signore mi ami così, perché io gli sia così caro.
Non posso capire come egli sia riuscito e abbia voluto vincere il mio cuore con il suo amore, posso soltanto dire: “Ho ricevuto misericordia”» (D. Bonhoeffer, scritto del 23 gennaio 1938).
Una riflessione
e guardare nella immobilità
sovrana la bellezza di una parete
dove il filo della luce e la lampada
esistono da sempre
a garantire la loro permanenza.
Montagna di luce ventaglio,
paesaggi paesaggi! come potrò
sciogliere i miei piedi, come
discendere – regina delle rupi
e degli abissi – al passo involontario,
alla mano che apre una porta, alla voce
che chiede dove andrò a mangiare? Un’immagine

Marc Chagall | Il figliol prodigo ,1975, Saint Paul de Vence, Collezione Privata
A questo evento tutti sono chiamati ad assistere, gli uomini e le donne del paese, le madri con i loro figli perché vedano il realizzarsi di un amore possibile. Anche il pittore stesso si rappresenta mentre dipinge la scena sulla tela per lasciarne testimonianza.
Così pure partecipano i due sposi raffigurati alle spalle del figlio e loro stessi sperimentano la forza riconciliatrice dell’abbraccio; imitandone il gesto, è come se ci dicessero che quando ci si sente amati, perdonati, abbracciati, si è capaci di fare altrettanto con libertà di spirito e forza interiore, senza paralizzanti timori o fuorvianti rivendicazioni.Entro nel quadro:
Come mi sento? Quale sentimento prevalente mi abita? Rimango qualche minuto in quell’abbraccio senza forzare pensieri né ricordi. Semplicemente sto lì.Un film

Robert Guédiguian | Le nevi del Kilimangiaro | 2011
Per festeggiare i trent’anni del loro matrimonio, i figli, i colleghi e gli amici di Michel e Marie Claire organizzano una festa nei locali dell’ex azienda di Michel. Con una colletta riescono a regalare ai festeggiati un biglietto per una vacanza nella terra dei Masai, in Africa, oltre che una somma congrua per sostenere le spese del viaggio. Poco tempo dopo, due rapinatori mascherati irrompono in casa di Michel e Marie Claire e li derubano, in modo brutale, di tutti soldi regalati, dei biglietti per l’Africa e di altro. Michel è stravolto per la rapina subita e cerca subito giustizia denunciando alla polizia quanto capitato. Ma rimane ancora più sconvolto quando si rende conto che uno dei due rapinatori è un giovane operaio, Christophe, suo ex collega, licenziato come lui, dopo che il suo nome è stato estratto insieme a quello di Michel. Preso dall’impulso di fargliela pagare, Michel denuncia alla polizia Christophe che, una volta arrestato, ammette subito il suo crimine. Eppure, dopo un confronto diretto e molto duro con il ragazzo, Michel si rende conto di non poter essere d’accordo con la logica del tribunale. Nel confronto tra i due emergono le differenze che separano le due generazioni: la precarizzazione del lavoro giovanile, il dramma di una disoccupazione senza protezioni, le diverse tutele sociali che, agli occhi di Christophe, fanno apparire Michel come un privilegiato. Il ragazzo ha usato il denaro rubato per pagare l’affitto di una squallida casa popolare nella quale si occupa anche dei suoi due fratellini più piccoli abbandonati dai genitori. Michel vorrebbe ritirare la denuncia ma ormai è troppo tardi: la macchina della giustizia si è mesa in moto e non può più essere fermata.
Michel e Marie Claire sono due figure semplici, abitano in una casa modesta ma sono anche persone solide e hanno un potere speciale che li rende (quasi) invincibili: si amano. Entrambi sono consapevoli del contesto sociale in cui vivono, sempre più in crisi, e, benché abbiano guadagnato con il sudore della fronte ogni piccolo vantaggio su cui adesso possono contare (una casa di proprietà, alcune garanzie sociali, una macchina, due figli sani e più che alfabetizzati, tre splendidi nipoti), sentono di essere privilegiati rispetto a chi si trova in una situazione come quella di Christophe. In pratica, moglie e marito non hanno smarrito la coscienza di classe e il senso di solidarietà che ne deriva.
Senza che l’uno sappia dell’altra e viceversa, Michel e Marie Claire cominciano a prendersi cura dei due ragazzini abbandonati a loro stessi dopo l’arresto di Christophe. Marie Claire va a casa loro per aiutarli nei compiti, per fare lavatrici e preparare qualcosa da mangiare; Michel decide di farsi rimborsare i due biglietti per l’Africa (trovati dalla polizia nella refurtiva) e usare quel denaro per aiutare i due bambini. A un certo punto si scopriranno l’un l’altra presi da questo impegno segreto, e prenderanno una decisione osteggiata da tutti, soprattutto dai loro figli: farsi affidare i due fratellini, ospitarli in casa loro, nell’attesa che Christophe sconti la pena ed esca di prigione.
C’è un centro d’amore profondo e condiviso che unisce Michel e Marie Claire, una visione del mondo che si fonda su un forte senso di giustizia. Per questo si scoprono, senza troppo clamore e senza troppa sorpresa, entrambi dalla stessa parte. Il cuore del loro gesto è lì, nell’amore di queste due persone umili e giuste, la cui coscienza dona a loro una vista più larga, un quadro più ampio, dove la miseria nella quale si trova chi è più fragile può essere un reato più grave del furto che, di quella miseria, è solo una conseguenza. Il tema della scelta in questa storia diventa la possibilità, per i due coniugi e compagni di vita, di non farsi travolgere dai fatti, per quanto siano dolorosi e imprevedibili, ma di rispondere a essi senza rinunciare alle proprie convinzioni profonde, quelle sulle quali si è edificata un’esistenza degna, soprattutto quando quelle convinzioni sembrano andare contro il senso comune. LE NEVI DEL KILIMANGIARO (Les Neiges du Kilimandjaro)
• Paese: Francia
• Anno: 2011
• Durata: 90 min
• Genere: drammatico
• Regia: Robert Guédiguian
• Interpreti: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Maryline Canto
• Visibile su: https://miocinema.com/le-nevi-del-kilimangiaro
A cura di
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
«Ora non per lussuria
io prendo questa mia parente,
ma con animo retto»
(Tobia 8,7)
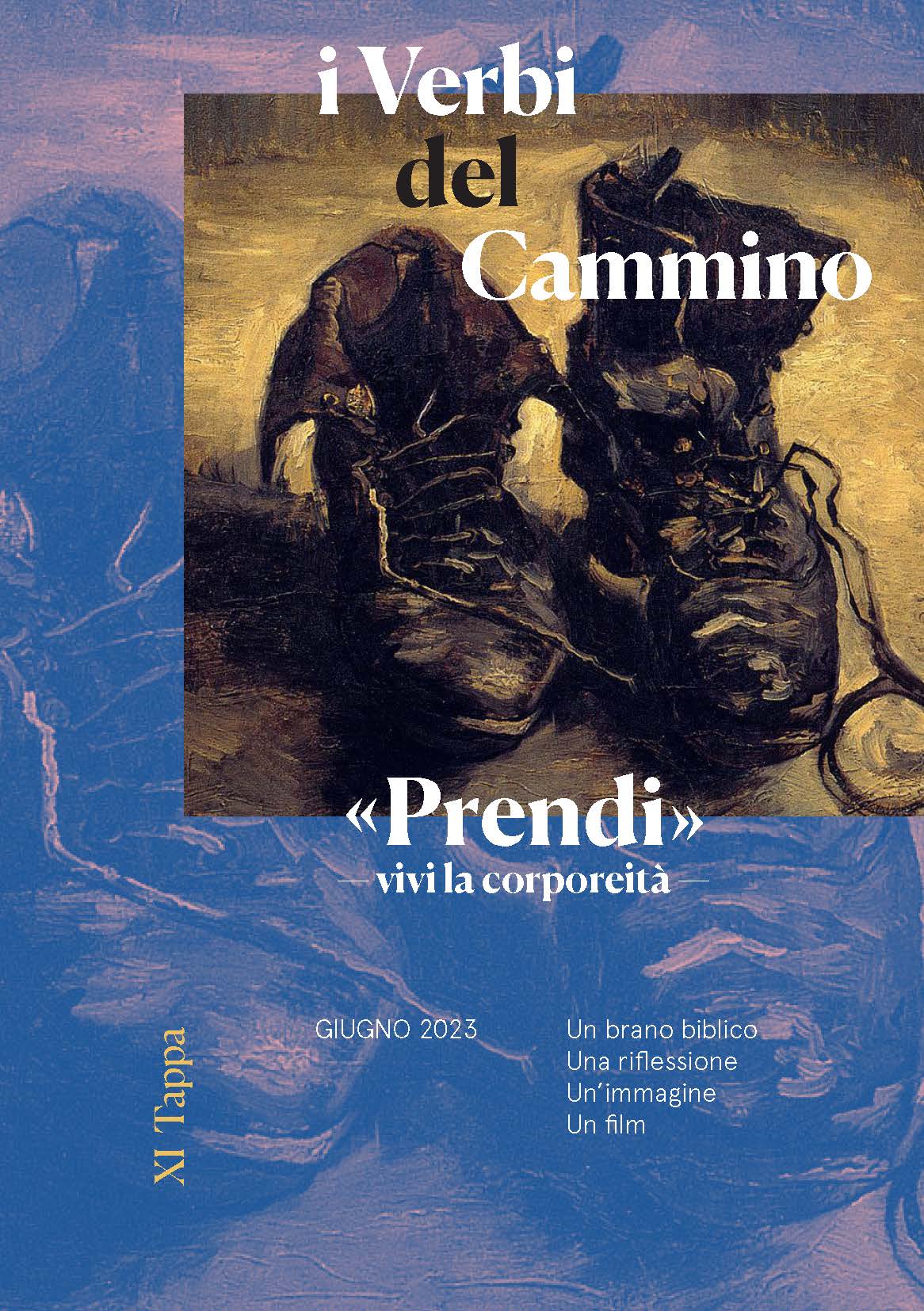
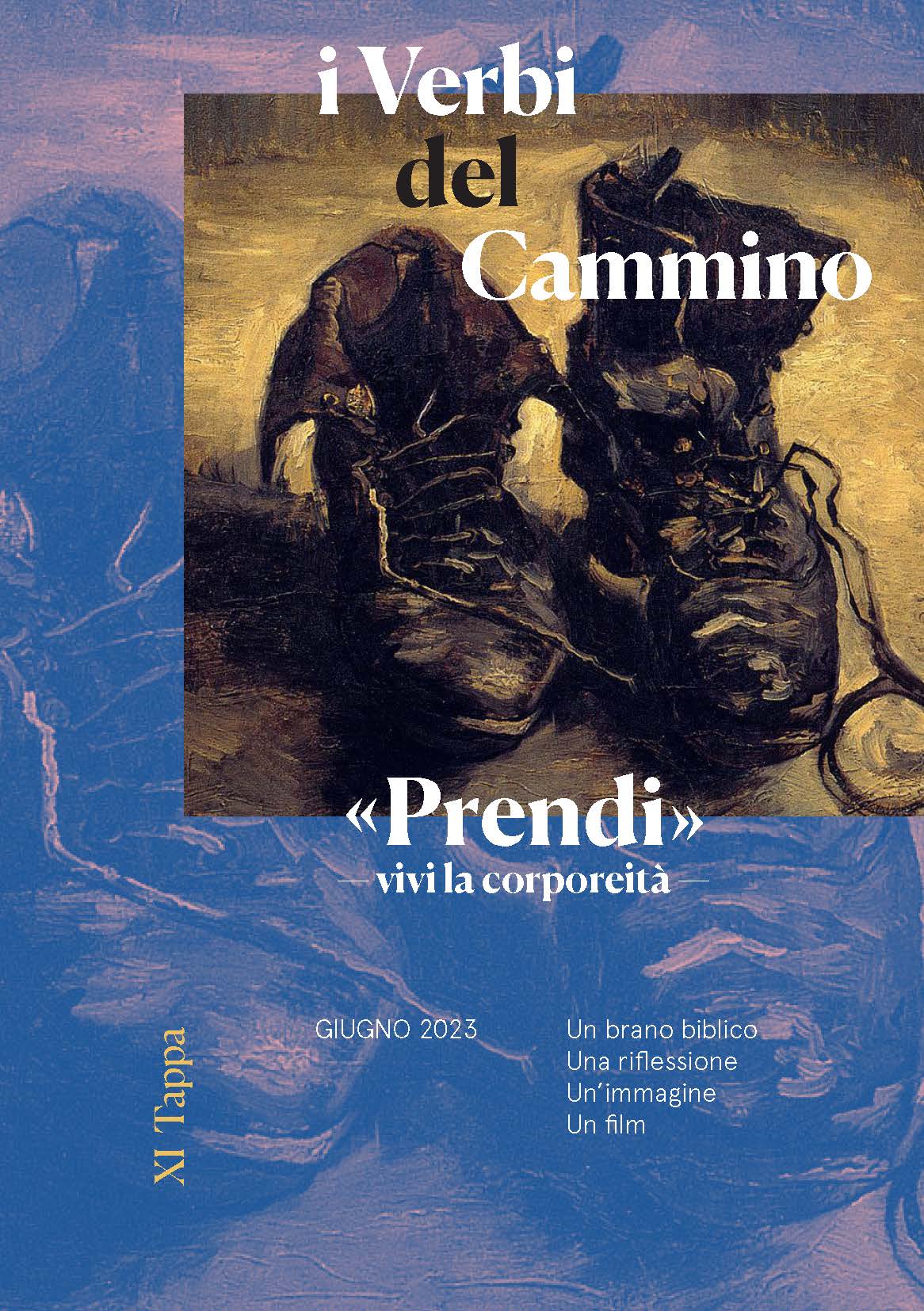
«Ora non per lussuria
io prendo questa mia parente,
ma con animo retto»
(Tobia 8,7)
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
«Prese… Prendete»
Marco 14,22-24
22 Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo". 23 Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti."
Come vedete, il brano è molto breve, solo tre versetti. Eppure si potrebbe dire che tutte le Scritture portano a questi tre versetti, loro vero centro, e ne sono di fatto il commento.
Nel cuore della sua Passione, Gesù si dona. Senza i racconti del Cenacolo e del Getsemani noi, nella narrazione della Passione di Gesù, contempleremmo la fine, l’ennesima tragica fine di un giusto che paga a prezzo della propria vita il male altrui.
Ma son proprio questi racconti a farci entrare nel cuore di Gesù e a comprendere, per quanto ci è possibile, che quello che contempliamo è innanzitutto il dono di sé che Gesù compie amandoci: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13); «Nessuno me la [la mia vita] toglie: io la do da me stesso» (Gv 10,18).
22 Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo".
Nel Vangelo abbiamo incontrato fino a questo punto tanti e diversi doni del Signore: guarigioni, ecc., tanti segni in cui abbiamo riconosciuto la sua bontà all’opera. Esperienza che facciamo tutti quando accogliamo il dono che qualcuno ci fa è che quel dono ci rimanda al donatore e fortifica la relazione con lui.
Adesso però è il donatore stesso che si consegna, che si dona nelle nostre mani.
«Il primo punto: richiamare alla memoria i benefici ricevuti nella creazione e nella redenzione e i doni particolari; ponderando con molto affetto quanto ha fatto Dio nostro Signore per me, e quanto mi ha dato di quello che ha; quindi di conseguenza il medesimo Signore desidera darsi a me, in quanto può, secondo il suo disegno divino» (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 234).
In questo versetto del vangelo di Marco il verbo prendere compare due volte.
Nella prima descrive ciò che Gesù fa, ‘prendendo’ appunto il pane nelle sue mani. In questo modo Gesù accoglie la propria vita, accoglie sé stesso come dono. Infatti, prende benedicendo. Questo non è scontato, anzi.
Il capitolo terzo del libro della Genesi, il brano 14delle origini e della caduta, ci rivela che con gli stessi verbi (prendere, mangiare, dare) si può impostare una vita assai lontana da quella autentica di figli e figlie che tutto ricevono e tutto donano. Adamo ed Eva non accolgono la loro verità di figli, si pongono come origine della propria vita, e da questo avranno luogo i loro fallimenti personali e relazionali.
Nella sua seconda apparizione in questo versetto, il verbo prendere descrive ciò che Gesù chiede ai suoi di fare: cioè accogliere, prendere nelle nostre mani Lui stesso, vero pane di vita, e nutrirci, vivere di Lui.
È il corpo di Gesù che siamo chiamati ad accogliere come nostro cibo, realizzando quella particolare ‘assimilazione’ che, invece di trasformare quanto mangiamo in noi stessi, trasforma noi stessi nel cibo che mangiamo.
Ricordo che tanti anni fa, al termine della celebrazione eucaristica domenicale, accompagnata dai suoi genitori, mi raggiungeva in sacrestia una bambina, di nome Martina, chiedendomi di darle una particola non consacrata. Un giorno, forse preoccupato che la bambina, che non aveva ancora fatto la Prima Comunione, comprendesse esattamente le cose, e la diversità delle cose, mi misi a spiegarle il senso di quel gesto. Non dovevo riuscire molto bene nel mio intento, al punto che la bambina, forse mossa a compassione verso quel povero sacerdote, mi fece cenno di fermarmi e mi disse (testuali parole): «Guarda che lo so. Adesso, quando mangio questo pezzo di pane, questo pezzo di pane diventa Martina. Quando farò la Prima Comunione e prenderò quel pezzo di pane, Martina diventa Gesù».
Siamo così chiamati a entrare nel circolo dell’amore divino che è il circolo stesso della vera vita: accogliere e ridonare. Non è forse questo che sta anche alla base del Sume et suscipe, la preghiera che Sant’Ignazio di Loyola pone in prossimità della conclusione dell’itinerario degli Esercizi spirituali: «Prendi, Signore e ricevi tutta la mia libertà … dammi il tuo amore e la tua grazia …» (n. 234)?
Nel corpo di Gesù si realizza il Regno di Dio in mezzo a noi: «Tutte le promesse di Dio in lui sono "sì"» (2Cor 1,20).
Chi attende questo regno, come Giuseppe di Arimatea, otterrà il corpo di Gesù: «Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch'egli il Regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù» (Mc 15,43).
Tutto quello che Dio ha promesso all’uomo è il corpo del Figlio, il Figlio che ha dato se stesso per noi. Il corpo del Figlio è il Regno di Dio, è Dio stesso che si dona nelle mani dell’uomo: abbiamo nelle mani Dio, il suo corpo dato per noi.
«Entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 6 Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 7 Allora ho detto: "Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà".
8 Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la Legge, 9 soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 10 Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre» (Eb 10,5-10).
In un certo senso è sul corpo di Gesù, il quale ha offerto se stesso senza macchia a Dio (cf. Eb 9,13), che noi possiamo leggere in maniera piena e definitiva l’amore di Dio per noi: la Sua e la nostra verità. È dai segni del suo amore per noi che Lo riconosciamo e che conosciamo quanto siamo amati: « 37 Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 38 Ma egli disse loro: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho". 40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi» (Lc 24,37-40).
I segni dei chiodi, che testimoniano il nostro male, diventano sul corpo di Gesù i segni del Suo amore per noi, indelebili come indelebile è il Suo amore. Gesù infatti – ci fa pregare la liturgia della Chiesa - «con i segni della passione vive immortale» (Prefazio pasquale III).
23 Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti.
Come il profumo della donna di Betania, nel brano raccontato appena prima (14,1-11) e che ha molti punti di contatto con il nostro brano - nella struttura e nel contenuto - il dono di Gesù raggiunge tutti, non esclude nessuno.
Del resto i versetti che immediatamente lo precedono (18-21) narrano la predizione del tradimento di Giuda mentre quelli che immediatamente lo seguono (26-31) raccontano l’annuncio del rinnegamento di Pietro.
Quale modo migliore per mostrarci la piena gratuità del gesto di Gesù? Un gesto che non chiede di essere subito compreso, né tantomeno meritato: l’amore non lo si merita, lo si accoglie.
«Il corpo di Cristo».
«Amen».
Torna sovente e prendimi,
torna e prendimi amata sensazione –
quando il ricordo del corpo si ridesta
e trascorre nel sangue il desiderio antico;
quando labbra e pelle rammentano,
e alle mani pare di nuovo di toccare.
Torna sovente e prendimi, la notte,
quando labbra e pelle rammentano…
Costantino Kavafis (1863-1933)
Costantino Kavafis (1863-1933) Grande poeta greco è considerato uno delle grandi colonne della poesia contemporanea.
Personalmente non è un poeta che prediligo, trovo nella sua poesia un senso di lontananza dalle cose che a volte mi indispettisce. Detto questo rimane un grandissimo poeta e poi il mio parere è quello del semplice lettore occasionale dei suoi 153 componimenti lirici.
Questa poesia, una di quelle di Kavafis che trovo più suggestiva, mi è venuta alla mente pensando al nostro verbo Prendi. La trovo appropriata in questo accostamento tra passato trascorso e presente della memoria.
Come un senso di malinconia instabile che trova nel ricordo del desiderio il senso dell’immanenza di un corpo. Tutto in un barlume di presenza sfocata, instabile, precaria e malsicura.
Non è tanto l’atto che fa la differenza ma la percezione di una amata sensazione che segna profondamente la carne e la scuote dall’intero. Prendi e restituisci, incorpora e conserva, custodisci ma insieme mantieni vivo “il suon di lei…”.
Quanta nostalgia, quanti struggimenti in questi versi. Quanta mancanza di un approdo sicuro che permetta un riconoscimento che stabilizzi, che orienti e definisca. Tutto questo non fa parte proprio dell’orizzonte di Kavafis. A lui piace la sommarietà, ciò che rimane nell’incertezza di qualcosa che è, ma potrebbe anche non essere e in questo Kavafis è maestro, ci spiazza e poi ci lascia in sospeso, come su un precipizio.
Ma Prendi è un verbo attivo, molto att ivo. Ha una sua “morale”, per questo lo percepiamo attivo e visibile. Un invito e insieme qualcosa di più di un invito.
Certamente viene immediatamente alla mente un’azione voluta ed attesa, quasi un affronto per assumere una consapevolezza che non abbiamo. Un invito che suona come una sfida: “prendi atto di questa cosa…” Dico questo perché il verbo prendere nella sua affermazione imperativa contiene in sé una severa legge di mercato. Qualcuno impone ad altri regole che vorrebbero (o dovrebbero) essere condivise ma che spesso non sono condivise affatto (e su questo Kavafis ci va a nozze!!!).
Prendere non accetta obiezioni e la gentilezza sembra lasciata fuori dalla porta. Ma qui è consentito un cambio di rotta, quel mutare di prospettiva che avviene solo nella possibile prospettiva evangelica.
Prendere non può che essere regolato dalla legge dell’amore che è misura e compimento. La carnalità dell’amore definisce ed orienta.
Prendimi affinché non mi smarrisca, prendimi perché le strade sono insidiose e io ho bisogno di te.
Prendimi perché insieme ci sarà concesso di vedere quello che, per Grazia della carne, ci apparirà come sfolgorante promessa, finalmente senza mezze misure.
Un appagamento pieno e vivo.
Non saprei bene, dentro il tuo abbraccio, come muovermi
ed è un tentativo, anche un po’ goffo,
quello di liberarmi dalle tue invadenze.
Qualcosa che fatico a riconoscere mi immobilizza, mi paralizza.
e vorrei andare oltre, oltre le cose di sempre
aprire varchi infiniti dove la gravità sia solo un antico ricordo
Ma quell’abbraccio, anche appena accennato, mi riporta alla realtà delle cose
alla loro semplicità, alla loro consistenza e dopo tutto ne sento una malinconica nostalgia
Sento ogni cosa familiare, vicina, come un qualcosa di già noto, anche se dimenticato.
Prendo le tue mani e capisco che forse non ho bisogno di altro.

Ci lasciamo ispirare ancora una volta da Chagall, il pittore che più di ogni altro ha rappresentato l’amore raffigurando in molteplici suoi quadri la vicinanza fisica e spirituale tra l’uomo e la donna.
Qui la composizione è piuttosto semplice, con pochi ma significativi elementi: in primo piano, così tanto che se ne vede solo una parte, c’è un letto nuziale con il cuscino poggiato allo schienale; al suo fianco, al centro, una sfera rossa in cui sono rappresentati un uomo e una donna in un intimo abbandono l’una appoggiata all’altro. Un ovale rosso d’amore che richiama quasi ad un cammeo, come una spilla preziosa che si porta al petto per identificare il potere e l'appartenenza ad una famiglia, ma anche per conservare ricordi importanti di volti e momenti cari.
Alla sua destra appare una donna che cerca di sporgersi oltre un’inferriata e con la mano cerca di afferrare quel nucleo, anche se con la testa guarda dalla parte opposta, verso l’interno della stanza in cui si trova che appare buia, illuminata solo da un candelabro
La metà superiore del quadro è riempita dal volo di un grande uccello blu che con le ali spiegate si dirige verso un ramo fiorito, i cui colori ed il cui profumo già si compenetrano con le sue piume.
Ad illuminare la scena, il calore giallo del sole che si irraggia dietro ogni elemento, simbolo della presenza di Dio che avvolge e benedice ogni manifestazione di vita.
Con questa semplice descrizione forse ci viene suggerita un’immagine che esprime il desiderio, che in fondo abita in ciascuno di noi, di andare oltre le proprie paure, oltre quelle resistenze che ci tengono immobilizzati dentro castelli dorati che ci costruiamo con le nostre stesse mani, in cui pian piano cala il buio e neanche ce ne accorgiamo.
Il desiderio di uscire da sé per accogliere e sentirsi accolti nella corporeità di un abbraccio, perché è con il nostro corpo che innanzitutto esprimiamo quanto siamo disposti ad incontrare e lasciarci incontrare.
Eppure a volte anche quando arriva la luce delle candele, simbolo di una presenza che invita ad uscire da sé e aprirsi all’amore, a rischiarare e rendere visibile ciò che quasi non vediamo più e avevamo dimenticato, anche allora siamo ancora tentati di guardare indietro alla sicurezza di quell’anfratto che tutto sommato ci ospitava senza metterci troppo in discussione.
Ma come non percepire che uscire dalla sicurezza delle sbarre porta a prendere il volo verso un orizzonte impregnato dei colori e del profumo dei fiori?
Non tutti sono belli e colorati, è vero, ma vale la pena orientarsi verso di essi perché già solo scegliere di farlo ci rende più liberi.
Parto dal gesto di abbraccio. Verso chi in questo tempo della mia vita sento che dovrei essere più accogliente? Come posso esprimere attraverso una corporeità tangibile che l’altro ha spazio? Guardo alla stanza dietro le sbarre: quale fatica colgo che più di altre mi fa venire la tentazione di stare dove sono e non andare ad incontrare l’abbraccio dell’altro?
Guardo le ali dell’uccello in volo e provo a chiudere gli occhi per sentire il profumo dei fiori verso cui vola. Il colore dell’uccello è lo stesso che abita la stanza. Come posso trasformare quel mio elemento di chiusura in un volo liberante? Come mi sento percependo di andare verso la corporeità di un abbraccio abbandonandomi ad un incontro che mi chiama ad uscire da me?
Dopo un tempo di silenzio, affido nella preghiera quanto è emerso.

Mitsuha è una ragazza di 17 anni che vive in un piccolo villaggio di una zona rurale del Giappone odierno.
Abita in un tempio shintoista con la sorella minore e con la nonna, che è una sacerdotessa. Il padre, dopo aver perso la moglie qualche anno prima, ha lasciato le due figlie con la suocera, per dedicarsi alla politica e diventare il sindaco del villaggio.
L’uomo non ha molta considerazione per le figlie, soprattutto in quanto femmine.
Mitsuha non sopporta più la vita di paese né gli obblighi che le competono come nipote della sacerdotessa. Una sera, dopo aver celebrato un rito shintoista davanti alle compagne di scuola che la prendono in giro, urla al cielo il suo desiderio di essere, in un’altra vita, un ragazzo di Tokyo.
Di notte, mentre dorme, il suo desiderio viene esaudito: il mattino dopo si risveglia nel corpo di un ragazzo coetaneo, Taki, che vive nella capitale. Nello stesso momento, Taki si sveglia nel corpo di Mitsuha.
Il risveglio nel corpo di un/a coetaneo/a va oltre la più immediata curiosità delle particolarità anatomiche che reciprocamente destano meraviglia e imbarazzo: per Mitsuha riguarda anche la complessità e la frenesia di un contesto urbano come quello di Tokyo, che per lei è un luogo da ammirare ma nel quale anche smarrirsi; mentre per Taki, ragazzo di città, consiste nell’immersione in un mondo paesano dove sono ancora vivi sia il contatto con il sacro sia quello con le dimensioni sovrannaturali.
I due ragazzi, una nel corpo dell’altro e viceversa, devono oltretutto confrontarsi con i cliché collegati al loro genere apparente, oltre che con i diversi contesti sociali e culturali.
La storia di YOUR NAME ci fa capire l’importanza, per un ragazzo, di entrare in contatto con la parte “femminile” di sé; così come ci mostra quanto può essere liberatorio, per una ragazza, lasciar emergere la componente “virile” del proprio carattere, soprattutto quando è il proprio genere a metterla in difficoltà con le figure maschili che ha intorno, a partire da quella del padre.
All’inizio di questo scambio, i due ragazzi credono di vivere solo un sogno molto intenso.
Quando prendono consapevolezza di quello che sta succedendo e si rendono conto che quella nella quale agiscono è la realtà, con tutte le conseguenze che questo comporta nel momento in cui rientrano in possesso dei propri corpi, decidono di collaborare.
Per farlo, comunicano tra loro lasciandosi reciprocamente messaggi scritti sulla pelle o sui rispettivi telefoni. Sperano così di evitare le conseguenze più fastidiose della loro vicendevole sostituzione.
Gli scambi tra loro continuano per un po’ di tempo, fino a quando si interrompono bruscamente, complice una cometa che fa il suo passaggio millenario sui cieli del Giappone e che segna con la sua scia un cambiamento drastico per entrambi i ragazzi.
Finché dura, la fusione di un’anima nel corpo dell’altro/a crea in ognuno di loro una consapevolezza aumentata, avvia un doppio viaggio, nello spazio e nel tempo, e l’ingresso in un’altra dimensione.
In una splendida armonia di suoni e di colori, questo viaggio ai limiti dei corpi e delle identità racconta una storia di salvezza che passa attraverso il sacrificio di ciò che si ha di più caro, come il ricordo del nome più amato.
Il titolo infatti fa riferimento al desiderio terribile dei due ragazzi di ricordare il nome dell’altro/a che, finite le sostituzioni, svanisce dalla memoria di entrambi.
Uno dei temi del film è sicuramente la nostalgia (Taki si reca con un’amica in un museo di Tokyo a vedere un’esposizione dedicata a questa categoria dello spirito e della cultura).
E forse si vuole suggerire che, come nel mito platonico, la nostalgia più grande e anche quella di cui si è più inconsapevoli, riguarda quell’unità originaria tra maschile e femminile che si è perduta nella notte dei tempi.
“Sono sempre alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Questa sensazione si è impossessata di me” ripete più volte Taki a sé stesso nel corso del film. La nostalgia di un’unione perduta – come la racconta Platone – che spinge uomini e donne a unirsi per cercare di ricreare quell’unità che si è spezzata in un tempo talmente remoto da averne perduto anche il ricordo.
A un certo punto, quella scissione sembra riecheggiare anche nei frammenti sparsi dalla cometa quando passa nel cielo sopra ai due ragazzi: un corpo unico che si frantuma.
La storia raccontata da YOUR NAME, quindi, sembra rimandare al racconto di un mito, più che a una fiaba. Il capolavoro di Makoto Shinkai (tale è considerato fino a oggi rispetto agli altri titoli dell’autore) è una storia potente che, come avviene con i miti contemporanei, è stata raccontata con grande successo di pubblico e di critica in forme diverse: romanzo, fumetto, cinema. È il mito di una ragazza e di un ragazzo che si cercano, come frammenti di una cometa spezzata, e vogliono ricongiungersi dopo essersi allontanati.
• Regia: MAKOTO SHINKAI
• Genere: animazione, fantastico, sentimentale, drammatico
• Anno: 2016
• Paese: GIAPPONE
• Durata: 107 min.
• Disponibile su: Netflix, Amazon Prime Video, VVVVID, CHILI, Google Play, ITunes.
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
«… facciamogli un aiuto
simile a lui …»
(Tobia 8,6)
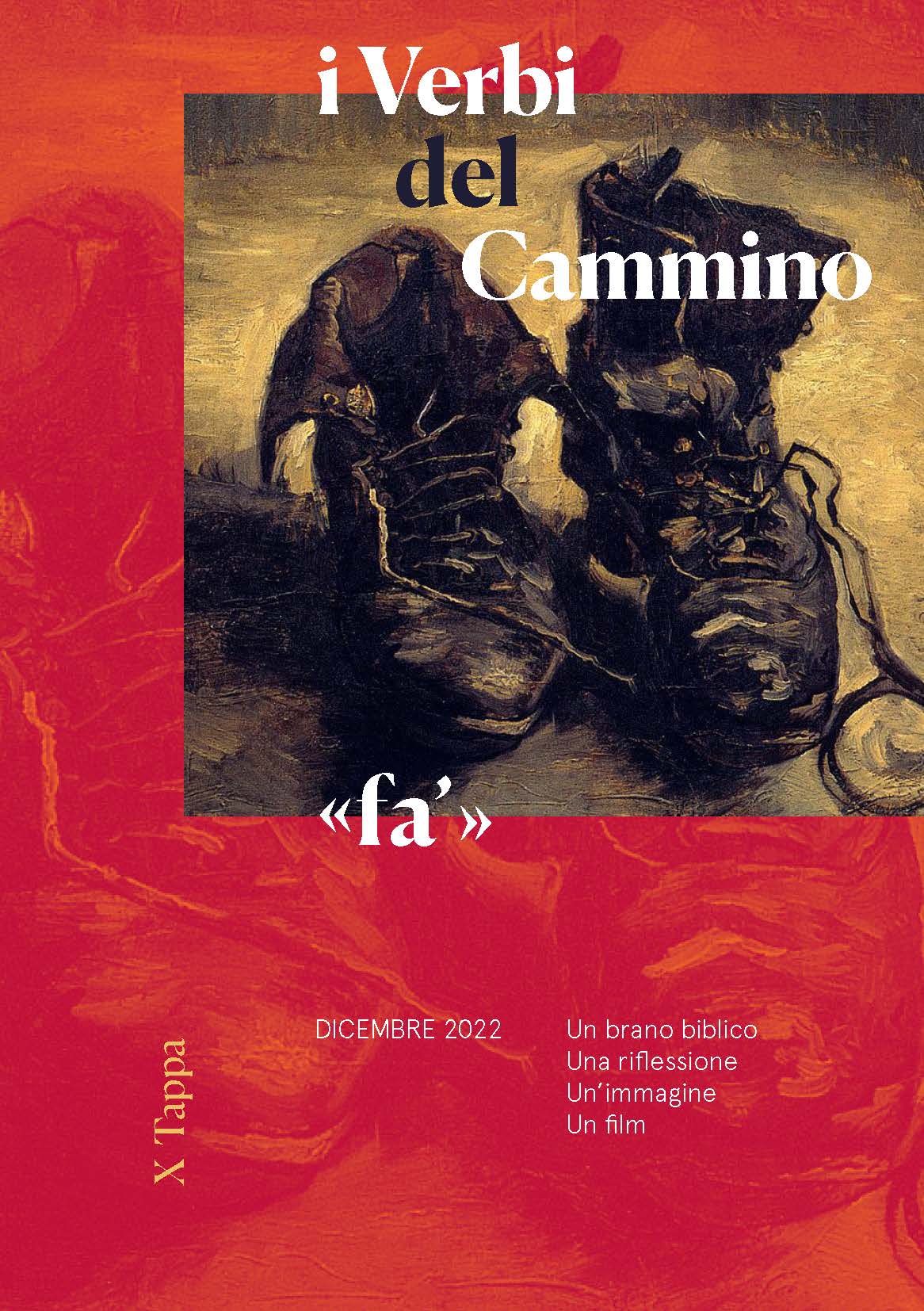
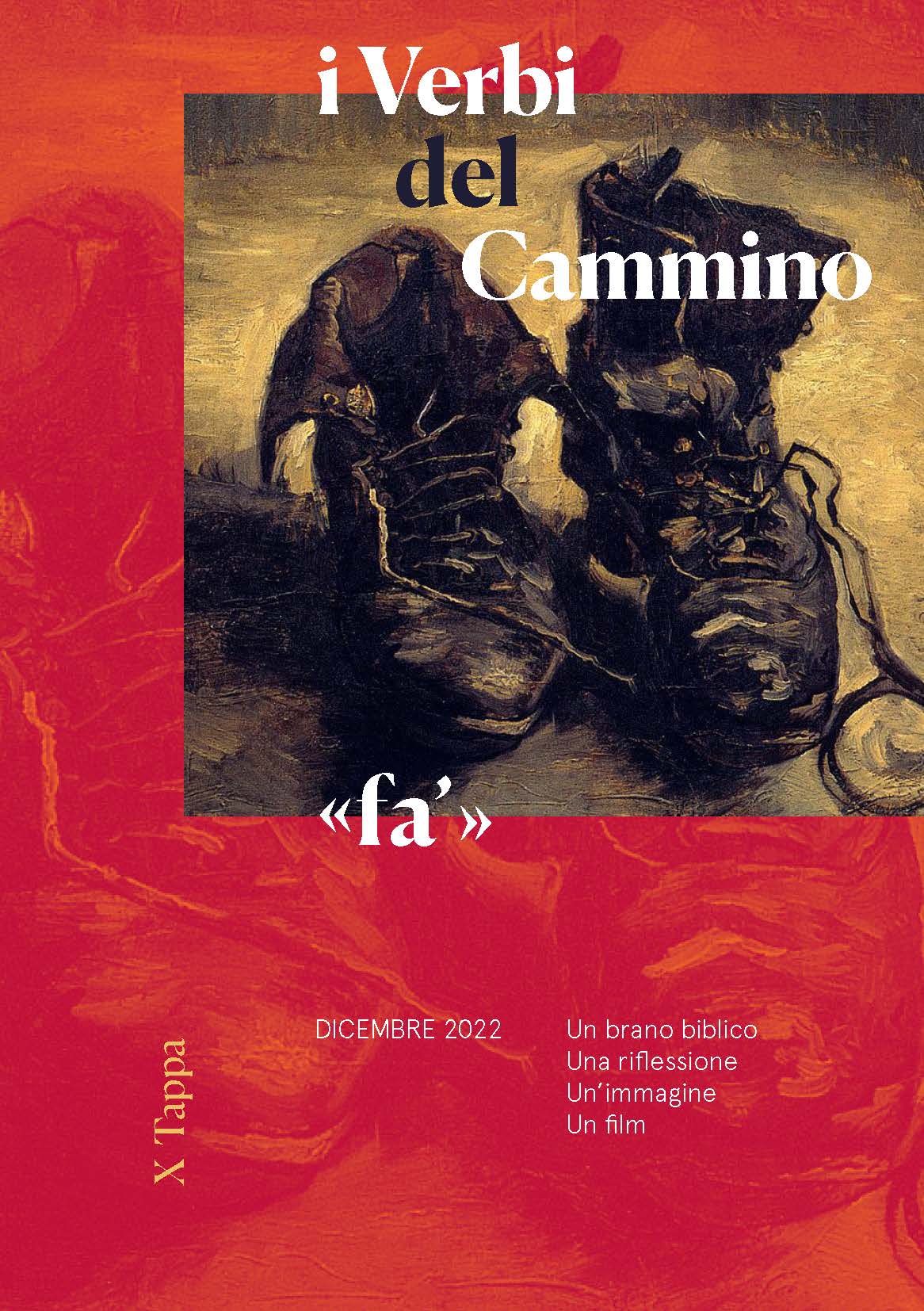
«… facciamogli un aiuto
simile a lui …»
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
«QUELLO CHE HA FATTO»: elogio dello “spreco”
Marco 14,1-9
1Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. 2Dicevano infatti: “Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo”.
3Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. 4Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: “Perché questo spreco di profumo? 5 Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!”. Ed erano infuriati contro di lei.
6Allora Gesù disse: “Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un’azione buona verso di me. 7 I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. 8 Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9 In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto”.
Se il protagonista dell’episodio evangelico della tappa precedente (Di’) era stato il centurione che non entrava mai direttamente in scena, protagonista dell’episodio di questa tappa (Fa’) è una donna anonima che non dice una sola parola ma che entra in scena e compie un gesto (fa!) in cui si esprime tutto il senso della sua vita.
Potremmo definire il gesto di questa donna come un quadro di luce (vv. 3-9) inserito in una cornice di buio (vv. 1-2; 10-11).
1Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. 2 Dicevano infatti: “Non durante la festa,perché non vi sia una rivolta del popolo”. / Il contesto del brano è la Passione di Gesù. Si sottolinea l’incomprensione e l’opposizione nei confronti di Gesù da parte dei capi dei sacerdoti e degli scribi, di coloro cioè che dovrebbero vantare una familiarità con Dio e una maggior conoscenza di Lui.
3Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. / Dopo le coordinate temporali, quelle spaziali: ci troviamo a Betània (cfr. 11,1.11.12), in una casa. Siamo a tavola. Gesù è già nella casa. Una donna vi giunge. E vi giunge con un vasetto di profumo. Questa donna fa tutt’uno con il suo vasetto di profumo, profumo di nardo come quello della sposa del Cantico dei cantici (1,12). Il profumo è qualcosa che non si vede ma si sente. Non si vede ma se ne avverte la presenza. Non si vede: contro tutti i nostri sforzi di apparire, di essere visti e riconosciuti.
È proprio del profumo donarsi, come Dio, il cui nome, dice il Cantico dei cantici, è infatti «aroma che si spande» (1,3). E, come sempre, è il dono che conta: l’olio comperato (!) non servirà (cfr. Mc 16,1). Il gesto della donna riassume un’intera esistenza. Ed è un gesto che non si improvvisa.
La donna non si limita a versare il profumo su Gesù: rompe il vaso. Il dono non può essere ripreso, è fatto senza riserve. Viene in tal modo compiuto un gesto di gratuità. E sono i gesti che fanno vivere e rivivere continuamente. L’amore non si merita, si accoglie: oltre i diritti, oltre il dovuto, oltre il merito.
4Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: “Perché questo spreco di profumo? 5 Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!”. Ed erano infuriati contro di lei. / Alcuni provano disagio davanti a tanto amore. Per Giovanni sarà Giuda (12,4), per Matteo i discepoli (26,8). Insomma, ci siamo dentro tutti …
Sono persone irritate in sé stesse. Come quasi sempre accade, il male che facciamo ha in noi la
sorgente. Il dono a fondo perduto di questa donna viene letto dai presenti come uno spreco. Quando uno vuole bene può conoscere la paura di perdersi, di sprecarsi, magari per persone che nemmeno comprendono l’amore con cui i gesti sono compiuti.
Potremmo forse tradurre la loro condanna del gesto della donna con queste domande: perché amare? Perché voler bene? E poi: perché voler bene così? Perché … sprecarmi?
Scrive Etty Hillesum (giovane donna ebrea olandese uccisa ad Auschwitz) nel suo Diario:
«Credo che sia soprattutto la paura di sprecarsi a sottrarre alle persone le loro forze migliori».
I presenti infastidiscono la donna: vorrebbero cambiare lei, e non sé stessi. Così come fa Marta (loro compaesana!) nei confronti della sorella Maria (cfr. Lc 10,40).
Un’altra verità del profumo è che esso raggiunge tutti, non esclude nessuno: è versato sul capo di Gesù ma raggiunge anche quelli che s’infuriano contro di lei (cfr. Gv 12, 3: «Tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo»). Amare, voler bene è la cosa più debole e più forte al contempo: può essere rifiutata ma non può essere impedita.
I presenti che si arrabbiano e la donna che rompe il vaso (queste due opposte economie di vita) sono parti che possono convivere in noi, così come la zizzania e il grano sono presenti nello stesso campo (cfr. Mt 13,24-30). Siamo chiamati a prendere posizione, in un cammino che conosce le sue tappe.
6Allora Gesù disse: “Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un’azione buona verso di me. 7 I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. 8 Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. / La donna ha fatto e tace. Dal canto suo, non si difende.
Il silenzio, tra l’altro, è anche un modo per fermare il male e per non moltiplicarlo.
È Gesù che parla per lei e di lei. Innanzitutto smaschera la pretestuosità della preoccupazione per i poveri. Il Signore, prossimo alla morte, viene messo in concorrenza coi poveri, lui che con essi si è identificato! (cfr. Mt 25,35-36).
E poi afferma che la donna ha compiuto un’opera buona, letteralmente: un’opera bella. Un’opera, cioè, che appartiene alla nuova creazione (cfr. Gen 1,4.12.18.21.31). Solo il dono infatti dà inizio al mondo nuovo. Al cospetto di un uomo che sta andando a morire per amore, questa donna dona il profumo esprimendo così la verità dell’affermazione dell’apostolo Giovanni che, nella sua prima Lettera, scrive: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli» (3,14).
Cioè, per l’apostolo Giovanni il contrario di morire non è vivere: il contrario di morire è amare. Vivere amando è già vivere da risorti; dove c’è un amore che dà tutto, c’è già vittoria sulla morte.
9 In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto”. / Gesù dice che dovunque sarà annunciato il Vangelo si parlerà anche di questa donna. C’è una identificazione di Gesù con questa donna (cfr. Mc 1,1). Il Vangelo, cioè, è la presenza di coloro che compiono atti di amore nella gratuità.
Il gesto della donna: per i discepoli è uno spreco, per la donna stessa è un riconoscimento, un
gesto di amore, per Gesù è Vangelo.
Chiediamo al Signore che ci aiuti a sperimentare nella nostra vita che il vasetto di profumo raggiunge la sua verità quando viene rotto e che la nostra verità più profonda è perderci, come il profumo e con il Profumo, per amore.
“Prova … Fa’ gli esercizi…”
Qualcosa è andato storto, solo adesso, distanziandoci nel tempo, forse ne possiamo cogliere tutte le implicazioni.
Più di ogni altra cosa è come se avessimo perso l’allenamento al fare non unicamente per noi stessi ma per una causa più alta, più importante e più nobile. E questo non riguarda solo i nostri ambiti lavorativi, dove ci destreggiamo ogni giorno, quelli bene o male dopo la crisi pandemica hanno ripreso la loro ordinaria funzionalità.
C’è qualcosa di più profondo che è mutato e credo che un po’ tutti ne percepiamo la consistenza anche se non è facile coglierne la portata reale. Sembra di respirarla nell’aria questa incapacità ad andare oltre le nostre incombenze, oltre il nostro senso del dovere, oltre le nostre abitudini quotidiane. Una stanchezza a fare per un intento più alto, più nobile e condiviso, che non riguarda solo la nostra vita ma quella di tutti. Un fare che ci permetta coraggiosamente ad alzare lo sguardo e contemplare … il cielo e le stelle.
Dico queste cose e mi viene naturale pensare alla pratica degli esercizi. Nel linguaggio comune usiamo l’espressione “fare gli esercizi” ed è corretta, appropriata perché gli esercizi vanno fatti cioè vanno pensati, voluti, disciplinati ma non per noi stessi ma per educarci ad alzare lo sguardo e fissarlo su un “qualcosa” di più alto così che il nostro io possa gustare le ragioni ultime ed inesauribili del fare.
Fare gli Esercizi è fermare per un attimo il nostro viaggio poggiando i piedi su una superfice salda e stabile e lì assumere la consapevolezza del cammino già percorso, della strada già fatta.
Fare gli Esercizi è osservare quale orizzonte nuovo la vita ci pone davanti, quali le strade possibili da intraprendere e lasciarci sorprendere da ciò che non è evidente.
Fare gli Esercizi è andare oltre una sensibilità consueta e riconoscere ciò che si muove dentro di noi, quei movimenti profondi invisibili agli occhi ma che abitano in noi.
Fare gli Esercizi è fermare per un attimo il nostro viaggio sospendere le consuetudini di ogni giorno, le urgenze quotidiane, sospendere la frenesia del fare per sperimentare un altro orizzonte, un altro piano di comprensione del reale.
Fare gli Esercizi è riscoprire il senso della Parola e con essa le ragioni delle nostre tante…infinite parole.
Fare gli Esercizi è cogliere le linee di pendenza delle colline in lontananza, quelle che delineano la strada che potremmo scegliere di percorrere e là dove vanno a convergere.
Fare gli Esercizi è un educarci alla sosta per direzionarci verso ciò che abbiamo più a cuore, un fare per dare rinnovato senso e ragione alla nostra esistenza.
Vorrei serenamente stare in panchina
un giro a vuoto
senza troppi clamori
e così capire meglio le regole del gioco.
Spezzare l’ansia del fare
rallentare il respiro
fermi, come davanti
ad un’inattesa mattinata di neve.
Poter camminare senza far rumore
silenziosi e leggeri,
orme che rimangono incollate a terra.
Allora lì forse ci è dato di capire qualcosa
Non è finzione e neanche struggente malinconia
è la capitolazione di antichi rancori
è la differenza che ci separa
da ciò che sempre avremmo voluto.

Ecco una delle diciassette grandi tele che Marc Chagall ha dipinto per rappresentare alcuni passaggi narrati nell’Antico Testamento.
Ci lasciamo interpellare da un’opera d’arte un po’ diversa: non un dipinto ma una realizzazione artistica di Vik Muniz, un artista brasiliano del 1961 che da vent’anni vive e lavora negli Stati Uniti.
Egli ha abbandonato la classica pittura su tela per sperimentare nuove frontiere, come ad esempio comporre illustrazioni utilizzando oggetti di diversa provenienza e grandezza. Questi vengono scelti accuratamente e poi disposti su un piano in modo da formare figure o immagini riconoscibili, spesso riproduzioni di quadri famosi; viene poi scattata una foto dall’alto in modo da vedere l’immagine nel suo insieme e solo guardando attentamente da vicino l’opera si possono distinguere i tanti elementi che la compongono.
Nel 2010 Vik decide di andare nella più grande discarica dell’America Latina: il Jardim Gramacho, dove entra in contatto con i catadores, la “feccia” di Rio de Janeiro. I catadores vivono in estrema povertà, in baracche fatiscenti nelle favelas e per sopravvivere e aiutare la famiglia, guadagnano una miseria lavorando in condizioni disumane nella discarica come riciclatori.
Qui, con l’aiuto di alcuni di loro realizza le riproduzioni di alcuni importanti e famosi quadri utilizzando i rifiuti che escono quotidianamente da ogni casa, dai materiali comuni ai prodotti alimentari, in questo caso quelli che vanno a costituire il 70% dei rifiuti di Rio.
Una delle opere derivate da questo progetto è la foto qui proposta. La forza di questa rappresentazione è non solo nell’aver reso possibile ad un uomo che per la società conta nulla o poco più di diventare un’opera d’arte, ma anche nel proporre l’idea del sottile ma sostanziale passaggio di un raccoglitore di immondizia che viene trasformato in un seminatore.
Il sacco in cui si accumulano i materiali riciclabili selezionati diventa il sacco che contiene le sementi da cui può sorgere nuova vita; il braccio che chi raccoglie da terra tiene rivolto verso il basso, qui è orientato verso l’alto in un gesto di semina, di lancio; il busto, lo sguardo, sono rivolti verso l’alto, verso un orizzonte da cui può provenire nuova speranza. E infatti grazie al lavoro di Vik Muniz e all’uscita del film Waste Land del 2012 che documenta il progetto e le opere da lui compiute a Jardim Gramacho, alcuni catadores sono riusciti a cominciare una nuova esistenza.
Focalizzando meglio sul nostro contesto dei verbi, ecco che i tanti e diversi oggetti che compongono questa immagine rappresentano il molto fare di tutti i giorni; si intravedono gomme d’auto, mobiletti, bulloni, pezzi di auto, frammenti di parti d’arredo, persino assi dei wc, insomma le cose più svariate che fanno parte della nostra esistenza.
Alcuni elementi hanno a che fare con esigenze vitali che vanno a soddisfare i bisogni primari… altri sono più futili come alcuni oggetti che riguardano un fare a volte un po’ dispersivo o che invece di facilitare la quotidianità, la appesantiscono. Tutti contribuiscono comunque a creare l’immagine, affiancati e sovrapposti gli uni agli altri in un’unica intricata trama; proprio un po’ come nelle nostre esistenze.
Il messaggio di queste opere è che tutto può essere ripensato e recuperato per dare un nuovo significato; che anche ciò che del nostro fare consideriamo uno scarto, qualcosa che per fare non serve più, conserva comunque una potenzialità, un valore.
Ma andando oltre l’oggetto in sé, è ciò che il nostro fare produce e ha prodotto nel tempo che rimane, sono i segni che il nostro fare ha lasciato. Pensiamo alle tante energie impiegate per lavorare, per occuparsi delle persone affidateci dalla vita, per alimentarsi, per imparare, per trasmettere ad altri qualcosa, per donare… non viene tutto ad un certo punto tritato nel nulla di una discarica.
Il fare rimane in tanti infiniti segni sia materiali sia intangibili, che spesso non riusciamo a considerare come qualcosa che ha un proprio valore continuamente rinnovabile, come qualcosa che non è andato perduto ma che ha lasciato dei semi in qualcuno anche senza che ce ne siamo accorti o ce ne accorgeremo mai; esattamente come non sono consapevoli coloro che hanno buttato via gli oggetti che hanno contribuito a creare questa immagine.
Ma andando oltre l’oggetto in sé, è ciò che il nostro fare produce e ha prodotto nel tempo che rimane, sono i segni che il nostro fare ha lasciato.
Pensiamo alle tante energie impiegate per lavorare, per occuparsi delle persone affidateci dalla vita, per alimentarsi, per imparare, per trasmettere ad altri qualcosa, per donare… non viene tutto ad un certo punto tritato nel nulla di una discarica.
Il fare rimane in tanti infiniti segni sia materiali sia intangibili, che spesso non riusciamo a considerare come qualcosa che ha un proprio valore continuamente rinnovabile, come qualcosa che non è andato perduto ma che ha lasciato dei semi in qualcuno anche senza che ce ne siamo accorti o ce ne accorgeremo mai; esattamente come non sono consapevoli coloro che hanno buttato via gli oggetti che hanno contribuito a creare questa immagine.
Provo a pensare ad un oggetto che faccia parte del mio fare quotidiano. Non sto a pensarci troppo, lascio che emerga spontaneamente, senza giudicare. Lo “guardo”, lo considero, cerco di percepire quali sensazioni mi dà. Quali cose faccio con questo oggetto? Quali tracce lascio con questo oggetto? In chi e per chi?
Considero l’azione del seminare. Quali sono le mie azioni più frequenti che mi permettono l’opportunità di seminare qualcosa? Come le sto facendo? Come potrei farle meglio perché lo scarto sia minore e la semina più proficua? Il fine non è una sterile autocritica su ciò che non va, è da buttare appunto, ma una vitale riconsiderazione su come posso dare meglio valore a ciò che faccio per seminare.
Accolgo ciò che è emerso e lo affido nella preghiera.

Olivier è un falegname (ci ricorda qualcosa?). Lavora in un centro che accoglie ragazzi che hanno bisogno di imparare un mestiere per reinserirsi nella società dal momento che provengono dal riformatorio.
Un giorno arriva da fuori un ragazzo che conosce. Olivier sembra fortemente turbato, inizialmente rifiuta di prenderlo a lavorare nel suo reparto con una scusa ma poi cambia idea.
Chi è Francis? Perché Olivier, in modo quasi voyeristico, lo osserva, lo studia, addirittura lo segue di nascosto? A mezz’ora di film (ma anche nel trailer), scopriamo che il ragazzo, di nome Francis, ha ucciso il figlio di Olivier qualche anno prima durante un furto.
L’uomo è attraversato da sentimenti contrastanti, shock, rabbia, curiosità, empatia, sentimento di vendetta, stati d’animo che sembrano dipanarsi, districarsi via via che il personaggio si muove nella storia, fa quello che sente di poter fare.
Olivier non rifiuta la chiamata ma entra pienamente in questa storia, in questo incontro, con il suo saper fare. Il film è infatti il racconto di un incontro difficile, doloroso, a momenti quasi insostenibile per il protagonista, di cui i registi spiano (come Olivier fa con Francis) emozioni e sentimenti, gesti e fisicità, con una camera a mano che sta sopra i volti, le teste, i corpi dei personaggi.
È l’incontro con colui che potremmo definire il nemico di Olivier, chi, uccidendo il figlio, ha ucciso il suo essere padre ma non ha ucciso la sua umanità che l’uomo manifesta nel lavoro che svolge, nell’aver messo a servizio degli altri (ragazzi come Francis) il suo mestiere.
È un incontro tra da un lato un uomo che attraverso i ragazzi a cui insegna, e attraverso Francis, riesce a entrare di nuovo in contatto col suo essere padre, e dall’altro un ragazzo che vede in Olivier il padre che non ha mai avuto.
Questo incontro sembra casuale all’inizio del film, del tutto accidentale ma, a pensarci bene, non è affatto così. Olivier ha fatto una scelta precisa, ha scelto di insegnare il suo lavoro a ragazzi che hanno commesso dei reati per “sentirsi utile” (come dice in una scena alla sua ex moglie che prova a convincerlo ad andare via dal centro) ma forse anche con l’inconscio desiderio di incontrare proprio Francis, l’assassino di suo figlio, il suo nemico.
Magalis, la sua ex moglie, quando scopre cosa sta succedendo, gli chiede “perché lo fai? Nessuno lo farebbe” ma Olivier non lo sa, semplicemente fa, e forse si rende conto che solo facendo, si può capire qualcosa di più dell’altro, nemico o amico che sia, solo non scappando, si può forse affrontare il dolore e guardare in faccia chi questo dolore lo ha provocato.
Olivier fa, accoglie Francis, gli insegna il lavoro di falegname: praticamente quasi tutte le scene in cui sono insieme hanno al centro il fare, il lavoro da falegname, portare una tavola, riconoscere i vari tipi di legno, prendere le misure. Attraverso il fare, ci si relaziona e forse è possibile trovare un modo per comunicare, un modo, come scriveva Pavese, “per rompere la nostra solitudine e comunicare con gli altri”.
Senza nessuna pretesa di assolutizzare alcunché, in questa storia il fare è al cuore delle cose: è facendo che i personaggi toccano la loro verità e quella dell’altro.
Un bel messaggio per chi pensa troppo, per chi rimane incastrato nei propri pregiudizi, per chi affoga nei propri pensieri, per chi non vede che il proprio dolore.
• Regia: JEAN PIERRE e LUC DARDENNE
• Interpreti: OLIVIER GOURMET, MORGAN MARINNE
• Anno: 2009
• Paese: BELGIO
• Durata: 99 min.
• Disponibile su: GOOGLE PLAY, YOUTUBE, APPLE TV
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
« …tu hai detto… »
(Tobia 8,6)
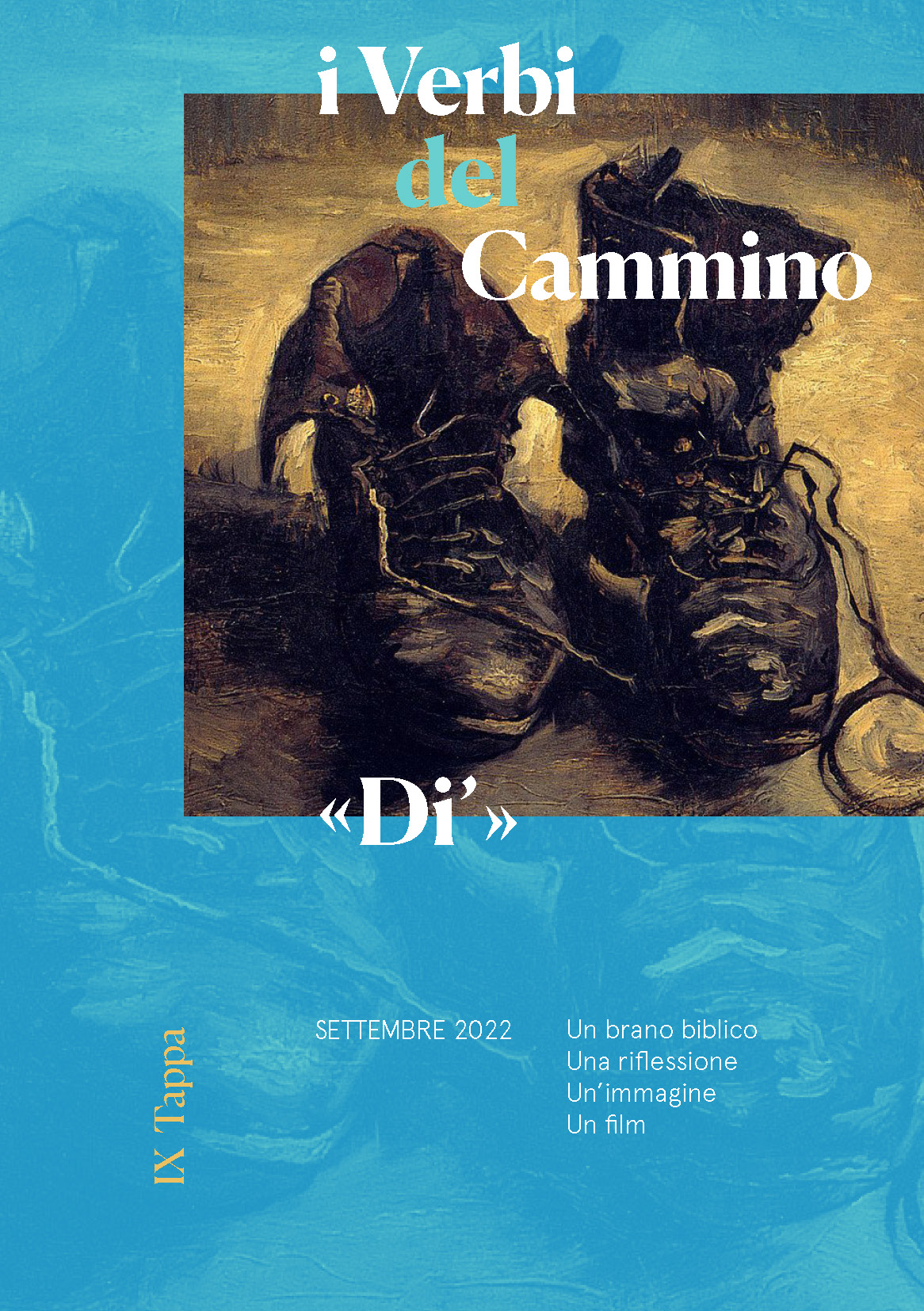
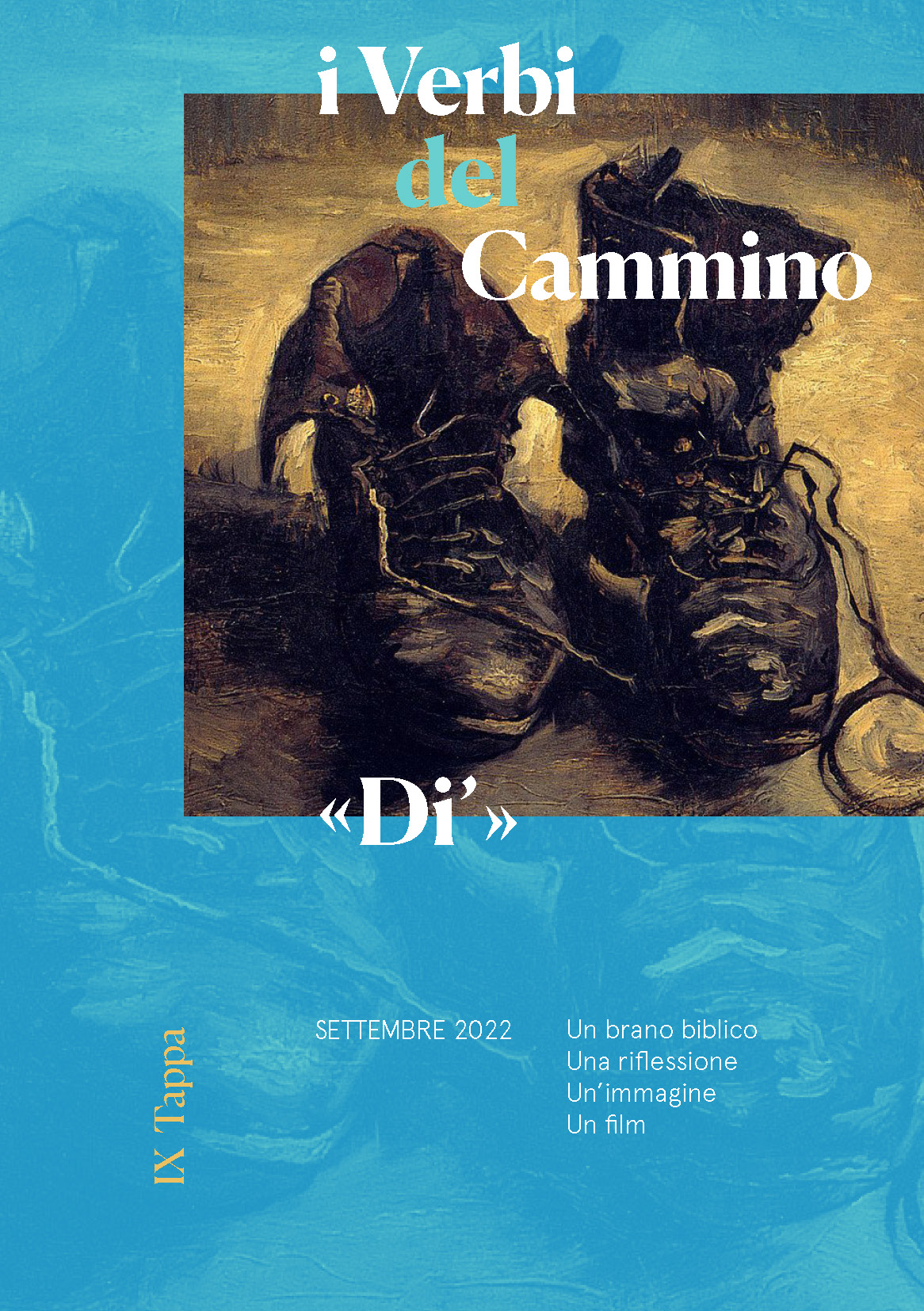
« …tu hai detto… »
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
Luca 7,1-10
1Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafàrnao. 2Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. 3Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. 4Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: “Egli merita che tu gli conceda quello che chiede - dicevano -, 5perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga”. 6Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: “Signore, non disturbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; 7per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà guarito. 8Anch’io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa”. 9All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: “Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!”. 10E gli inviati, quando tornarono
a casa, trovarono il servo guarito.
Protagonista di questo episodio è il centurione che però non entra mai direttamente in scena. La sua fede ha un ruolo più rilevante rispetto alla guarigione del servo.
1 Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafàrnao. / Gesù ha appena terminato il discorso ai discepoli, discorso che l’evangelista Luca, diversamente da Matteo (5,1), colloca in un luogo pianeggiante (Lc 6,7): forse un richiamo alla “pianura” della nostra quotidianità dove spesso si nascondono ascese inaspettate e significative.
Gesù rivolge al popolo «tutte» le sue parole, dice tutto quello che aveva da dire (cf. Gv 15,15), creando comunione e amicizia con coloro che stanno in ascolto: dice tutto, così come darà tutto sé stesso.
La parola richiede un umile atteggiamento di ascolto per essere accolta, un ascolto calmo e attento fino alla fine: «A voi che ascoltate, io dico...» (Lc 6,27). Il dire e l’ascoltare presuppongono, custodiscono e sostengono una relazione personale che, in questo brano, sarà chiamata ‘fede’.
2 Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. 3Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. / Anche il centurione è una persona che ascolta: ha udito parlare di Gesù e da quello che ha ascoltato ha compreso che Lui desidera e può donarci vita. Cerca pertanto di creare un ponte fra due parole che lui ascolta e accoglie: la parola riguardante Gesù, con il suo desiderio di donare vita, e quella parola così silenziosa, forse, ma al contempo così forte ed eloquente che è la sofferenza del servo che gli è molto caro e per il quale desidera, appunto, vita.
Il centurione affida ad alcuni anziani dei Giudei la propria parola di richiesta e costoro intercedono presso Gesù: una parola che inizia come sofferenza del servo e che passa di bocca in bocca per raggiungere finalmente il cuore di Gesù. Come la conoscenza di Gesù avviene tramite altri mediante l’ascolto, così anche l’accesso a Lui è mediato da altri, fino a quando ogni carne vedrà la salvezza di Dio (Lc 3,6).
4 Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: “Egli merita che tu gli conceda quello che chiede - dicevano -, 5 perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga”. 6 Gesù si incamminò con loro. / Gli anziani dei giudei dicono parole di supplica e parole che mettono in evidenza i meriti della persona che li ha inviati da Gesù. E questi s’incammina con loro.
Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: “Signore, non disturbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; 7 per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà guarito. 8 Anch’io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa”. / La seconda modalità d’incontro con Gesù contrasta con la prima. La prima si realizza tramite anziani del popolo di Israele e fa leva su concetti quali dignità, merito. La seconda vede protagonisti amici del centurione e dice di indegnità, difetti; insomma, si fonda unicamente sulla fiducia nell’interlocutore e non su propri diritti o meriti.
Il senso d’indegnità non distrugge, anzi, alimenta la fede in Gesù, la fiducia incondizionata nella Sua parola. Il centurione percepisce insieme la propria miseria e la misericordia del Signore: non pretende nulla, la sua è una fede forte e rispettosa. Le parole che il centurione dice sono quelle che ogni fedele ripete in ogni Eucarestia prima di ricevere il corpo di Gesù, cibo che - come l’amore - non si merita, ma si accoglie.
Notiamo anche che nella casa del centurione regna la concordia: egli vuole bene al suo servo, ama il popolo di Israele ed è circondato da amici. Non sono relazioni di potere. Il centurione è una persona capace di amare, di voler bene, cioè di volere il bene dell’altro. Così come lui, straniero e pagano, aveva fatto costruire la sinagoga, adesso desidera la vita per il suo servo.
Questa volta è Gesù che ascolta una parabola: con essa il centurione vuol dire che lui stesso, pur essendo un sottoposto, ha il potere di dare ordini e che quindi a maggior ragione può farlo Gesù. Anche perché ora, nonostante la propria autorità, il centurione sperimenta la propria incapacità di fronte al suo servo malato.
Il centurione non vedrà Gesù, né Gesù il centurione. Eppure fra i due accade un incontro vero, autentico, pieno.
Tra loro interviene solo la parola e tutto avviene per intercessione: il servo non chiede nulla, lo fa per lui il suo padrone, che chiede prima agli anziani e poi agli amici di pregare Gesù.
9 All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: “Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!”. / Gesù non ha neppure bisogno di pronunciare la parola che il centurione gli ha chiesto. Il servo infatti ritroverà la salute grazie alle parole di fede pronunciate dal suo padrone. Il centurione aveva sentito parlare di Gesù (v. 1). Ora Gesù sente parlare del centurione, anzi sente parlare il centurione attraverso la bocca di suoi mediatori. Il centurione è l’unica persona che Gesù ammira: c’è fede presso gli estranei e non presso i vicini (Mc 6,6)!
Ciò che suscita l’ammirazione di Gesù è la fiducia fondamentale che quell’uomo ha nei suoi confronti e nella forza della Sua parola. La fede è la nostra risposta a Gesù che desidera donarci vita. Il centurione rimane il personaggio principale; Gesù reagisce quasi come uno spettatore. Infatti, quando finalmente prende la parola, non è né per rispondere agli amici del centurione né per pronunciare la parola che guarisce, ma per rivolgersi alla folla che lo accompagna e parlare del vero protagonista di questa storia. «Di’ una parola», aveva chiesto il centurione. Ma, alla fine, chi ha detto questa parola? Non lo sappiamo di preciso. Come di preciso non sappiamo nemmeno quale sia stata questa parola. Gesù fa tutto ciò che gli chiede il centurione. Se lo prega di venire, eccolo incamminarsi verso di lui. Quando gli fa sapere di non disturbarsi, eccolo fermarsi. Gesù agisce come i subalterni del centurione: “Vieni” ed egli viene, “va” ed egli va. Come il servo, il Signore fa ciò che gli si dice di fare. Il solo ordine che non eseguirà sembra essere quello di dire una parola affinché il servo sia guarito, a meno di non voler considerare come tale ciò che Gesù dice e cioè il riconoscimento della fede del centurione. Va però sottolineato che è la presenza di Gesù a permettere al centurione di esprimersi con tutto sé stesso, fede compresa, di essere cioè pienamente sé stesso.
10 E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. / Il servo stavolta ha obbedito a una parola di guarigione che – di fatto e a distanza, quasi senza esserne del tutto consapevole – il centurione ha detto su di lui e che Gesù ha confermato.
In conclusione
«Di’ una parola»: Qual è la parola che vorrei sentirmi dire da Gesù?
O, ancora meglio: qual è la parola che chiedo a Gesù di poter dire, e che porta vita in me e attorno a me?
Poesia scritta con la matita
Sono devoto all’anima di grafite della matita:
un solo colpo di gomma e il segno lasciato sparisce,
sentieri imboccati con leggerezza
si riconducono alla docilità della via maestra
i crolli vengono evitati con un’alzata di spalle,
l’imprevisto è un vecchio con il pugnale spuntato.
L’anima di grafite non conosce soste, esitazioni:
nel suo stesso procedere in avanti
ci chiama alla possibilità del ritorno,
nel suo segno scuro riposa la dolcezza del bianco
e Angelina torna a sorridere
tenendo per mano un bambino
abbagliato dal sole.
Pierluigi Cappello
Lo confesso, sono io stesso un devoto di questo poeta. Un signore del verso Pierluigi Cappello che personalmente considero una delle voci liriche più limpide di questo nostro tempo.
Mi viene in mente lui se penso al richiamo del verbo DIRE. È la sua matita, chissà perché, a richiamarmi il DIRE. Non un frastuono di parole, non una deriva dell’ascolto ma il lento agire di un dire efficace, un’avventura dell’anima.
Lo sappiamo, lo sappiamo bene che le nostre parole sono fragili e spesso povere ed insufficienti, ci girano intorno e se va bene ci tornano indietro impotenti e sgualcite. Le parole abbondano in ogni dove, siamo sommersi dalle parole e spesso procedono randagie per la loro strada prive di un corpo che le custodisca. Ci esaltiamo per la loro forza espressiva e ci abbaglia il potere che da esse ne possiamo trarre. Penso all’infinito flusso delle parole e penso a quante volte sono stato sia vittima che carnefice.
DIRE forse è un’altra cosa, non può che essere un’altra cosa e se non ne intuiamo la diversità, ed è legittimo non intuirla, allora dobbiamo imparare da chi è maestro nel dire, e quindi dai poeti.
Dire è un’altra cosa: una danza leggera che non ferisce alcuno, un azzardare l’impossibile per scoprire poi inaspettatamente che tutto risulta più facile, più semplice di quanto ci è dato di credere.
Dire ci mettere in corrispondenza con una infinita linea d’orizzonte appena tracciata, appena tratteggiata.
Dire è la discrezione, la gentilezza, il tempo infinito dell’ascolto, una verità che deve diventare familiare se vogliamo sopravvivere al deterioramento delle parole.
Vorrei accarezzarti con il mio DIRE e non finire mai di stupirti. Come un segno di matita, semplicemente un segno di matita.

Ecco una delle diciassette grandi tele che Marc Chagall ha dipinto per rappresentare alcuni passaggi narrati nell’Antico Testamento.
Qui, immersa nel giallo bagliore della presenza divina, viene raffigurata la scena della consegna delle tavole della legge a Mosè, dipinto a grandi dimensioni e posto in una dinamica diagonale che divide il quadro in due parti. A sinistra il popolo d’Israele che osserva un po’ incredulo e disordinato la determinazione della sua guida ma che ha già pronto in alternativa il vitello d’oro. Il monte Sinai è colorato come Mosè in bianco e grigio ma il suo fianco ne traccia una diagonale opposta, quasi come per voler far notare che Mosè per andare ad incontrare il Signore ha cambiato rotta rispetto al suo popolo, non ha seguito la direzione che stavano percorrendo insieme, ha osato altro.
Ecco perché Chagall lo rappresenta con sul capo i raggi della benedizione; lui è il prediletto, è l’eletto, non si perde d’animo e crede fino in fondo alla promessa.
L’incontro tra Dio e Mosè avviene attraverso la Parola; Dio non è visibile (“Dio nessuno lo ha mai visto”), chiede ancora una volta di fidarsi del proprio sentire nell’incontro con Lui, non di certezze tangibili ma di percezioni, chiede di fidarsi di quelle dieci parole che portano alla vita.
Sulla destra in basso vediamo il popolo dei profeti. C’è Aronne che porta il candelabro simbolo sacro della tradizione ebraica e sul petto ha le pietre delle 12 tribù di Israele. Appare triste e con lo sguardo rivolto verso il basso. C’è il re Davide, riconoscibile dalla corona, che suona l’arpa. C’è anche il profeta Geremia che appare anch’egli triste e assorto nei suoi pensieri. Forse Chagall ha voluto rappresentare attraverso di loro il dispiacere di Dio nel vedere l’infedeltà del popolo. Alle persone rappresentate sulla destra, l’angelo scendendo dal monte porta il rotolo della Torah.
Guardando il quadro nel suo insieme, notiamo che la diagonale descritta dal protendersi del corpo di Mosè ha un suo parallelo in una coppia che si eleva abbracciata sopra il vitello d’oro, accompagnata dalla vicina presenza di un angelo. La loro direzione porta ad un’altra rappresentazione di coppia che si intravede un po’ più a destra, disegnata quasi in trasparenza e immersa nel giallo della luce di Dio.
Come in tanti altri suoi dipinti, Chagall rappresenta l’amore terreno come luogo in cui è possibile elevarsi e farsi più prossimi a Dio accomunati da un desiderio di vita e di amore che vuole affondare nel contempo le proprie radici nell’umano ma con lo sguardo rivolto al divino di cui l’uomo e la donna sono immagine.
Guardo gli occhi di Mosè: sembrano rivolti ad un volto di Dio che però non si vede, eppure il suo sguardo appare come sorridente e fiducioso.
Guardo i suoi piedi scalzi che hanno imparato a presentarsi inermi e senza difese dopo che Dio gli aveva fatto togliere i sandali per imparare ad incontrarlo nel roveto ardente presentandosi senza barriere.
Guardo le mani grandi, protese e pronte a ricevere il peso di una parola incisa sulla pietra, che poi però sarà portata da un angelo che lo aiuterà a diffonderla.
Provo ad immedesimarmi in Mosè e mi concentro sul mio sguardo verso un Dio che non vedo, sui miei piedi scalzi e quindi vulnerabili che vanno incontro all’altro, sulle mie mani che accolgono la fatica di una Parola che appare limitazione ma che si trasforma nella libertà di un volo alato. Come mi sento? Dove faccio più fatica?
Guardo la coppia che si solleva elevandosi dal disordine di un popolo incerto e affaticato e percepisce nel proprio amore la possibilità di superare fatiche e incertezze rimanendo l’uno nello sguardo dell’altro e avvicinandosi abbracciati allo sguardo di Dio.
Quali esperienze scorgo nella mia/nostra storia di momenti o eventi in cui ho/abbiamo percepito questo?
Accolgo quanto è emerso e lo affido, lasciandolo avvolgere dal calore del giallo del quadro.

Dopo nemmeno un anno dall’avere ereditato il trono britannico, l’11 dicembre 1936 re Edoardo VIII abdica per poter sposare Wallis Simpson, un’americana che ha divorziato dal suo primo marito e sta cercando il divorzio dal suo secondo: una condizione inaccettabile per la futura moglie di un sovrano. Il trono del Regno Unito passa a suo fratello minore Albert, soprannominato “Bertie” in famiglia, duca di York, che viene incoronato re Giorgio VI il 12 maggio 1937.
Il passaggio avviene alla vigilia di uno dei momenti più bui della storia europea: Hitler è sul piede di guerra e le grandi nazioni, provate da una lunga crisi economica e con le ferite ancora non rimarginate della Prima Guerra Mondiale, devono fronteggiare la più violenta aggressione mai vista nel vecchio continente. In questo quadro, Bertie è tutt’altro che felice di prendere il posto del fratello maggiore.
Giorgio VI è descritto come un “re riluttate”, ha un’indole riservata, un carattere introverso e, soprattutto, è segnato da una caratteristica che sta al centro del film che proponiamo per il verbo dire: una balbuzie che gli impedisce di affrontare con le necessarie tranquillità e sicurezza qualunque discorso pubblico. Considerando che la voce del re arriva a milioni di sudditi in tutto il mondo attraverso i microfoni della BBC, il sovrano appena salito al trono ha bisogno di affrontare questo problema con urgenza.
È sua moglie la regina, Elizabeth Bowes-Lyon, a sostenere il marito in questa battaglia con sé stesso, a individuare in un logopedista di origini australiane, anticonvenzionale e all’avanguardia, Lionel Logue, la persona in grado di aiutare Bertie con la sua balbuzie. Il lavoro che permette ai due di affrontare le difficoltà di Giorgio VI non è privo di scontri e deve necessariamente passare per questioni molto personali, che riguardano la sfera affettiva e familiare di Bertie. È proprio il nesso intimo che si crea tra i due uomini a essere determinante per aiutare Albert a superare le sue difficoltà, oltre che a far nascere una duratura amicizia tra il terapeuta e il suo assistito.
Nella realtà le vicende ebbero uno sviluppo un po’ più lungo, in un arco di tempo più ampio, che nel film è stato condensato per ragioni drammaturgiche, ma la sostanza umana ed emotiva della vicenda restano inalterate, creando un racconto ricco di senso e di sensibilità, e che, pur occupandosi della vita di un re, è capace di parlare alla mente e al cuore di ogni essere umano. Che cosa c’è di più universalmente umano della voce?
Come scriveva il filologo e critico letterario, Paul Zumthor: «Luogo di articolazione delle parole e delle frasi, la voce ne travalica, con tutta la sua potenza esistenziale, la materialità e il significato […] Numerosi studi recenti hanno dimostrato che la voce costituisce, nell’inconscio umano, una forza archetipica: è un’immagine primordiale e dotata di un potente dinamismo creatore, la quale predetermina più o meno per ciascuno di noi una configurazione mentale, affettiva, se non un modo di pensare simbolico. Di qui la sua notevole capacità di generare miti e di prestarsi a significazioni religiose. Affondando le proprie radici a monte di ogni formula concettuale, questa immagine, nella sua totale cecità, ci assicura che non siamo – né voi né io – soli al mondo. È questo il motivo per cui il linguaggio è senz’altro impensabile senza la voce […] La parola si articola dunque, nella voce, in un duplice desiderio di dire, e quello di dirsi.»
E infatti, Bertie deve imparare ad amare sé stesso per poter affermare sé stesso e quindi dire sé tesso attraverso la propria voce. Lo può fare grazie a Lionel, non solo perché quest’ultimo è un geniale terapista ma, soprattutto, perché è un generoso “ascoltatore” della voce di Bertie. Il verbo dire è necessariamente e intimamente connesso con il reciproco ascoltare.
Solo se riconosciuti e accettati dall’altro possiamo esistere. Scrive il filologo Corrado Bologna: «Prima ancora che il linguaggio abbia inizio e si articoli in parole per trasmettere messaggi nella forma di enunciati verbali, la voce ha già da sempre origine, c’è come potenzialità di significazione e vibra quale indistinto flusso di vitalità, spinta confusa di voler-dire, all’esprimere, cioè all’esistere. La sua natura è essenzialmente fisica, corporea; ha relazione con la vita e con la morte, con il respiro e con il suono; è emanata dagli stessi organi che presiedono all’alimentazione e alla sopravvivenza. Prima di essere il supporto ed il canale di trasmissione delle parole attraverso il linguaggio, dunque, la voce è imperioso grido di presenza pulsazione universale e modulazione cosmica tramite le quali la storia irrompe nel mondo della natura: di una simile Metafisica della Voce è testimonianza in quasi tutte le culture antiche ed anche moderne, che all’emanazione sonora annettono un valore demiurgico, fondatore, addirittura iatrico-taumaturgico, incastonandola nell’orizzonte sacrale e individuando nel luogo dell’Origine lo spazio che essa colma.»
“Lasciate fare al microfono”, questo è il consiglio che si sente dare il principe Albert, bloccato dalla balbuzie davanti a uno strumento capace di diffondere la sua voce su tutta la Terra - più o meno quella era l’estensione del Commonwealth Britannico. E come non sentirsi vicini a quest’uomo, alla sua paura di far sentire la sua voce? La nostra voce, intima e personale, eppure alla mercé degli altri a cui arriva; la nostra voce che a nessuno (o quasi) piace riascoltare. La diffusione dei media ha esasperato e continua ad esasperare le capacità di performance: tirare fuori la voce è prima di tutto una terribile battaglia contro sé stessi.
Cresciuto all’ombra di un padre ingombrante e brusco, a fianco di un fratello maggiore esuberante, molto attento ai propri desideri, anche a scapito degli impegni dovuti per nascita, Bertie deve imparare ad affermare sé stesso, ribadendo il proprio diritto a esistere. Lo stesso diritto di esistere degli stati attaccati con inedita violenza dalla Germania nazista nello stesso momento in cui sale al trono. La sua voce, la voce del re, è chiamata a esprimersi, a dire un discorso, per raccogliere le proprie forze e quelle di tutta la gente che aderisce al suo appello, per affermare quel diritto a esistere in pace e in libertà che in quel momento è ferocemente minacciato.
Re Giorgio VI, dai microfoni della BBC, il 3 settembre del 1939, con una voce che a stento supera gli inciampi della balbuzie, parla così al suo popolo: «Siamo stati costretti a un conflitto, perché ci viene richiesto di affrontare la sfida a un principio che se dovesse prevalere sarebbe fatale per ogni ordine civile del mondo. È il principio che permette a uno stato, nel perseguimento egoistico del potere, di ignorare i trattati e gli impegni assunti solennemente; che sancisce l’uso della forza, o la minaccia della forza, contro la sovranità e l’indipendenza dei nostri stati.»
«Se tale principio, la mera primitiva dottrina che la ragione è del più forte, dovesse affermarsi nel mondo, la libertà del nostro paese e di tutto il Commonwealth sarebbe in pericolo. Questa è la posta in gioco. Per amore di tutto quello che ci è caro, è impensabile che possiamo rifiutare tale sfida».
*I brani di Paul Zumthor e di Corrado Bologna sono entrambi tratti da CORRADO BOLOGNA, Flatus Vocis - Metafisica e antropologia della voce, Il Mulino, Bologna, 1992.
• Regia: Tom Hooper
• Interpreti: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Timothy Spall
• Genere: Dramma storico
• Paese: Regno Unito
• Anno: 2009
• Durata: 188 min.
• Disponibile su: Amazon Prime Video, Google Play, YouTube, Apple Tv
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
«da loro due nacque
tutto il genere umano…»
(Tobia 8,6)
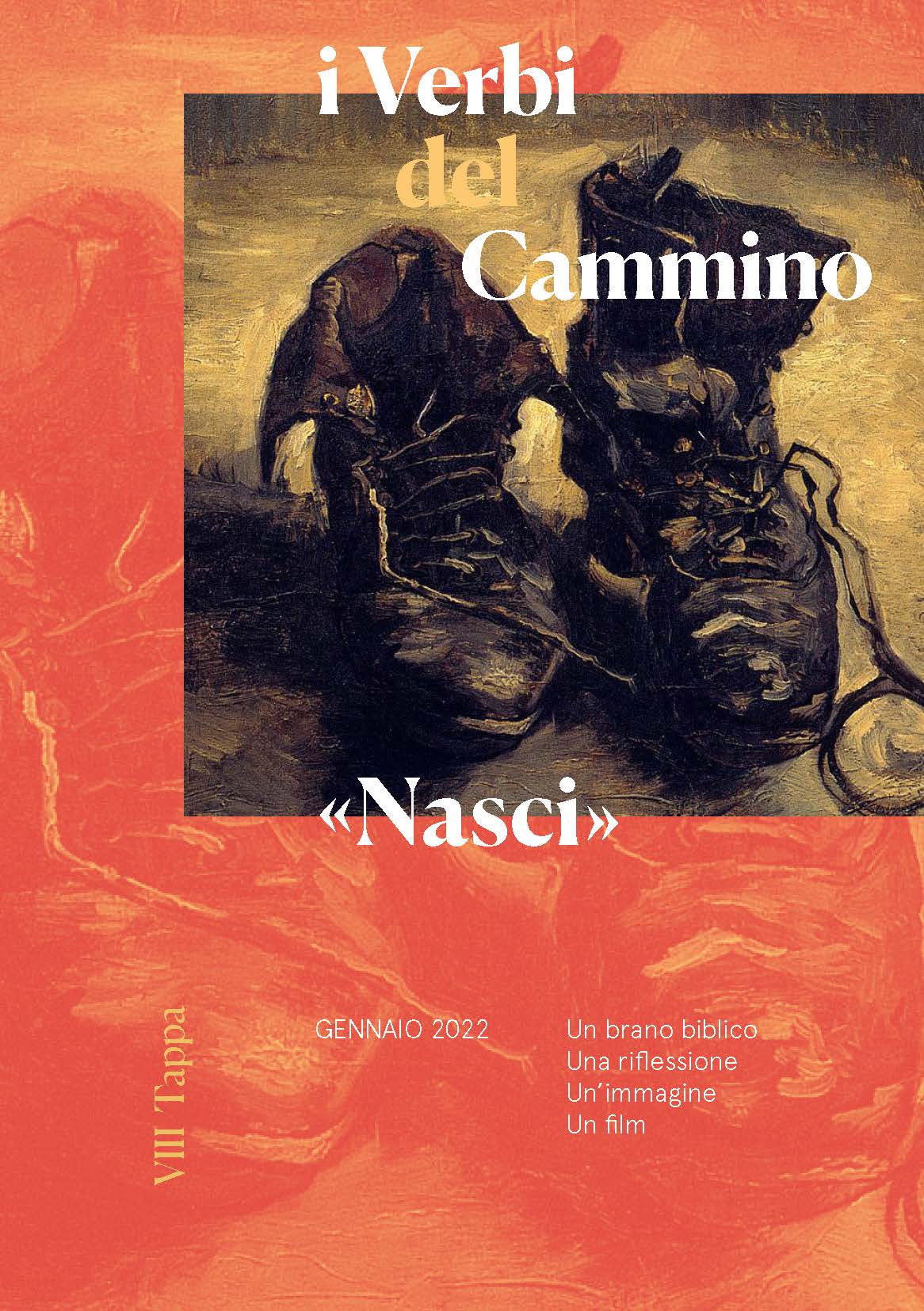
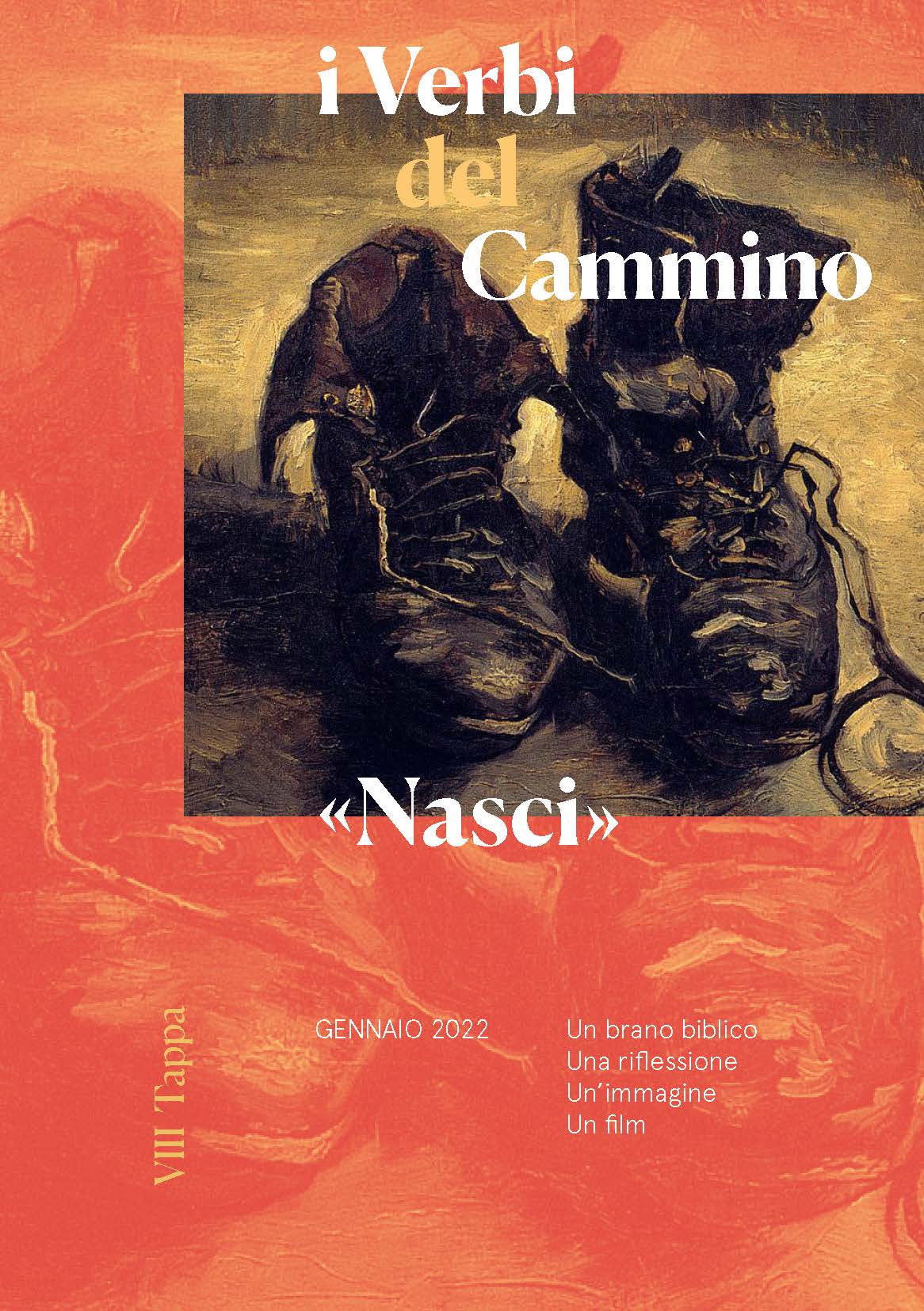
«da loro due nacque
tutto il genere umano…»
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
Luca 1,5-25
5Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. 6Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. 7Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 8Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, 9gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l’offerta dell’incenso. 10Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. 11Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. 12Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. 13Ma l’angelo gli disse: “Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 14Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, 15perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre 16e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. 17Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto”. 18Zaccaria disse all’angelo: “Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni”. 19L’angelo gli rispose: “Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. 20Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo”. 21Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. 22Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. 23Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. 24Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: 25“Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini”.
Luca 1,57-66
57Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. 58I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 59Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. 60Ma sua madre intervenne: “No, si chiamerà Giovanni”. 61Le dissero: “Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome”. 62Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. 63Egli chiese una tavoletta e scrisse: “Giovanni è il suo nome”. Tutti furono meravigliati. 64All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. 65Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 66Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: “Che sarà mai questo bambino?”. E davvero la mano del Signore era con lui.
Luca 1,80
80Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
Luca 1,5-7 / L’evangelista Luca apre il proprio racconto con l’annuncio di due nascite, e di due nascite particolari: la prima da una donna sterile e la seconda da una vergine. ‘Al tempo di Erode’: una nascita che avviene in tempi non ideali, sotto Erode, il quale inoltre, stando al racconto Matteo, accoglierà la notizia della nascita del bambino Gesù come una minaccia per sé (Matteo 2,16).
Zaccaria ed Elisabetta sono una coppia lontana dai potenti di turno e sembrano essere anche una coppia senza futuro. Si può essere giusti e senza figli. La sterilità di Elisabetta, che ricorda quella delle matriarche, ben rappresenta ogni nostra situazione che appare senza via d’uscita.
Luca 1,8-17 / Zaccaria incontra il Signore nel compimento del suo dovere, nello svolgimento delle funzioni sacerdotali che gli sono proprie. Quella di Giovanni sarà una nascita attesa, una nascita per la quale si è pregato, una nascita portatrice di gioia per tutti, non solo per i genitori, perché segnata da una grandezza che è tale agli occhi del Signore. Tale grandezza si esprime come forza riconciliante («ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio… per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti»). Una grandezza ben diversa quindi da quella che ci divide gli uni dagli altri, apostoli recidivi compresi: «Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande» (Luca 9,46); «E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande» (Luca 22,24).
Luca 1,18-22 / Elisabetta è sterile e tutti e due sono avanti negli anni. Coma Sara e Abramo. Difficile scorgere possibilità di un futuro, un futuro che non dipende solo da quello che possiamo fare noi. La fede di Zaccaria sembra arrestarsi davanti all’annuncio dell’angelo.
Risuonano resistenze analoghe a quelle che il lettore della Bibbia ha incontrato nel racconto del libro della Genesi quando, prima Abramo e subito dopo sua moglie Sara, faticano ad affidarsi alla parola che il Signore rivolge loro. «Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: “A uno di cento anni può nascere un figlio? E Sara all’età di novant’anni potrà partorire?”. 18 Abramo disse a Dio: “Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te!”» (Genesi 17,17-18). «Allora Sara rise dentro di sé e disse: “Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!”» (Genesi 18,12). Per Abramo si compirà la parola che aveva già ascoltato da parte del Signore: «uno nato da te sarà il tuo erede» (Genesi 15,4). Anche Zaccaria scoprirà che nulla è impossibile a Dio (cf. Genesi 17,19; 18,14).
Insomma, piuttosto che Abramo e Sara (e Zaccaria) che faticano a credere, ecco che l’unico vero “credente” sembra essere il Signore, che non si stanca di porre la propria fiducia in Abramo, Sara, Zaccaria, Elisabetta.
La resistenza a credere nella Parola ci rende sordi non solo all’Altro ma anche agli altri (cf. v. 62) e incapaci di dire parole vere, parole di benedizione.
Luca 1,23-25 / Dal tempio alla casa con nel cuore ma non sulla bocca resa muta il «lieto annuncio» dell’angelo da trasmettere alla moglie. Sembra che prima che dare la vita a Giovanni le parole dell’angelo abbiamo ridato vita a Zaccaria e ad Elisabetta. Il miracolo che è questa nascita (e che di fatto è ogni nascita) scandirà ormai il tempo dell’Incarnazione. Dal «tempo di Erode» (1,5) che è quello di Zaccaria nel tempio di Gerusalemme si passerà al «sesto mese» (1,26) che è quello di Maria nella casa di Nazaret. La possibilità di una vita nuova, quasi non più sperata, è ciò che il Signore ha compiuto per Elisabetta ed è ciò che desidera compiere «per me».
Luca 1,57-64 / Non c’è solo la promessa, c’è il compimento. Questa nascita è segno della misericordia divina. Così è per ogni nascita. Ma non è forse anche così ogni volta che ci viene donata, in tanti e diversi modi, una nuova possibilità di vita?
Il nome del neonato sarà quello annunciato dall’angelo. Dall’alto proviene la nostra vera identità, una identità donata, come la stessa vita. Un nome che sorprende, che suscita meraviglia. Il «No» pronunciato da Elisabetta e confermato per iscritto da Zaccaria è l’eco del «Sì» pieno e definitivo alla promessa di vita di Dio, molto più grande di ogni attesa umana.
Luca 1,65-66 / Ogni esistenza è un mistero che riposa nella mano di Dio e per questo è bene che la domanda che le persone si fanno (“Che sarà mai questo bambino?”) non riceva mai una risposta compiuta. Non possediamo e non possederemo mai la vita: né la nostra né tantomeno quella degli altri. Possiamo solo accogliere e custodire.
Luca 1,80 / La nascita è compimento e insieme nuovo inizio, punto di partenza.
La vita va nutrita in tanti modi e in tanti modi si cresce. Nel corpo e nello Spirito.
Zaccaria è uomo del tempio, il figlio dimora nel deserto. La parola del Signore ci raggiunge ovunque e in ogni circostanza. Quello che era atteso dai suoi sarà colui che indicherà a tutti l’Atteso di ogni tempo.
Nascere non basta.
È per rinascere che siamo nati.
Ogni giorno.
Pablo Neruda
Nascere non è scontato … e questo lo sappiamo. L’intenzionalità di essere oggi qui, ognuno
di noi oggi qui, dipende da una volontà e da una grazia imponderabile che in qualche misteriosa logica ci troviamo a subire.
Questo può sembrare scontato ma spesso, molto spesso, ce ne dimentichiamo e assumiamo una presunzione esistenziale poco edificante, soprattutto poco ragionevole, diciamo anche un po’ patetica. Quello che dipende da noi è rendere attivo quell’imponderabile che ci è dato e forse donato.
E questo non è poca cosa perché si tratta di rendere vitale, rendere germinativo ciò che all’origine è un “semplice” patrimonio potenziale. Bisogna mettersi d’impegno per nascere continuamente liberando il campo da possibili fraintendimenti. Essere al mondo e starci con un senso è il percorso di un’intera vita, come dire che nasciamo per scoprire il senso del nascere.
Nessuno ce la insegna questa sapienza perché come tutte le sapienze che si rispettano può sopraggiungere solo da un’esperienza incarnata cioè da una sapienza che si acquisisce nella vita normale, ordinaria, domestica. Non c’è nessuna sapienza superiore teorica o letta su qualche libro che ci risolve il problema. Solo il lento, costante, ostinato incontro con l’ordinario può trasformarci in donne e uomini rinati nella sapienza di una nascita seconda.
Credo che sia così, credo che la vita in sé, la vita normale in sé custodisce un sapere che ogni giorno siamo chiamati a ricomprendere….
Ma non è tutto lì, non è proprio tutto lì.
Nell’ordinarietà che ci è data e che in buona parte edifichiamo giorno per giorno si annida un rischio che sicuramente ben conosciamo. Il rischio di sprofondarci dentro quell’ordinarietà, galleggiare al suo interno senza possibilità di venirne fuori edificati, cresciuti, nuovi.
In questa direzione la prospettiva credente può aprirci spazi di sapienza eccedente, cioè spazi nei quali pur rimanendo dentro, totalmente dentro l’esperienza esistenziale che siamo chiamati ad abitare, ci permetta di poter guardare e comprendere prospettive interpretative inedite e sempre nuove del reale.
La prospettiva del buon Nicodemo in Giovanni 3 per me è un orizzonte nel quale mi immergo ogni giorno per dare senso e valore al giorno che mi attende. Rinascere dall’alto… perché abbiamo bisogno di una nascita seconda per vedere le cose per come sono nella loro genuina ordinarietà.
È lo sguardo alto (Calvino direbbe leggero) sulla domesticità che ci permette di capire da dentro, di accedere da dentro al senso delle cose. Rinascere dall’alto per capire il senso di ritrovarsi intorno ad una tavola a condividere cibo e parole, rinascere dall’altro per dare continuamente nuova ragione all’intimità dell’atto amoroso, rinascere dall’altro per non tenere la porta chiusa ma solo socchiusa affinché qualcuno possa aggiungersi al nostro abitare.
Credo che possiamo così sperare che ogni cosa assuma un senso semplicemente per quello che è nella giusta misura di ciò che è. Questo per me è un nascere continuo, insostituibile per la mia vita.

Questo dipinto del Caravaggio rappresenta Giuseppe e Maria intenti a custodire la nascita appena sbocciata del loro bimbo che sa di divino, un miracolo nel miracolo di ogni nuova vita.
Una scena sacra rappresentata in modo molto realistico come era sua consuetudine e con una tale ricchezza di simboli e significati come solo lui sapeva fare. Caso vuole oltretutto che,
probabilmente per motivi economici, l’abbia dipinto su tela di fiandra, quella usata per le tovaglie, conferendo così ancora più “domesticità” alla scena, mischiando ancor più il divino all’umano nella concretezza della realtà.
Questo quadro merita che ci si soffermi un po’ di più a conoscerlo. Siamo durante la fuga in Egitto, un viaggio condotto da Giuseppe per amore del figlio e di Maria poiché “I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: -Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò-“.
Dunque ancora una volta Giuseppe è chiamato a fidarsi e ad avventurarsi verso una terra sconosciuta.
Caravaggio immagina che il Signore voglia premiare l’obbedienza di Giuseppe inviando loro un angelo che sia di conforto e di conferma; lui gli regge lo spartito, come segno della collaborazione dell’uomo al progetto divino.
I suoi occhi sono a fianco dell’occhio incuriosito dell’asino, animale devoto e servizievole, pronto a rendersi utile. Giuseppe è seduto su un sacco di grano con a fianco una damigiana, simboli eucaristici del pane e del vino.
Il viaggio della Sacra Famiglia è metafora del viaggio della vita, che qui parte dalle asperità di un terreno arido e sassoso per poi diventare, dall’angelo in poi, terra ricca e rigogliosa. L’angelo stesso ha le ali di rondine, simbolo della primavera e quindi della Resurrezione.
Ai piedi di Maria ecco l’alloro, simbolo di gloria e immortalità perché sempreverde; rovi e cardi, simboli della Passione di Cristo e il tasso barbasso, emblema della Resurrezione. Dietro, a fare da appoggio, una quercia, una pianta forte e che contiene in sé sia i semi maschili che femminili, quindi simbolica delle maternità di Maria, concreatrice col Signore di una vita umana e divina.
Il violino suonato dall’angelo ha una corda spezzata, riferimento alla precarietà e all’ imperfezione della vita umana, ma questo non gli impedisce di far riecheggiare le note di un mottetto sul tema del Cantico dei Cantici. Proprio non molto tempo fa infatti è stata riconosciuta in quelle note dipinte la composizione scritta da Noel Bauldewijn nel 1519 per musicare i versetti “Quanto sei bella e quanto sei graziosa, carissima mia, in mezzo alle delizie. La tua statura somiglia a una palma e a grappoli somigliano i tuoi seni… Una torre d’avorio è il tuo collo. Vediamo se la vigna è tutta in fiore, se i fiori partoriscono la frutta, se sono tutti in fiore i melograni. Il mio seno in quel luogo ti darò.”
Maria viene rappresentata tutta in riferimento al Cantico: i capelli rossi “Le chiome del tuo capo sono come la porpora del re” e il suo capo appoggiato al bambino “Io dormo ma il mio cuore veglia”.
Sullo sfondo, il cielo cupo si rischiara in lontananza, per dirci che la vita è sì fatica, cosparsa di imprevedibili variabili come ben sa qualsiasi famiglia, ma ogni vita ha uno scopo, un senso, una meta… e custodire le tante e svariate forme di nascita che la vita di una coppia genera, è lo scopo prioritario. Questo richiede che si sappiano usare tutti i cinque sensi, come indicato in questo quadro, per poter scorgere ciò che è promessa invisibile agli occhi, che necessita della capacità di mettersi in gioco, di fidarsi e rimanere in viaggio aprendosi alle novità che la vita propone… così da darsi la possibilità di intuire che davvero “la vita di un uomo passa di nascita in nascita” (Christian de Chergé).
Mi immedesimo nello sguardo di Giuseppe, il volto stanco e segnato dalla fatica dei tanti sforzi di partenze e ripartenze nell’incertezza, ma nel contempo i suoi occhi ed i suoi gesti dicono disponibilità e affidamento. Provo a fare memoria di una o due circostanze in cui ho fatto questa esperienza del mettermi comunque in viaggio pur nella fatica vincendo il desiderio di rimandare o desistere. Osservo e considero quanto è avvenuto.
Riguardando alla stessa o alle stesse circostanze di cui sopra, metto in campo la vicinanza dell’altro/dell’altra. Quanto l’amore che ci unisce è stato motore per il cammino fatto?
Quanto l’essere due, o tre, o più, ci ha dato forza per ripartire dopo il riposo pur nell’incertezza della meta?
Ritorno allo sguardo di Giuseppe, fisso sul volto dell’angelo del Signore. E lì sosto in preghiera a fianco dell’amata, dell’amato, in silenzio, così da riuscire a cogliere le note del Cantico e custodire quanto di nuovo sta nascendo in noi.

Il film è tratto dall’omonimo libro della scrittrice Valeria Parrella e racconta, con delicatezza e intensità, l’esperienza autobiografica dell’autrice a cui è nata una figlia prematura.
È la storia di una donna adulta che rimane incinta senza averlo preventivato e che partorisce improvvisamente a sei mesi di gestazione: la bambina che ha dato alla luce viene messa dentro un’incubatrice dove, le dicono i medici, dovrà restare per almeno due mesi.
Maria è costretta quindi a fermarsi e a vegliare questa figlia che è nata ma la cui fragile esistenza è appesa a un filo: riuscirà a vivere oppure non ce la farà? La presenza della bambina nel mondo, la sua nascita, è allo stesso tempo anche assenza.
Nell’attesa, Maria non può fare niente o almeno lei pensa di non riuscire fare niente; la sua vita di prima, i suoi impegni quotidiani, la sua illusione di controllo e di indipendenza (è infatti una donna sola, volitiva ed energica) cambiano radicalmente, investiti da questo evento imprevedibile che la mette in uno stato di precarietà e la costringe a sentire in un modo più profondo e sottile la propria interiorità ma anche a sviluppare una sensibilità particolare verso il mondo che la circonda e i piccoli gesti umani che gli altri hanno in serbo per lei.
Come la protagonista del film prima della nascita di sua figlia, a volte anche noi non siamo in grado di notare e di provare gratitudine per ciò che ci circonda perché troppo concentrati su noi stessi e sulla nostra vita materiale e non solo, in un movimento incessante e a volte cieco.
Il film ci propone un’esperienza non solo visiva e narrativa ma anche contemplativa, poiché è
scandito da momenti musicali e quasi onirici, in cui lo spazio bianco dell’incubatrice, dove la
piccola Irene sta lentamente formandosi, è anche lo spazio bianco di una donna che sta per
diventare madre e che deve maturare questo nuovo spazio dentro di sé: Maria deve rinascere come persona nuova, come sua figlia Irene sta aspettando di nascere una seconda volta.
La rinascita di Maria è momento di attesa, di pazienza nervosa che diventa gentile, in cui Maria faticosamente ma senza mai guardarsi indietro impara a guardarsi intorno e a guardare in modo nuovo ciò che la circonda.
E noi come affrontiamo le esperienze gioiose o dolorose della nostra vita? Siamo presi dalla frenesia e dall’impazienza oppure riusciamo a fermarci e magari a vedere quelle esperienze come un’opportunità di rinascita?
E quando l’attesa è legata a una situazione di sofferenza, come viviamo questo tempo? Forse potremmo anche riconoscere l’attesa come la possibilità di vedere un segno che ci aiuti a rintracciare un senso, chiedendoci “Where is my love?” (Dove è il mio amore?), il ritornello di una canzone del film.
• Regia: FRANCESCA COMENCINI
• Interpreti: MARGHERITA BUY, GAETANO BRUNO
• Anno: 2009
• Paese: ITALIA
• Durata: 98 min.
• Disponibile su: AMAZON PRIME VIDEO, GOOGLE PLAY, YOUTUBE, TIM VISION, APPLE TV
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
«Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno…»
(Tobia 8,6)
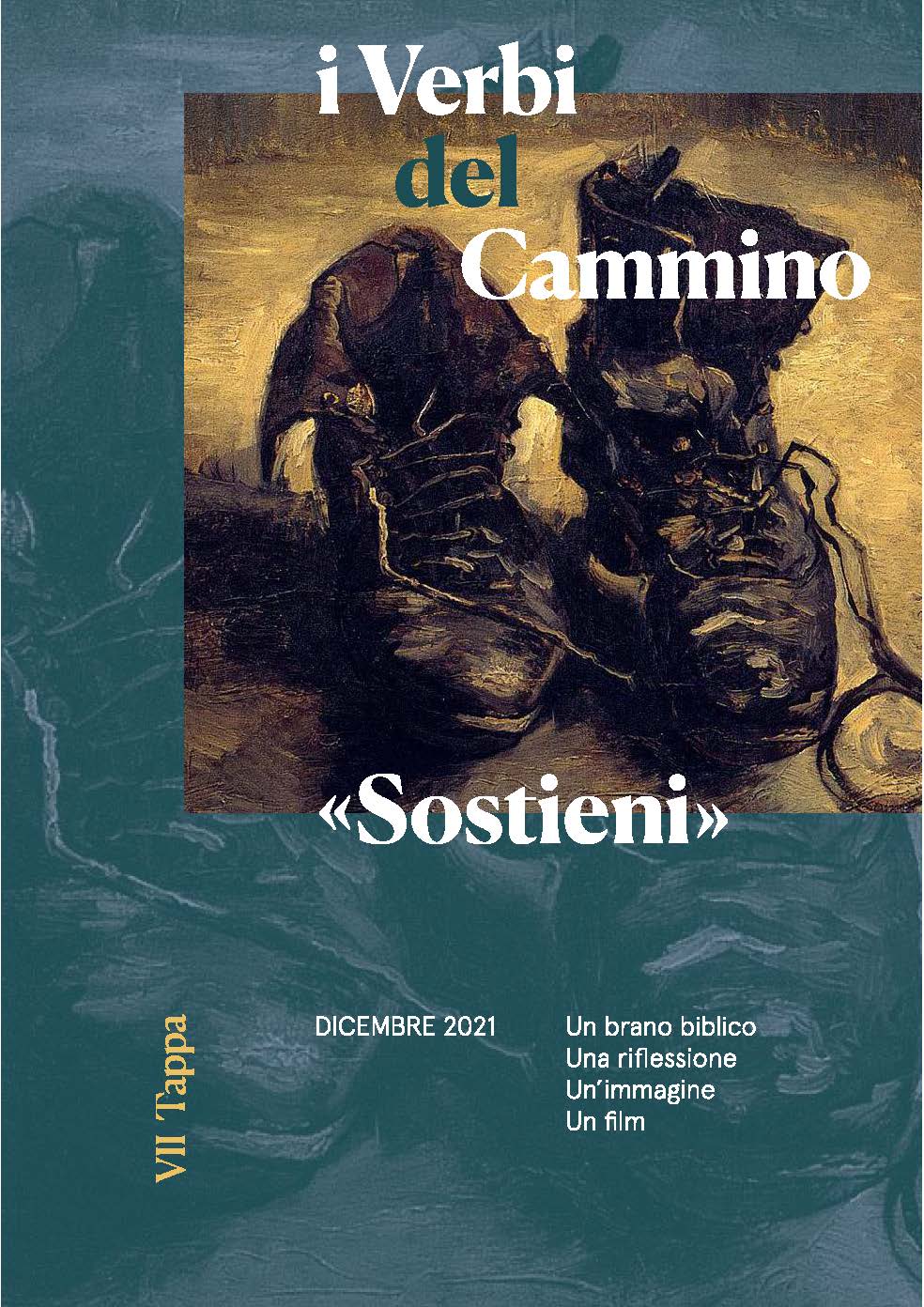
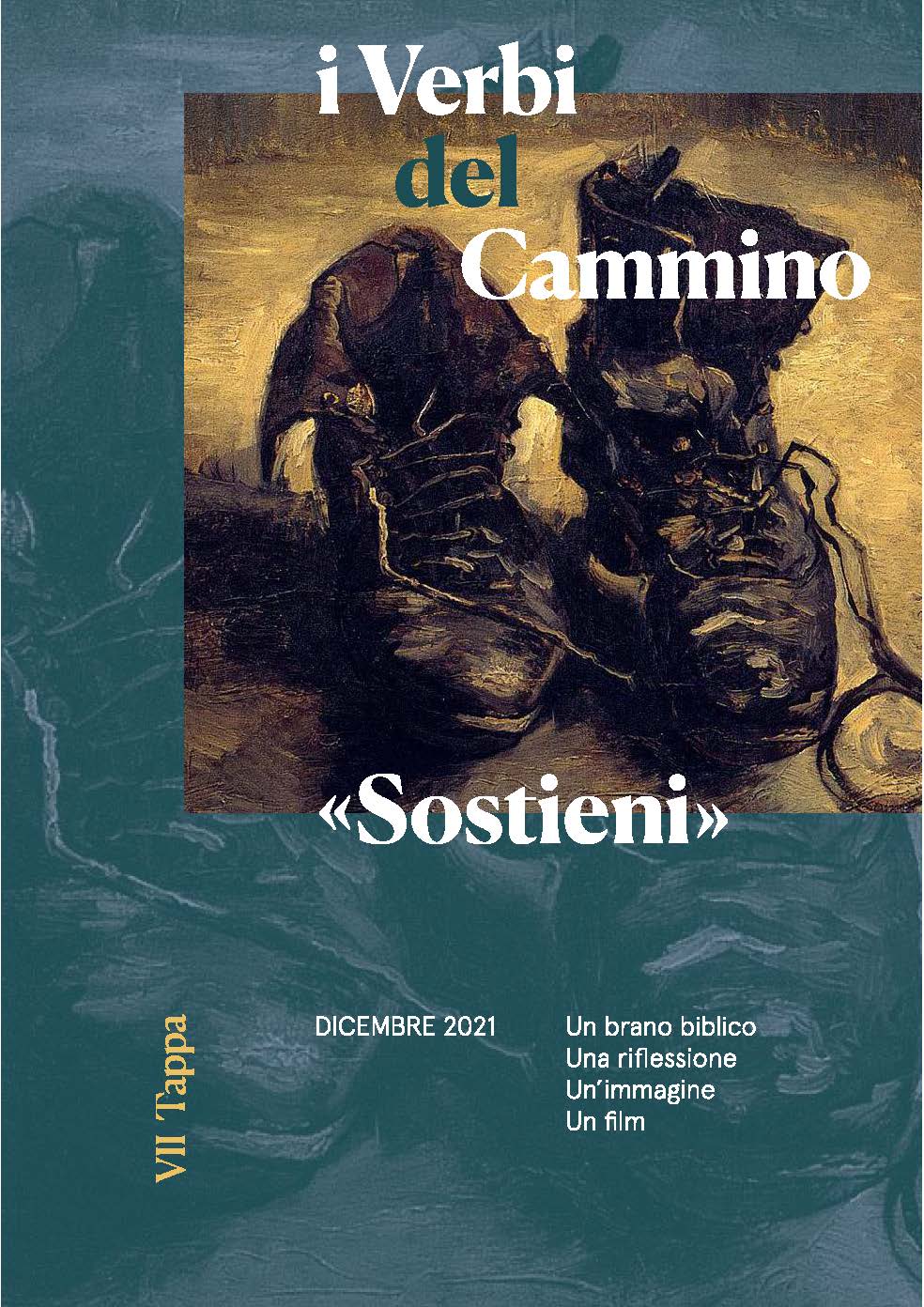
«Tu hai creato Adamo
e hai creato Eva sua moglie,
perché gli fosse di aiuto
e di sostegno…»
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
Luca 10,25-37
25«Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. 26Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. 27Costui rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso”. 28Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. 29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. 30Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. 37Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”.
Proporre la parabola del buon Samaritano a commento del verbo ‘Sostieni’ può forse portarci immediatamente a fermare la nostra attenzione sul gesto con cui il protagonista della parabola si fa carico dell’uomo lasciato mezzo morto dai briganti.
In realtà Gesù, con questa narrazione, si sta facendo carico (sta sostenendo) anche del dottore della Legge che lo sta mettendo alla prova.
25«Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Il dottore della Legge sembra preoccupato di mettere alla prova Gesù, di tendergli una trappola con la propria domanda, più che di ascoltare in autenticità la risposta del suo interlocutore a proposito nientedimeno che della vita eterna.
Il modo di porsi di questo scriba ci interroga sul modo in cui noi entriamo in dialogo con le persone facendoci forse scoprire che può non esserci estranea la tendenza di ricercarvi l’affermazione di noi stessi e delle nostre opinioni piuttosto che la verità.
26Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. Per prima cosa Gesù rifiuta la logica oppositiva sottesa dalla domanda del dottore della legge.
Inoltre, rinvia lo stesso dottore alla religione dei padri come fonte e norma della verità. Essendo il suo interlocutore un dottore della Legge, è come se Gesù rinviasse questa persona alla sua
competenza; lo rinvia, in una parola, a sé stesso. È un bel modo di ‘sostenere’: non sostituirsi
all’altro ma dargli fiducia.
27Costui rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso”. 28 Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Il dottore della legge accetta il dialogo, cosa non scontata. Accetta di essere interrogato, deponendo forse l’ostilità che lo aveva contraddistinto all’inizio.
Nella sua risposta afferma che quanto proposto nella Legge è l’inseparabilità dei due amori. Il fatto stesso che nella seconda frase non venga ripetuto l’Amerai sottolinea l’intimo legame dei due comandamenti.
Non è forse anche questo un modo di affermare il ‘sostenersi’, qui nell’ambito dei due amori? Per dirla con le parole di Giovanni: «Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: “Io amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (1Gv 4,19-21).
La totalità è la misura dell’amore di Dio; il «come te stesso» è la misura dell’amore del prossimo.
Ma non è forse quest’ultima misura a impedirci di fare di noi stessi o dell’altro un idolo e, quindi,
ancora una volta, a sostenerci, salvando la reciprocità?
Il dottore della legge si era alzato per mettere alla prova un altro uomo; ora vediamo che sa che nella legge c’è scritto di amare il prossimo. Pian piano sembra che, sostenuto dall’amore e dalla pedagogia di Gesù, la verità che già conosceva diventi sempre più e sempre meglio sua vita («Osserverete dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà», Levitico 18,5).
Gesù sostiene il suo interlocutore adottando anche il suo punto di vista e il suo linguaggio (fare … vita/vivere)..
29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. La nuova domanda del dottore della Legge sembra supporre una esperienza di resistenza, una volontà di mettere dei paletti, di tracciare una sorta di confine tra chi è il mio prossimo e chi non lo è, mettendo con questo i paletti al mio amore nei suoi confronti.
30Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Gesù risponde anche alla nuova domanda, un modo con il quale mostra anche come ami quel prossimo che gliel’ha appena posta.
Risponde con una parabola, con una narrazione cioè con cui coinvolge il proprio interlocutore chiamandolo a trovare dentro sé stesso la risposta.
«Un uomo scendeva...»: non importa che uomo sia: il prossimo non ha confini.
«Per caso». Per strada e per caso … Quanti nostri incontri decisivi sono avvenuti e avvengono così! In quali modi umanamente impensabili Dio e la vera vita ci vengono incontro!
Il sacerdote e il levita vedono e passano oltre. Quell’uomo mezzo morto non li riguarda; sembra essere più un ostacolo che una possibilità.
33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Il Samaritano viene proposto come modello: un paradosso! La lezione al sacerdote e al levita viene data dall’impuro, dall’eretico. Il bene lo si trova là dove non lo si aspetta. Non è il solo caso nel vangelo di Luca (cf. il lebbroso, in Luca 17,16-18).
Il Samaritano si sente messo in questione dall’altro. La compassione provata dal Samaritano è il cuore di tutta la narrazione. Questo suo essere precede ogni suo fare, anzi è la sorgente del suo suo agire. Questa compassione non può essere ridotta a un mero sentimento o a una particolarità del carattere.
È in gioco la vita eterna. Non può essere una dote che uno si ritrova e un altro no: altrimenti il
comando finale di Gesù (v. 37) non avrebbe alcun senso.
La compassione è dunque un atteggiamento accolto e coltivato con il proprio impegno e la propria responsabilità, accettando che lo sguardo del Signore diventi sempre più e sempre meglio lo stesso nostro sguardo.
4Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. La compassione si fa gesto concreto che esprime cura. Amare il prossimo è aiutarlo a vivere.
35Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno” Il Samaritano suscita un altro come lui, un altro capace di sostenere. Non fa tutto da solo.
36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. Di nuovo Gesù, l’interrogato, pone una domanda allo scriba (l’interrogante), capovolgendo la domanda di partenza. In sostanza, il ‘prossimo’ non è l’altro che in tanti modi incontro; ‘prossimo’ è la mia vocazione nei confronti di ogni altro che incontro. ‘Prossimo’ definisce me stesso nella mia chiamata a divenire tale e non la condizione dell’altro.
Non sono chiamato a chiedermi chi sia l’altro nei miei confronti, mettendo magari dei paletti per cui chi è oltre non mi riguarda; sono chiamato invece a chiedermi chi sono io nei confronti dell’altro, e la risposta è semplice: sono il suo prossimo. Io sono chiamato a farmi prossimo di chiunque.
Sono chiamato a sostenere il bisogno di vita presente nell’altro e, al contempo, l’altro sostiene il mio desiderio e la mia ricerca di umanità vera, autentica.
La domanda del dottore della legge aveva di mira il prossimo, quella di Gesù ha di mira il dottore nella legge affinché scopra la chiamata a diventare prossimo.
Del resto, in questo dialogo non è lo stesso Gesù a farsi prossimo dello scriba che, ferito dal suo stesso male, lo sta interrogando?
37Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”. Ciò che spinge il Samaritano a farsi prossimo è la partecipazione allo stesso amore di Dio (cf. Luca 7,13; 15,20).
In questo modo scopre la sua vera identità accogliendo quella parola di Dio che è la carne stessa del povero in cui si è imbattuto e di cui si è scoperto essere il prossimo.
«Così Dio non è soltanto colui che, presente nel povero, sollecita l’amore comandandolo; è ancora colui che, presente in chi vede il povero, comunica l’amore come principio del libero gesto di prossimità» (Armido Rizzi).
M’incanta l’immagine che trovo nella direzione finale del Cantico. Un’immagine che spesso
attraversa improvvisa i miei pensieri e anche i miei umori soprattutto quando, inaspettati, sembrano prendere il sopravvento. Un’immagine insieme dinamica e statica, dove non c’è nulla da aggiungere, nulla da ritoccare, tutto è in equilibrio, tutto è compiuto e anche ciò che viene dopo in sé raccoglie semplicemente
quell’immagine: “Chi sta salendo dal deserto, appoggiata al suo amato?” (Cantico 8, 5).
E vorrei possederne con gentilezza il senso senza l’ansia di capire e vorrei non essere solo a coglierne la suggestione. Il deserto delle parole spiana la strada alla bellezza del gesto semplice, rapido, come un volo leggero d’ali che si appoggia a sostegno della corrente.
Sappiamo per conoscenza e insieme per esperienza che spesso l’appoggio viene meno e che la vita continuamente ci richiama a nuovi posizionamenti nella ricerca di nuovi equilibri, nuova stabilità.
Ma ogni volta si aggiunge un po’ di fatica come di chi ogni stagione si misura abiti sempre più stretti. Eppure l’appoggio è possibile e ci è vicino, lo sappiamo, lo vediamo, ma bisogna passare attraverso la forma interrogativa, bisogna che accada un riconoscimento.
Chi è colui, colei che sale dal deserto? E’ vero è una domanda che punta direttamente all’infinito ma è anche una domanda dalla quale non è possibile sottrarsi. E allora quanta fiducia serve per sostenersi fidandoci di chi ci sostiene?
Troppo spesso ci inceppiamo in un sovraccarico di parole, di discorsi infiniti e di scavi nell’anima propria e dell’altro appesantendoci così in un reale senza suggestioni, senza incanto, senza poesia.
Quanto ci scomoda abbracciare il sostegno dell’altro? Quanta fatica ci costa riconoscere che senza l’altro la vita è più faticosa, semplicemente più triste? E allora…
Sostienimi con il tuo respiro,
affinché ogni cosa trasudi di te.
Ancorami alle tue carni,
affinché l’ultimo dei respiri
possa all’infinito prolungarsi
La vita trasforma ogni cosa
e il tempo non conosce resa
ed è un susseguirsi di stanze
ognuna con un’impronta scolpita, diversa
e ne distinguo appena i contorni
Ma da qualche parte è possibile
so che è possibile, ripararsi
dalle gelide intemperie
Un rifugio qualsiasi, come di chi
nella notte intravede una salvezza
E non chiedo molto di più,
un semplice riparo, un riparo per ripartire
magari anche senza di te,
(non è detto che dureremo una vita intera)
ma so che il nostro sostegno, uno per l’altra,
anche solo per un solo attimo,
basta per una vita intera

Per sostare sul verbo “sostieni” ci lasciamo condurre dalla pittura metafisica di Giorgio de Chirico (1888-1978). Anche questo quadro, come molti altri suoi, rappresenta il concetto di uomo senza volto tipico di quella corrente, con figure di manichini sproporzionati e senza volto né espressione ma che pur riescono a far percepire attraverso gesti e postura uno stato d’animo e, in questo caso, mostrano ciò che li abita. Ecco infatti comparire nei loro addomi rovine antiche, segmenti di colonne, tempietti, porte ad arco… tutti elementi che appartengono al suo stesso passato. Lui infatti era nato in Grecia, e, nonostante il suo trasferimento in Italia, le sue radici rimasero ancorate profondamente alla terra ellenica. Ecco anche il significato del titolo: infatti, il compito dell’archeologo è quello di serbare il passato, di proteggerlo e di farsene portavoce.
Andando oltre il contesto pittorico del quadro e lasciandoci far ispirare da esso, possiamo dire che non è forse questo un compito che ciascuno di noi ha verso se stesso e verso le persone più care e più vicine? Vivere il presente è innanzi tutto imparare a conoscersi, sapere cosa ci abita, saper guardarsi dentro e riconoscere i tanti frammenti della propria storia, saper dar loro un nome. E siccome la vita ha origine da affetti e ci conduce ad altri nuovi affetti, quando ci si relaziona con gli altri, è imprescindibile ricordare che ciascun altro è abitato da ricordi e frammenti esattamente come noi. È importante però porre sempre attenzione a non improvvisarsi psicoterapeuti né di se stessi né degli altri, né tantomeno giudici.
Sostenersi vuol dire sapersi fermare l’uno accanto all’altra, appoggiati in un abbraccio che dice presenza, ed aprirsi in un dialogo sincero e profondo. Sostenersi vuol dire accostare con amore e discrezione i propri mondi interiori perché vengano accolti e direzionati verso un futuro in cui ci si riconosce e ci si sente riconosciuti. Sostenersi vuol dire aiutarsi a scorgere tra le ombre dei frammenti del passato, quali spiragli di luce intravediamo come possibili e già presenti.
Non è cosa scontata fare questo, tanto meno con chi si ha a fianco nella condivisione della vita, degli affetti, dell’educazione dei figli, con chi abbiamo imparato a conoscere giorno dopo giorno e abbiamo l’impressione di saper già tutto di ciò che lo abita. Ma intimamente sappiamo che sostenersi non è stare affiancati dandosi per scontati; sostenersi richiede vigilanza, cura, attenzione per aiutarsi a crescere e guardare con senso a nuovi orizzonti.
Scelgo tra i tanti frammenti di vita che mi abitano uno che oggi vedo come fatica. Poi ne scelgo uno che oggi vedo come risorsa ancora spendibile.
In un secondo momento mi siedo a fianco dell’altro/dell’altra ma con la possibilità di guardarsi negli occhi, e consegno quanto ho scelto. L’altro fa lo stesso. Poi consegniamo al Signore quanto ho scorto in me e quanto ho ascoltato dall’altro, senza dibattito, non subito, prima si lascia sedimentare. Solo in un secondo momento si condividerà quali sentimenti sono emersi nell’osservazione di sé e nell’ascolto dell’altro. Sempre ricordando bene con quale attenzione e cura gli archeologi maneggiano i frammenti di passato.
Sosto nel desiderio del passeggiare come nel quadro, lo affido in preghiera, poi muovo i primi passi perché questo possa avvenire.

Ali è un giovane uomo con esigenze basilari: procacciarsi un luogo dove poter stare con suo figlio, il piccolo Sam, che gli è appena stato affidato dalla madre del ragazzino, sparita per non ritornare più; riuscire a nutrire sé stesso e suo figlio con un lavoro.
Il tetto glielo offre sua sorella, nella modestissima casa di periferia dove vive con suo marito. Dato il fisico prestante che si ritrova e grazie a una certa abilità nella boxe, il primo posto di lavoro che si trova assegnato è di addetto alla sicurezza in un locale notturno. Qui, in seguito a una rissa, conosce Stéphanie, una donna sua coetanea, bella e sicura di sé, addestratrice di orche in un parco di divertimenti acquatici. Ali si offre di accompagnare la donna a casa, perché non è nelle condizioni di guidare. Una volta arrivati a destinazione, tenta goffamente un approccio con lei, tentativo che fallisce prima ancora di cominciare.
Poco dopo, Ali, sempre guidato dal proprio istinto brutale di sopravvivenza e senza porsi troppe domande, riesce a trovare un lavoro migliore, come agente di sicurezza nell’azienda di sua sorella; si occupa poco del figlio, a cui pensa la zia, si allena e intrattiene rapporti ferini con le donne che gli capitano a tiro.
Intanto, durante uno dei consueti show davanti alla platea entusiasta del parco divertimenti,
Stéphanie cade vittima di un incidente gravissimo: in breve, si ritrova in un letto d’ospedale con le bellissime gambe amputate.
Sola e disperata, Stéphanie fallisce nel tentativo di farla finita con una vita che non riconosce più come sua. Ormai reclusa come un animale ferito in gabbia, a un tratto Stéphanie decide di chiamare quel giovane rozzo e un po’ ridicolo che l’aveva accompagnata a casa qualche tempo prima: come se avesse bisogno di un rapporto con un individuo naturalmente più elementare di lei.
E Ali risponde alla sua chiamata. Con una spontaneità che sconfina in una ruvidezza a volte terribile, l’uomo si fa letteralmente e fisicamente carico di lei: la porta sulle proprie spalle fuori dall’appartamento nel quale si è rinchiusa negandosi alla vita.
L’uomo riporta il corpo mutilato di lei alla luce del sole, all’aria, all’acqua. Ali va anche a letto con Stéphanie, generosamente ma sempre con modi rozzi, animaleschi. Questa routine vitale, ma anche priva delle attenzioni e della tenerezza di cui una relazione ha bisogno, diventa faticosa per l’ex addestratrice di belve feroci, che non riesce ad addomesticare la selvatichezza a volte disumana di Ali, tanto da preferire un ritorno alla propria solitudine.
L’eccesso di brutalità e cinismo porta Ali lontano da tutti, da sua sorella, da Stéphanie, persino da suo figlio Sam, fino a quando un destino crudele non lo fa piegare a terra, non lo costringe ad entrare in contatto con quel centro emotivo, caldo e pulsante, con il quale Stéphanie, prima di lui, ha già dovuto fare i conti. Così sarà lui a sentire il bisogno del sostegno di lei, un sostegno diverso, che funziona con una forza differente e più sottile ma di cui lui non può fare più a meno se vuole rimanere in piedi.
Bisogna provare l’esperienza della caduta per accettare di avere bisogno dell’aiuto dell’altro: questo il senso che arriva forte come un pugno allo spettatore dalla storia di due personaggi a cui manca qualcosa, una parte importante di sé. Bisogna diventare consapevoli della propria fragilità, delle proprie carenze, se ci si vuole offrire in aiuto alla fragilità e alle carenze dell’altro.
La storia di Un sapore di ruggine e ossa ci vuole dire che per sostenere davvero qualcuno, e non essere solo la stampella di un momento, bisogna anche accettare di essere sostenuti, in uno scambio vicendevole.
Solo quando Ali riconoscerà il proprio profondo bisogno di amore, lui potrà stare a fianco a Stéphanie da uomo, con la dolcezza e l’attenzione che ogni essere umano può dare e allo stesso tempo merita di ricevere.
![]() Film per un pubblico adulto
Film per un pubblico adulto
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
«Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie…»
(Tobia 8,6)
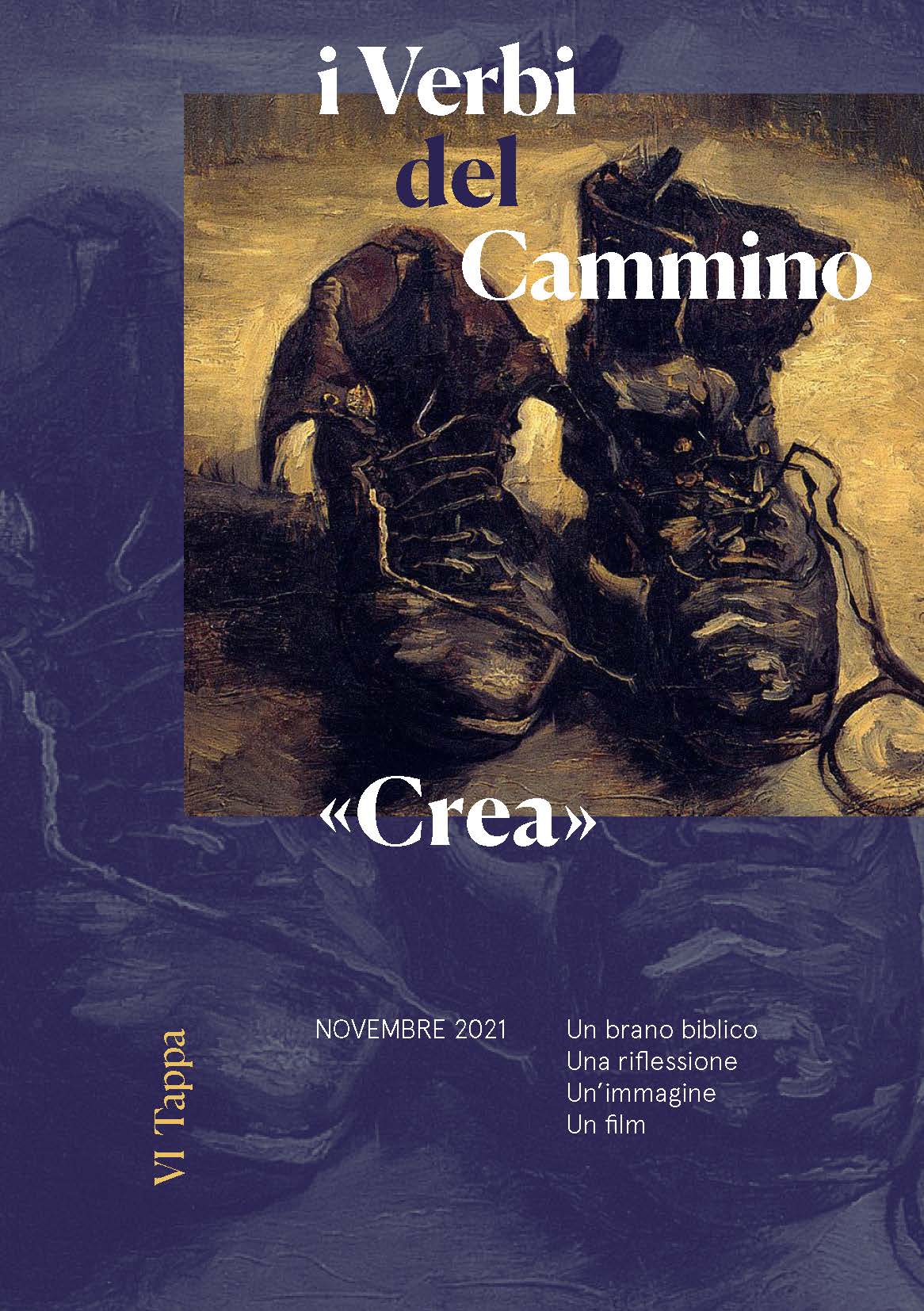
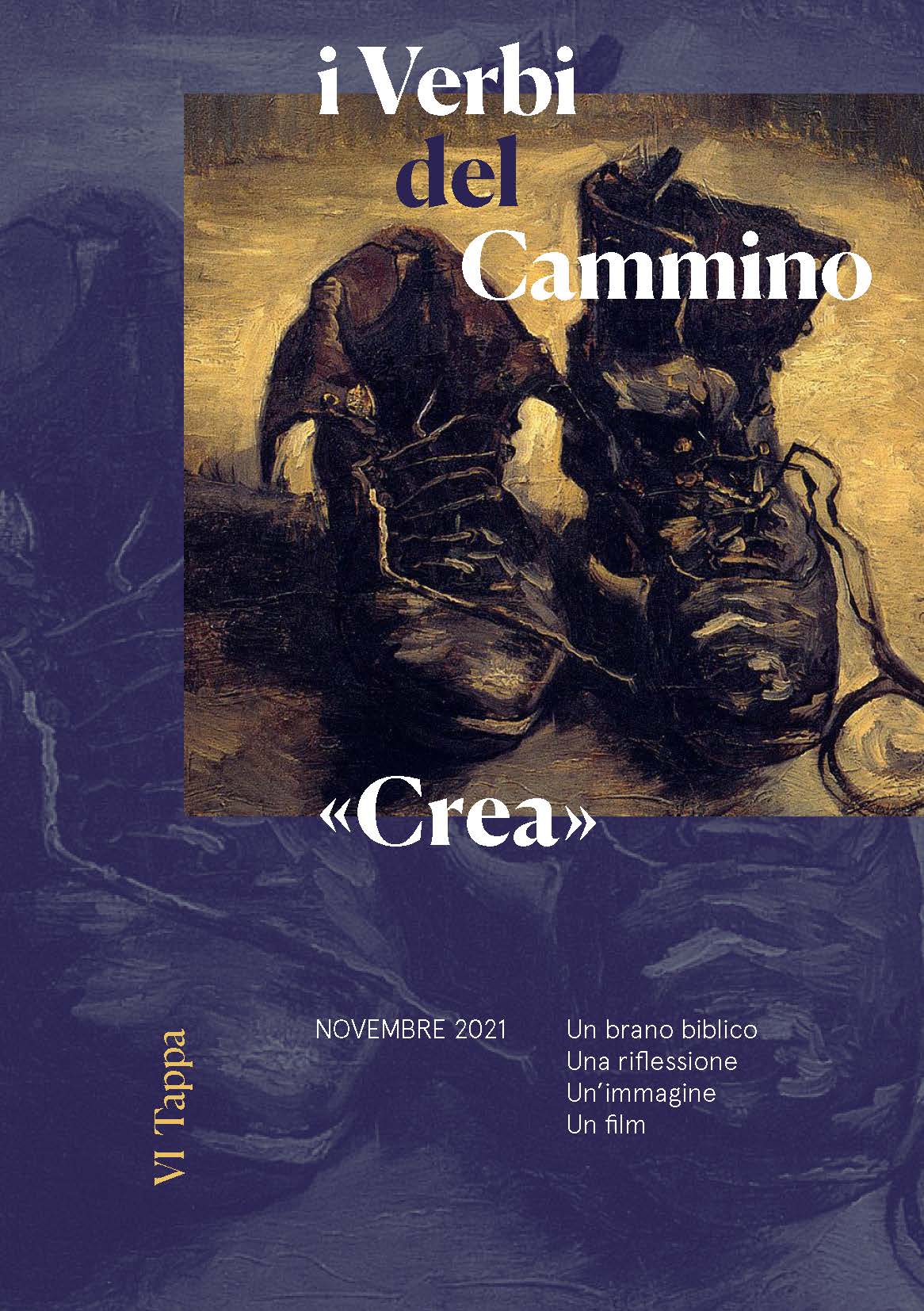
Tobia 8,4-8
4b«Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza”. 5Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia”. 8E dissero insieme: “Amen, amen!”»
Due citazioni per indicare la prospettiva di queste righe. La prima: «L’uomo è creato per…». Queste parole, incipit del ‘Principio e fondamento’ degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Loyola (n. 23), ci consegnano una verità semplice ed essenziale, e cioè che l’uomo è creato. Nessun essere umano si crea da solo: veniamo al mondo grazie ad altri e come dono possiamo accoglierci. Detto in altri termini, la nostra verità fondamentale è che siamo figli e che nessuno di noi è l’origine di sé stesso.
La seconda: «La vita di un uomo passa di nascita in nascita». Possiamo applicare questa frase del trappista francese Christian de Chergé a Nicodemo come figura emblematica per esprimere evangelicamente il verbo a tema. Possiamo infatti leggere le tre volte in cui compare Nicodemo nel vangelo di Giovanni come tappe successive della generazione/creazione dello stesso ad opera del Signore Gesù.
Giovanni 3,1-17
1«Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 2 Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui”.
3Gli rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio”. 4Gli disse Nicodèmo: “Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. 5Rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito”. 9Gli replicò Nicodèmo: “Come può accadere questo?”. 10Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? 11In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 15perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Di notte. A Gerusalemme. Un dialogo tra due uomini. L’interlocutore di Gesù è un fariseo, uno dei capi dei Giudei.
Il capitolo successivo di Giovanni si aprirà con un altro incontro. A mezzogiorno. In Samaria. Un dialogo tra un uomo e una donna. L’interlocutrice di Gesù sarà una Samaritana, “eretica” e dalla condotta morale non ineccepibile.
Gesù si lascia incontrare sempre, ovunque, da chiunque. E ognuno può essere ri-generato, ri-creato dall’incontro con Lui.
L’incontro notturno tra Gesù e Nicodemo ci fa toccare con mano come il Signore sia continuamente all’opera per creare dei figli. Nel colloquio con Gesù Nicodemo fa infatti esperienza del cammino che Gesù gli apre davanti come una possibilità nuova, forse nemmeno sperata, ma tanto desiderata, come si evince dal prosieguo della sua storia.
Infatti, l’opera di creazione non avviene in un attimo. È un cammino che richiede perseveranza e pazienza, che conosce le sue tappe e dura tutta una vita. Significative in questo senso saranno le altre due apparizioni di Nicodemo nel vangelo di Giovanni.
Vv. 1-3 / Essere nella notte vuol dire non essere ancora nato. Il senso di questo testo è farci venire alla luce.
Per vedere il regno di Dio e per entrare in esso dobbiamo essere generati dall’alto. Dio è Padre e nel suo regno entrano i figli, non gli schiavi. In questo modo Gesù contrappone la generazione, il fatto vitale del nascere a una vita nuova, all’osservanza della legge. L’amore non lo si merita: lo si accoglie. Credere in Gesù, il Figlio, vuol dire fondare la propria esistenza sul fatto che siamo figli, accettandosi come dono d’amore, invece che sui propri obblighi religiosi; due strategie di vita completamente diverse.
Vv. 4-8 / Gesù dice che non si tratta di nascere di nuovo (“dall’alto” si potrebbe tradurre anche con “di nuovo”: spessissimo Giovanni usa gli equivoci, e Nicodemo ne è una espressione), bensì di nascere in altro modo.
Nascere dallo Spirito designa esattamente questo altro modo: cioè, nascere dall’Amore e all’amore. Lo Spirito, invisibile come il vento, lo si può riconoscere dai suoi frutti: «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Galati 5,22).
Vv. 9-17 / Essere generati dice qualcosa di più del semplice nascere. Indica anche la relazione con chi ci genera ed è questa relazione che ci fa vivere, non semplicemente l’essere nati. È l’amore che ci crea continuamente: la vita è donata e noi viviamo del dono.
Non corrisponde forse a verità che quando facciamo esperienza di gratuità (ricevuta e data) facciamo esperienza di rinascita?
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio per questo mondo: Gesù sarà il Figlio dell’uomo innalzato, il Messia che porta su di sé il male dell’uomo per amore dell’uomo. Sarà colui che ama i figli con lo stesso amore del Padre rendendo possibile una vita fraterna vivibile qui e ora. Sarà colui che ci fa capire che Dio ci
ama infinitamente fino a dare la vita per noi.
La vicenda di Adamo ed Eva in Genesi 3 ci rende consapevoli che il principio dei mali è il non accettare di essere amati, di essere figli: «il serpente ha il veleno nella bocca» (Silvano Fausti).
Contemplando Gesù che ci ama fino ad identificarsi col nostro male senza giudicarci comprendo finalmente chi è Dio: è uno che mi ama infinitamente. E comprendo chi sono io.
Gv 7,45-53
«45Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: “Perché non lo avete condotto qui?” 46Risposero le guardie: “Mai un uomo ha parlato così!”. 47Ma i farisei replicarono loro: “Vi siete lasciati ingannare anche voi? 48Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? 49Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!”. 50Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 51“La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”. 52Gli risposero: “Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!”. 53E ciascuno tornò a casa sua.
In questo secondo passo in cui compare nel vangelo giovanneo, Nicodemo prende le difese di Gesù, o meglio invita i capi dei sacerdoti e i farisei ad ascoltarlo prima di emettere un giudizio su di lui. È un consiglio saggio e onesto che però non verrà accolto.
Ma al di là di questa mancata accoglienza l’intervento di Nicodemo rivela il suo coraggio e la sua capacità di distinguere la propria opinione da quella di tutti gli altri, accettando anche parole umilianti nella consapevolezza però di essere rimasto fedele a se stesso e rispettoso dello Sconosciuto, e pagando di persona tutto questo. Nicodemo non si omologa all’opinione corrente. Non è forse questo un passo verso la luce?
La storia di Nicodemo non si è dunque conclusa in quella prima notte. Il suo cammino sta continuando. Segno, questo, che possiamo anche interpretare come un esempio del modo in cui il Signore agisce, crea: non “buttando via” niente e nessuno ma offrendo continuamente nuove possibilità. Non era stata questa anche l’esperienza del profeta Geremia presso il vasaio? «Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto» (Geremia 18,3-4).
Gv 19,38-42
38Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. 39Vi andò anche Nicodèmo - quello che in precedenza era andato da lui di notte - e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. 40Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 41Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. 42Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Pochi versetti prima, l’evangelista aveva affermato che uno dei soldati con una lancia aveva colpito il fianco, di Gesù e subito ne erano usciti sangue e acqua (cf. Gv 19, 34). Come dal fianco di Adamo Dio creò Eva (Genesi 2,21-22), così, dal fianco squarciato di Gesù, il Padre crea e ri-crea continuamente i suoi figli. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo sono tra i primi.
È la terza volta che Nicodemo compare nel vangelo ed è qui che si compie la sua creazione. Egli si espone davanti a tutti e viene finalmente e definitivamente alla luce.
Quella che è l’ultima tappa del suo cammino coincide in realtà con quella che è la sua e la nostra origine: l’amore di Dio per noi, principio e fondamento della nostra vita. Quel Dio che nessuno ha mai visto (Giovanni 1,18) si rivela sulla croce senza più possibilità di equivoci.
Togliendo Gesù da dove questi era stato innalzato Nicodemo viene generato dall’alto. Tra i primi ad essere attirati dal Gesù innalzato (cf. Giovanni 12,32) Nicodemo può ora volgere lo sguardo a colui che è stato trafitto (cf. Zaccaria 12,10). Siamo generati, creati quando siamo amati.
Nicodemo accompagna Giuseppe di Arimatea nel pietoso servizio di deporre Gesù dalla croce e di dargli sepoltura. È bello e significativo che Nicodemo non sia solo. La creazione non è una faccenda privata ma, se autentica, è sempre comunitaria: veniamo generati al contempo come figli e come fratelli.
«Nascere non basta.
È per rinascere che siamo nati.
Ogni giorno».
(Pablo Neruda)
Tu puoi soltanto attendere
Il tempo è incerto. In bilico il sereno
e la pioggia. Ma né l’uno né l’altro
dipendono da te.
Tu puoi soltanto attendere, scrutando
segni poco leggibili nell’aria.
Ti affidi al desiderio
ascoltando il timore. Le tue mani
sono pronte a difendersi e ad accogliere.
Così non sai quando Dio ti prepari
una gioia o un dolore e tu stai quasi
origliando alla porta del suo cuore,
senza capire come sia deciso
da quell’unico amore,
lo splendore del riso o delle lacrime
Renzo Barsacchi (1924 )
È bello interagire con un testo poetico. Da più di trentacinque anni a scuola, con i miei alunni, cerco di fare null’altro che questo. Perdo volutamente per strada analisi formali, strutture metriche per lasciare soltanto spazio alla
voce lirica, alla melodia leggera del verso poetico. E mi piace ancor più provocare gli alunni soprattutto quando la poesia altera equilibri, crea sconquassi, quando il testo ci sta stretto o magari ci troviamo apertamente in disaccordo.
La poesia è questo: accordo e disaccordo, partecipazione e lontananza, presenza e assenza. Sempre comunque una opportunità impareggiabile per interagire con il mondo e con se stessi.
Detto questo veniamo al testo di Barsacchi, grande poeta vivente (ci sono ancora poeti viventi, pochi ma ci sono!). Mi è venuta alla mente la sua poesia, una poesia limpida, musicale, genuinamente piana, perché ci pone di fronte al tema del “Creare” descrivendo esattamente il suo contrario. È vero, l’attesa è la nostra condizione esistenziale, è la condizione che ci è data o forse che dobbiamo pagare per avere in cambio la vita. Ma tutto non si esaurisce lì.
L’uomo non è artefice di un volere superiore indipendente dalla sua volontà. Dio non ci ha pensati e non ci pensa in questo modo. L’atto creativo rende plausibile il dono della vita che come qualsiasi dono deve essere segno di una relazione, di una reciprocità. Senza il nostro atto creativo la sostanza stessa delle cose viene meno.
Origliamo alla porta del cuore di Dio non per rapire un segreto a noi proibito ma per imparare l’arte di inventare ciò che non è ancora, per diventare a sua immagine creatori di vita e sapienza. Dobbiamo crederci e non essere semplici recitanti adagiati in una passività senza soluzioni.
Tutto è ancora da inventare, da creare. Non ci è dato solo di attendere ci è dato di partecipare mani e piedi alla grande avventura della vita. Lo splendore del riso e delle lacrime è più dolce e anche meno amaro se l’invenzione di Dio incontra l’estro inesauribile della volontà umana.
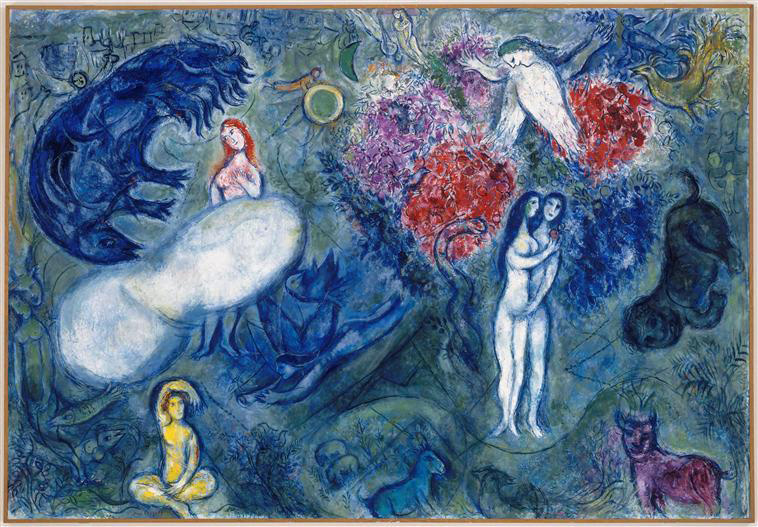
Ci proviamo ad introdurre in una delle 17 grandi tele sul tema del messaggio biblico dipinte da Chagall intorno alla metà del ‘900, poi donate nel ’66 alla Francia ed esposte al Museo del Messaggio Biblico da lui stesso allestito nella città di Nizza.
Il colore dominante è quello delle prime ore del mattino perché tutto è ancora all’inizio, tutto è ancora da scrivere… La vegetazione è avvolta dal verde-azzurro della rugiada, quel fitto ma sottile manto acquoso che sarà alimento per l’erba durante le ore calde della giornata. E’ così che il Signore trasforma il deserto in giardino, con piccole ma costanti goccioline notturne.
Ecco, in questo contesto di vita nascente muovono i loro passi Adamo ed Eva, l’uomo e la donna creati da Dio a sua immagine e somiglianza, affiancati l’uno all’altra in un abbraccio che li unisce. “I due saranno una carne sola” recita il libro della Genesi.
Sono nudi, nulla di nascosto tra di loro, si svelano l’uno all’altra per quello che sono, per come sono ed in questa verità si relazionano. I piedi scalzi, perché il loro camminare sia attento e consapevole perché tutto sia più percepibile… l’erba, la vegetazione, il giardino creati da Dio, il corpo dell’altro creato da Dio. I piedi scalzi perché il loro sia un camminare leggero e se anche può accadere che uno calpesti i piedi dell’altro non li può ferire.
L’uomo e la donna sono dunque in cammino, i corpi in intima relazione uno a fianco dell’altra.
La loro è presenza reciproca e sopra di loro c’è la presenza discreta e premurosa di un angelo mandato da Dio per affiancarli nei loro passi nel giardino, nella loro :vita proteggendoli dall’alto con la sua ombra. L’angelo, contornandoli di fiori e del loro profumo, porge loro il sole perché siano scaldati dal suo tepore.
Intorno, altre creature popolano il giardino pesci, uccelli, altri animali… per ricordare che l’uomo e la donna fanno parte di un progetto di creazione vasto, che contempla tante forme di vita. Alcune creature sono più positive, altre hanno l’aspetto più minaccioso, almeno apparentemente, forse perché non facilmente riconoscibili, come quello strano animale che pare soffiare, ricurvo su se stesso, proprio dietro alla donna. Tra tutti, ecco seduta a terra una figura di uomo, di colore giallo, il colore che identifica la natura divina dell’uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio; è seduto come in posizione di yoga e sembra inviti a danzare alla vita…
L’uomo e la donna. Il loro essere insieme, una sola carne per la vita è rappresentato da una sorta di “bozzolo” , quella specie di nube bianca lì, da una parte, proprio vicino alla donna e a quello strano animale… E’ come un nucleo primordiale che racchiude e protegge i germogli dei loro desideri dei loro progetti di vita. Alla donna, almeno nell’interpretazione di Chagall, è dato il compito di custodirli e difenderli da quello strano e indefinito animale che rappresenta forse le nostre paure, quelle che ci immobilizzano e ci annebbiano sogni e desideri.
Ma se Adamo ed Eva, l’uomo e la donna creati ieri come oggi per dare nuova vita, sapranno continuare a camminare nel giardino mantenendo la capacità di gustare il profumo dei fiori e i loro colori e percependo nel calore del sole il tepore di Dio, sapranno allora accogliere l’invito a danzare e custodiranno gelosamente i loro progetti e i loro sogni senza lasciarsi fermare da paure fuorvianti di non vita, di immobilità… perché si fideranno dell’amore che li trascende e lo renderanno nuova creazione.
Faccio memoria di alcuni momenti in cui ho camminato a fianco dell’altro, dell’altra, gustando una sensazione di creatività, di progettualità di vita, in cui passeggiando affiancati abbiamo assaporato tutta la bellezza del sentirci creati per guardare a prospettive di futuro sentendoci fino in fondo parte di un progetto di creaturalità ampio ed accompagnato. Provo a ricordare non tanto il cosa ci si era detti, quanto la sensazione di piacevolezza che si era provata. Constato come in quei momenti siano stati maggiormente degli sguardi alti ad abitarci piuttosto che timori e paure.
Considero senza alcuna volontà di giudizio quanto si sono ripetuti nel tempo questi momenti, quanto ancora continua ad abitarci il desiderio di progettualità quando ci lasciamo andare in un camminare affiancati sentendoci amati da Dio.
Sosto nel desiderio del passeggiare come nel quadro, lo affido in preghiera, poi muovo i primi passi perché questo possa avvenire.

Una coppia che vive in un piccolo appartamento a Santa Monica in California, un giorno, per mantenere la promessa fatta a un cane, decide di cambiare radicalmente la propria vita e di realizzare un sogno quasi impossibile per delle persone prive di qualsiasi esperienza nel campo, ovvero creare una fattoria biologica in armonia con la natura.
Da qui inizia il suggestivo documentario autobiografico “La fattoria dei nostri sogni” (il titolo originale è “The Biggest Little Farm”) che segue il percorso di John e Molly nell’arco di otto anni, dall’acquisto, anche grazie a finanziatori che credono nel loro progetto, di un ampio terreno a nord di Los Angeles, quasi desertificato dalle monoculture e dall’agricoltura intensiva fino a quando le cose iniziano veramente a funzionare: con l’aiuto di un esperto di agricoltura tradizionale, trasformano gradualmente un luogo arido e morto in un’area brulicante di vita sotto l’insegna della biodiversità.
Nel corso degli anni, la coppia deve affrontare molti flagelli naturali, dai coyote che sbranano le galline alle lumache che si nutrono delle piante coltivate, dagli stormi di uccelli che banchettano con la frutta degli alberi agli afidi che popolano i campi fino ai cambiamenti climatici, ma tutti questi problemi – come imparano non senza fatica e tante preoccupazioni – diventano anche delle opportunità per guardare alla natura come a un ecosistema alla ricerca costante di un equilibrio instabile perché la coesistenza con la terra non può essere forzata e occorre imparare a danzare con essa, senza pretendere di controllarla.
Per Molly e John, la fattoria diventa una grande scuola di creatività a contatto con la natura: creando una nuova realtà che prima non esisteva, imparando ad affrontare creativamente gli ostacoli che si pongono sul loro cammino senza ricette precostituite o facili scorciatoie e anche riuscendo a plasmare con coraggio e fantasia una nuova identità personale e di coppia. Una piccola grande storia con meravigliose immagini della natura, adatta a tutta la famiglia.
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
« Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano icieli e tutte le creature per tutti i secoli! »
Vi informiamo che le pubblicazioni de i Verbi del cammino riprenderanno nel prossimo mese di ottobre.
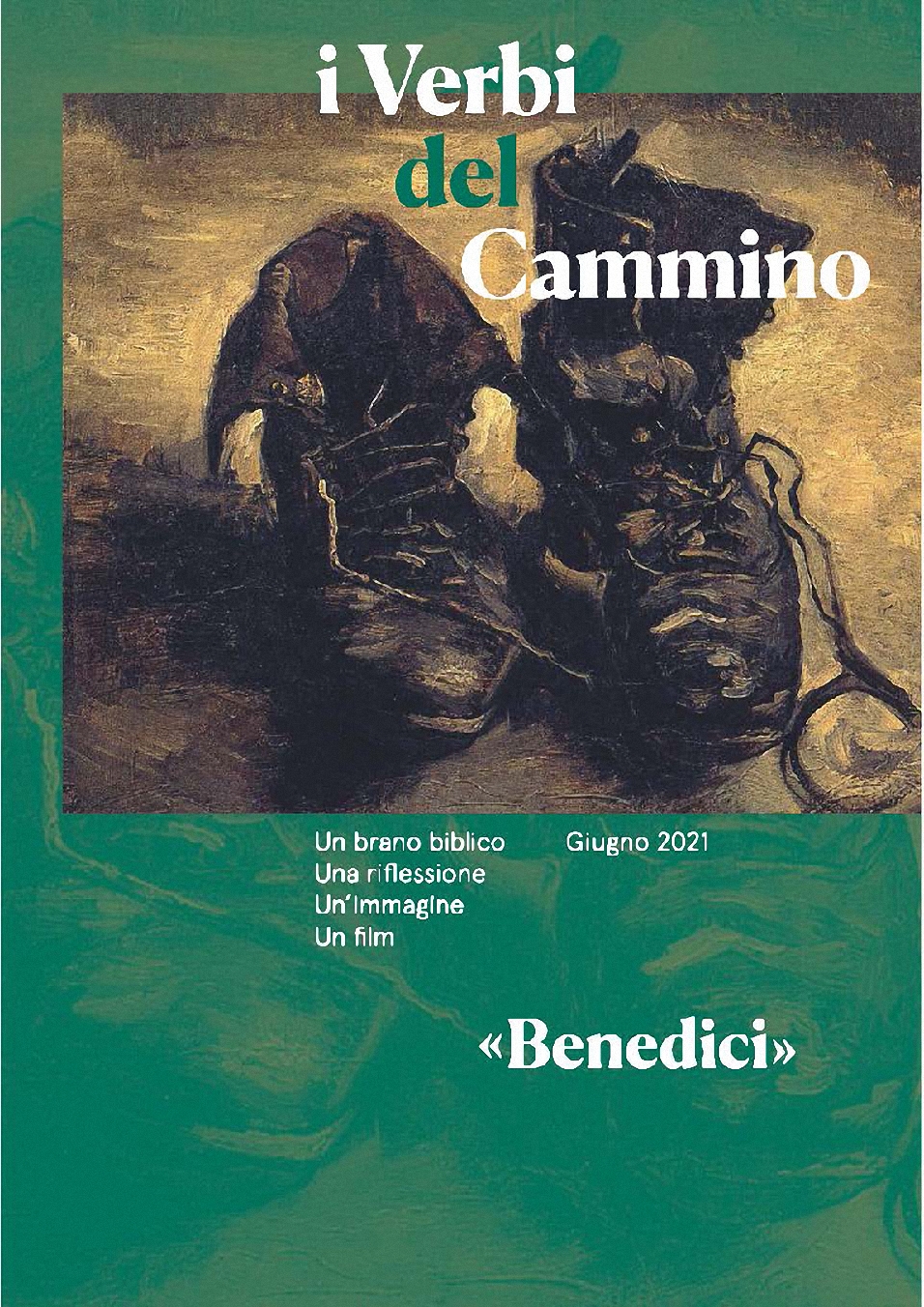
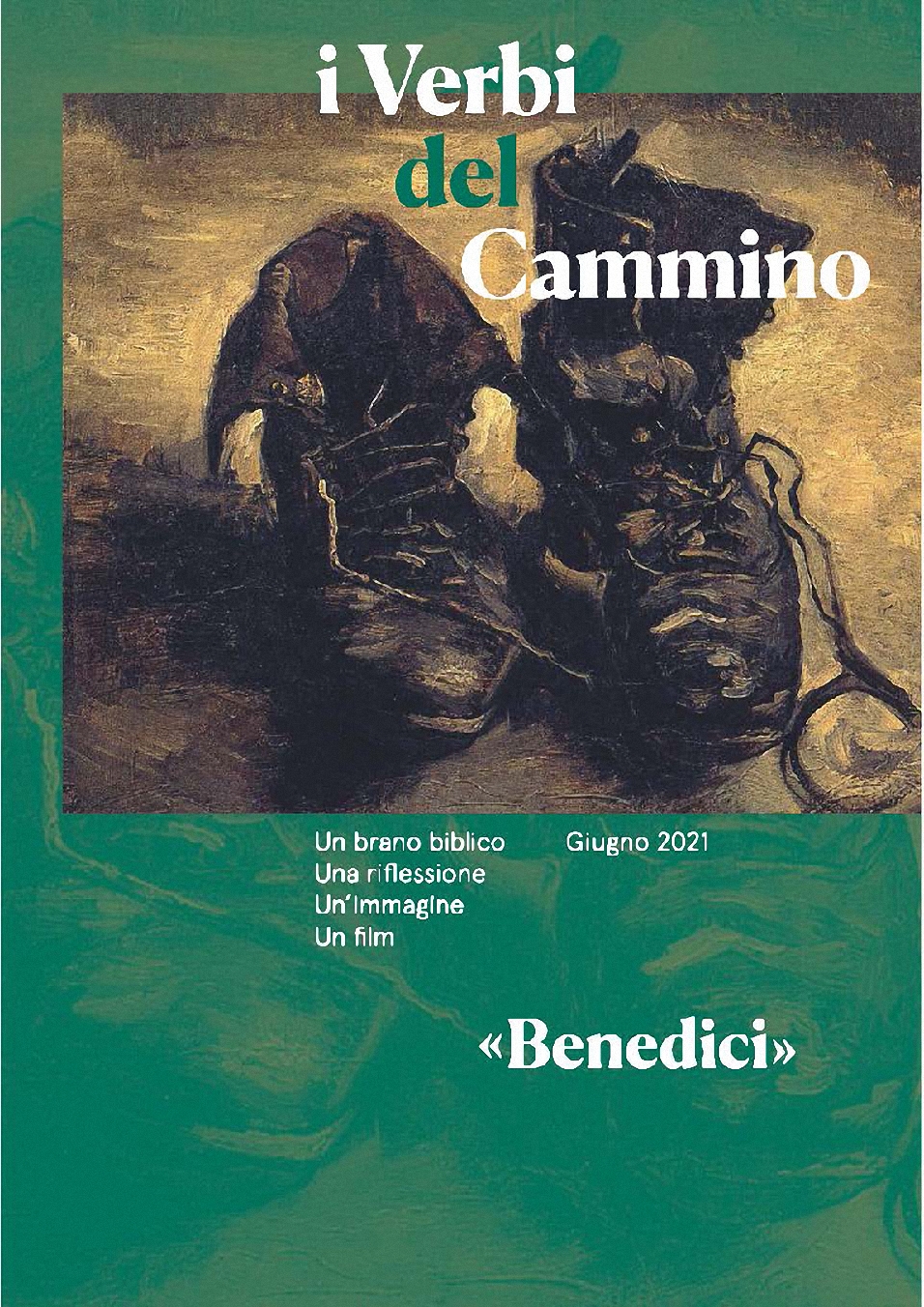
Tobia 8,4-8
4bTobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza».
5Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli!
6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui.
7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d’intenzione. Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia».
8E dissero insieme: «Amen, amen!».
Luca 1,59-45
«In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto”»
Nell’incontro di Maria ed Elisabetta contem¬pliamo gesti di vita e parole di benedizione.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda / L’angelo Gabriele, prima di lasciare la casa di Nazaret, aveva indicato il segno a Maria: «Ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio» (Luca 1,36-37). E Maria non esita: si alza e parte portando nel suo grembo il bambino appena generato in lei. Per dire che Maria si alza l’evangelista Luca usa uno dei verbi che utilizzerà anche per indicare la risurrezione di Gesù. Il concepimento del Figlio porta con sé la rinascita della Madre.
Maria parte, prende l’iniziativa. La visita ricevuta da parte del Signore non è vissuta da lei come un privilegio, magari contro altri, ma, all’opposto, come un dono anche per gli altri. Non attende che altri vengano a renderle omaggio. È lei che muove il primo passo. Lei, visitata dal Signore, visiterà Elisabetta.
Maria parte, e con lei parte Gesù. In questo modo Maria diventa anche simbolo di ogni nostra cammino missionario, ovunque siamo: camminare verso gli altri portando loro Gesù.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta / Come l’angelo Gabriele era entrato nella sua casa, così ora Maria (con Gesù nel grembo) entra nella casa di Zaccaria e di Elisa- betta (con Giovanni nel grembo).
Gesù in questo modo inaugura la sua nuova economia: quella di un Dio che ci visita e che si rende presente lì dove noi siamo. Qualcosa di analogo sperimenterà più avanti anche Zaccheo e, con lui, tutti noi chiamati ad accogliere Gesù che si invita a casa nostra. E Zaccheo lo accoglierà, animato dalla stessa fretta di Maria (Lc 19,5). Altra richiesta non ha l’amore se non quella di essere accolto.
Gli incontri veri dicono sempre qualcosa di più rispetto a quello che si vede, così come l'incontro tra Maria ed Elisabetta dice anche dell'incontro tra il Messia e il suo precursore.
Ci sono saluti formali e saluti che profumano di salvezza e di vita nuova, di pace vera. Il saluto di Maria viene ricordato ben tre volte. Non ne conosciamo le parole esatte, conosciamo però la sua portata nel cuore di Elisabetta.
Questo incontro è stato preparato dall'angelo Gabriele, inviato prima nel tempio di Gerusalemme e poi nella casa di Nazaret, perché poi su queste montagne della Giudea le persone visitate si potessero finalmente incontrare. Così opera il Signore secondo Luca: basti pensare ai Due di Emmaus e Pietro (Lc 24,55-35), a Saulo e Anania (At 9,17), a Pietro e Cornelio (At 10,3- 4.10-14.25-27): tutte persone incontrate in tanti modi dal Signore anche perché a loro volta si potessero incontrare creando comunione e fraternità.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
/ Prima ancora che Elisabetta possa pronunciare una parola viene raggiunta da due doni: il saluto di Maria e lo Spirito Santo.
Il solo vedere corre sempre il rischio di farci fermare all’apparenza; l’ascoltare raggiunge le nostre profondità. Forse anche per questo Bonhoeffer in "Vita comune” scrive che il primo servizio nella comunità di fede è quello dell’ascolto.
Come Elisabetta ascolta il saluto di Maria, così il bambino nel suo grembo accoglie la visita del Bambino che è nel grembo di Maria, con una danza che richiama quella di Davide davanti all’arca (2Sam 6,14).
Prima Dio ha visitato Maria attraverso l'angelo, ora visita Elisabetta attraverso Maria. Lui è sempre in cerca di noi, in tanti e diversi modi. Con Gesù è la Sua visita definitiva.
ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!" / Queste parole sono il frutto dell’accoglienza dello Spirito Santo, del dare spazio alla vita divina in noi.
Sono parole così semplici che ripetiamo ogni volta pregando l’Ave Maria e al contempo sono parole così belle e profonde che solo lo Spirito ce le può suggerire e far dire.
Pronunciando queste parole Elisabetta mostra di guardare alla vita così come Dio aveva guardato alla Sua opera creatrice riconoscendone la bontà e la bellezza (Gen 1).
Inoltre mostra di aver vinto logiche di gelosia e di invidia. Non si mette in concorrenza con Maria, come se fosse una rivale, in competizione.
Elisabetta esulta per una cosa bella operata dal Signore in Maria. Che libertà in questa donna che sa condividere la gioia di un'altra! Elisabetta è in grado di far propria la gioia di Maria. Sappiamo bene quanto in noi spesso si affaccino altre logiche; Pilato, per esempio, sa bene che Gesù gli è stato consegnato «per invidia» (Mt 27,18 e Mc 15,10).
Chi pronuncia parole come quelle di Elisabetta mostra di aver vinto in sé stesso la logica di Caino (Gen 4,5-8) e di essere entrato nello spirito della promessa divina ad Abramo («Benedirò coloro che ti benediranno», Gen 12,3).
Questo ci riguarda non solo come singole persone ma anche come comunità, come Chiesa. Giovanni, prima in lotta contro gli altri undici per la supremazia nel “Collegio apostolico”, si ritroverà alleato degli undici in lotta contro un uomo colpevole di ...fare del bene! (Lc 9,46- 50). Dove non arriva l’egoismo dell’individuo può giungere quello del gruppo.
Elisabetta benedice la madre e poi benedice il suo Signore, così come poi farà nel Tempio l’anziano Simeone (Lc 2,28.34). Saper dire bene di Dio e dire bene degli altri: quale invito da raccogliere e da incarnare sempre di più e sempre meglio nella nostra vita! Ci vengono incontro le parole dell’apostolo Paolo: «Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per un'opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,29-31). Riconoscere dinamiche disordinate dentro di noi non deve spaventarci o scoraggiarci (in ogni campo c'è sempre almeno un po' di zizzania: Mt 13,28-30), ma invitarci a non dare loro l'ultima parola e a chiedere il dono dello Spirito perché, come in Elisabetta, possiamo dare spazio a parole che sappiano edificare. Elisabetta non si fa metro di giudizio di ciò che avviene ma fa del bene questo metro di giudizio, ovunque sia compiuto e chiunque lo compia.
Queste parole della moglie troveranno eco nelle prime parole che suo marito Zaccaria pronuncerà non appena avrà riacquistato l’uso della parola («Benedetto il Signore, Dio d'Israele ...» Lc 1,68): si potrebbe affermare che, non solo il bene, ma anche il benedire irradia sé stesso.
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? / È il grido di stupore di chi accoglie un amore gratuito, incondizionato. Siamo amati non perché siamo buoni ma perché è buono Colui che ci ama e coloro che a Lui si sono affidati.
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo / Anche il bambino che è nel grembo di Elisabetta gioisce: piena sintonia tra madre e figlio nel dare lode a Dio.
E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto / Non bastasse la benedizione, ecco ora anche la beatitudine. Elisabetta loda la fede di Maria nella parola che il Signore le aveva detto.
La fede di Maria ha contribuito a portare il Signore e, con Lui, la pienezza di un umanità benedicente su quelle alture di Giudea.
(I. Silone, Vino e pane)
Benedire ogni cosa senza distinzione, senza lasciare nulla indietro, senza lasciare spazio a possibili contorte interpretazioni.
Benedire sempre e comunque anche se spesso non capiamo e vorremmo fuggire pur di non cadere in ulteriori parole.
Benedire lo spazio che ci separa perché permette di guardarci dritti negli occhi e sorriderne al più piccolo movimento.
Benedire ciò che non capiamo, anzi benedire due volte ciò che non capiamo perché sicuramente la prossima volta ci sarà più chiaro.
Benedire le tue mai e benedire le mie mani come se non avessero accarezzato altro, come se non avessero fatto altro che accarezzare, perché non c’era altro da fare.
Benedire le parole dette e soprattutto quelle non dette perché sono state quelle più efficaci e non hanno ferito nessuno, sono rimaste lì immacolate e salvate.
Benedire di te ogni cosa e anche quella leggera curvatura del collo dove ripetutamente mi sono perso, sabbie mobili di pensieri e poi improvvisa una via di uscita.
Benedire i piedi, benedire una due tre volte i piedi e poi benedirli ancora, instancabile appoggio del cammino e benedire il lavoro di tenerci dritti, in equilibrio e danzare là dove serve danzare oltre ogni equilibrio.
Benedire quello che ci è dato di vedere e soprattutto ciò che non vediamo, che solo immaginiamo e sapere che tutto va oltre e che la nostra sapienza è lì a portata di mano, se solo osassimo un pochino di più.
Benedire il silenzio e anche l'ingenuo tentativo di violarlo, benedire la fatica di starci dentro nonostante tutto e sapere che questo è già molto. Benedire ciò che ci fa di ostacolo ad ogni benedizione e poi andare oltre, perché la vita benedice addirittura chi verrà dopo di noi perché sorprendentemente e inarrestabilmente...
Tutto l’Universo Obbedisce all’Amore.

Per interiorizzare il verbo benedire ci lasciamo trasportare dal quadro dipinto da Caravaggio che rappresenta la cena di Emmaus proprio nel momento in cui Gesù viene riconosciuto dai due discepoli per il suo atto benedicente. La scena è resa particolarmente intensa dal gioco di chiaroscuro che dona forza al quadro come solo Caravaggio sapeva fare.
Gesù è seduto di fronte, rappresentato senza barba secondo la tradizione bizantina della raffigurazione del buon pastore, probabilmente perché il pittore ha voluto renderlo non immediatamente riconoscibile neanche a noi, per portarci a riconoscerlo dal suo benedire il pane e il vino e a fare lo stesso percorso che hanno fatto i due discepoli.
La sua mano sollevata sulla mensa richiama visivamente quella del discepolo di destra che sembra quasi uscire dalla tela per introdurci nella scena. Le sue braccia sono allargate in gesto di grande sorpresa e così poste riproducono quelle di Gesù sulla croce; percorrono il dipinto in profondità collegando la zona in ombra con quella illuminata dalla luce, la luce della rivelazione, in un percorso che è testimoniato dalla conchiglia del pellegrino che porta sul petto.
L’altro discepolo per lo stupore si sta alzando dalla sedia, non può rimanere lì seduto ancora, deve rimettersi in movimento subito. Anche lui, rappresentato con sapiente tridi-mensionalità, visivamente ci introduce nella scena e ci fa sentire come invitati a notare che c'è un posto libero tra loro due, per noi.
L’unico rappresentato in piedi è l’oste che assiste con stupore ad una scena che non comprende, guarda un uomo che non può riconoscere.
Tutto si svolge ancora una volta a tavola, in una casa, in un contesto di quotidianità che potrebbe essere quello di tutti noi, delle nostre famiglie.
Il grande realismo di Caravaggio si fa interprete del contesto entrando nella loro casa e riproducendo alcuni rilevanti particolari che i suoi contemporanei gli avevano contestato, ma che hanno un significato profondo e sono un grande suggerimento teologico. Il primo, evidente, posto proprio in primissimo piano, è il buco nel gomito della maglia consunta del discepolo; Gesù gli si rivela cogliendolo così come, nella sua povertà.
E il discepolo stesso lasciando che sia visibile il buco della maglia è come se ci dicesse “vieni, avvicinati pure, non aver timore a prendere parte a tavola, non sentirti inadeguato e con il pensiero che prima devi andarti a cambiare, è adesso che sei invitato a sederti a tavola con il Cristo risorto e vivente, così come sei. Guarda me, non sono meglio di te.”
Anche il canestro di frutta ci presenta dei frutti imperfetti, con alcuni segni di deterioramento. Quello è quanto i due hanno da offrirgli e quello è quanto Gesù benedice. E il cestino stesso è posto in bilico sul bordo della mensa, segno della caducità della vita... la vita dei discepoli, la nostra, quella delle nostre famiglie che hanno bisogno della benedizione. Perché ben sappiamo che le nostre imperfezioni, i nostri strappi, i nostri fragili equilibri esposti alle imprevedibilità della vita che ogni famiglia conosce, hanno sete della benedizione, di sentir dire bene di ciò che si è e di ciò che si ha.
Hanno bisogno di sentirsi dire che ogni giorno è possibile percorrere la strada dal buio alla luce, che ogni giorno a tavola, se sappiamo condividere il nostro essere e i nostri frutti mettendoli così come sono e mettendoci in gioco così come siamo, è possibile chiedere insieme la benedizione e percepire la presenza del Risorto e di lì ripartire per continuare a camminare con più slancio e con nuova e più vitale disposizione d’animo.
Quel è il buco nella maglia che porto a tavola oggi, quale falla sono chiamato a mostrare per cominciare poi a rammendarla?
Guardo il cestino di frutta. Contemplo il suo inequilibrio e lascio che mi risuoni dentro. Percepisco la mia paura di cadere, il timore dellì'mprevedibilità della vita. Li affido alla mano benedicente di colui che è tornato per testimoniare che è la vita ad avere l'ultima parola là dove sappiamo mettere in gioco l'amore.
Provo a percepire l'incontenibilità dello slancio ad alzarsi dei discepoli. Da quale anche piccolo segno posso ripartire nelle mie giornate? Non eclatanti propositi che presto si scontrerebbero con la difficoltà del quotidiano, ma un piccolo gesto possibile che mi rimette in cammino sotto lo sguardo benedicente di chi è pronto ad affiancarci e camminare con me./p>

Il dono più potente che una benedizione possa operare è quello di bene - dire anche di fronte al male, di riuscire a volgere in bene ciò che nasce come male e farlo crescere e prosperare, quindi, in una direzione completamente diversa, se non proprio opposta a quella iniziale.
È possibile dire, quindi raccontare, spiegare e indirizzare un avvenimento luttuoso, un dolore terribile in modo che dal male (e quindi da una potenziale maledizione che potrebbe segnare le vite di uomini e donne) nasca invece un bene, il bene più grande, la vita? Si potrebbe affermare che in questo consiste il miracolo all'origine del Cristianesimo: operare un capovolgimento che trasforma la morte in vita. E il film che riesce, con una misura narrativa quasi perfetta, a raccontare questo processo stra-ordinario e molto umano è sempre una storia di ebrei, una storia che parla di una famiglia di ebrei ortodossi nell'attuale Stato d'Israele.
Il titolo internazionale del film, Fill the void richiama immediatamente il cuore tematico della storia: la protagonista è chiamata a riempire il vuoto, atrocemente lasciato da sua sorella, che potrebbe diventare l'origine di una tragedia familiare, nella quale i personaggi finiscono inghiottiti in un baratro oscuro di dolore e disperazione, distrutti dal male. Ma è proprio la scelta di non lasciare che questo vuoto rimanga lì, a divorare vite, che trasforma radicalmente un destino che sembra segnato.
Andiamo con ordine. Shira è una ragazza di appena 18 anni, vive nella comunità ebraica ortodossa di Tel Aviv, è la figlia minore di un rabbino importante nella sua comunità: un punto di riferimento per chi è in difficoltà, e un esempio anche per gli altri rabbini. Come da tradizione, Shira è destinata a fidanzarsi con un coetaneo scelto dalla famiglia. A differenza di quello che sarebbe normale e prevedibile in contesto sociale laico e occidentale (compreso quello di altre componenti della società israeliana), Shira è entusiasta della scelta della famiglia e non vede fora di sposare il ragazzo che ha intravisto a mala pena nella corsia di un supermercato.
In questo, è identica alle sue coetanee della comunità. Quando però sua sorella maggiore muore dando alla luce il primo figlio, la madre di Shira vorrebbe spingerla a sposare il vedovo. Il vuoto lasciato da Esther con la sua morte è insopportabile per la famiglia. L’unico loro appiglio, per riuscire a non naufragare, è il neonato figlio di Esther, che però rischia di allontanarsi per sempre nel momento in cui al padre vedovo si prospetta la possibilità di un matrimonio con una donna europea e il trasferimento in un altro continente.
Il matrimonio tra ex cognati appare come l'unica soluzione in grado di evitare il peggio ma si presenta una scelta condizionata da questioni che nulla hanno a che fare con i sentimenti e con la passione.
Shira deve affrontare un percorso di discernimento difficilissimo, mettendosi in ascolto della volontà di Dio, tenendo conto anche del dolore di chi le sta più vicino, dei suoi genitori ma anche di Yochai, il vedovo di sua sorella, un uomo più grande di lei e, come lei, perplesso e contrario, almeno all’inizio, a questa proposta della suocera.
Ed è qui che comincia il racconto di un delicato avvicinamento a Yochai, una reciproca esplorazione e scoperta. Alla fine, la scelta non sarà dettata da mera obbedienza a un’imposizione della madre (l’unica fermamente convinta, anche contro il parere del marito e di altri componenti della comunità) ma dalla consapevolezza che la necessità più drammatica può aprire prospettive impensabili e, se affrontate con cuore puro, trasformare il male in una benedizione per sé e per gli altri.
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
« … domandiamo al Signore nostro
che ci dia grazia e salvezza … »
Da’, nella sua immediatezza è un’affermazione
che dice, insieme, un’inderogabilità e una responsabilità.
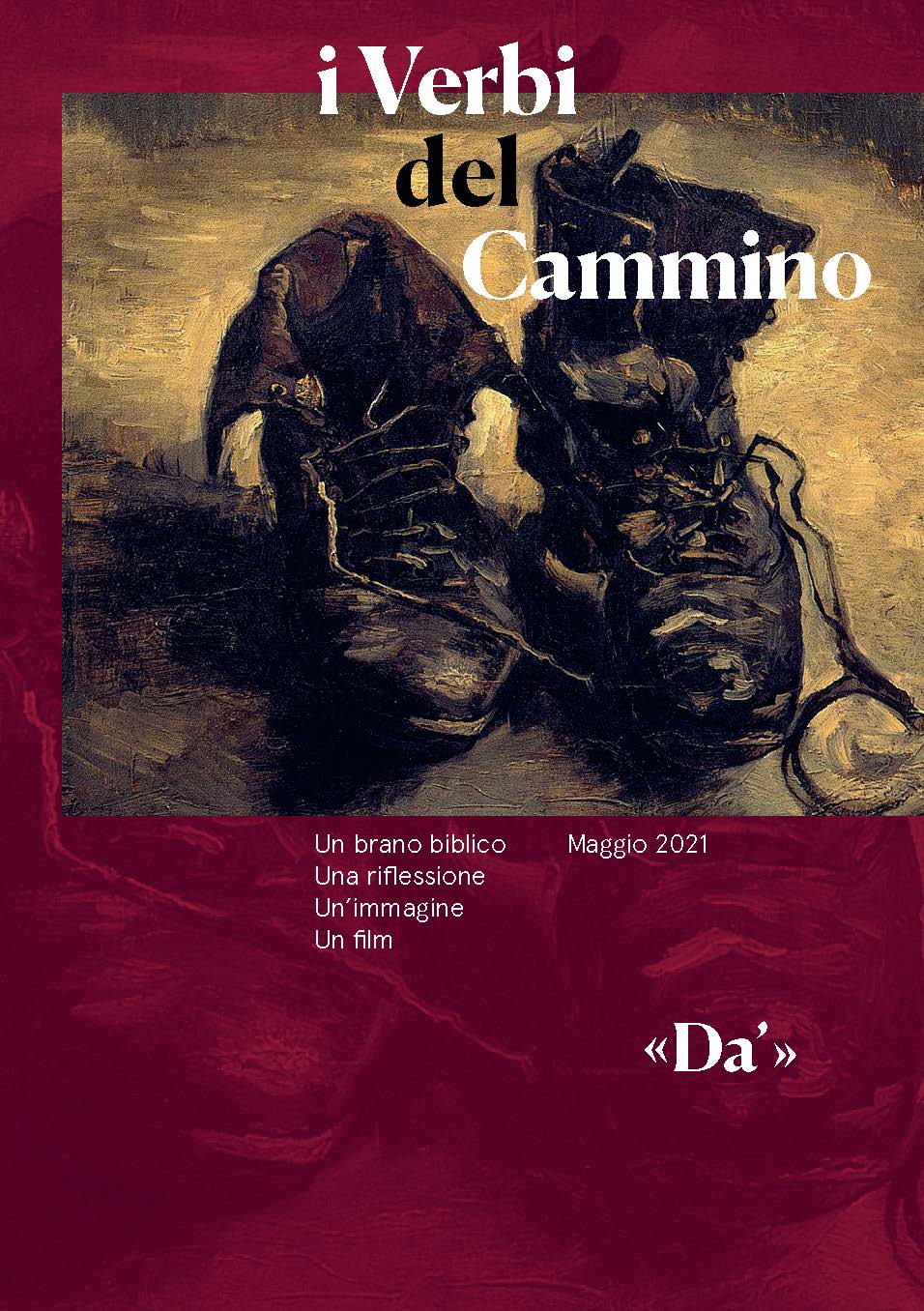
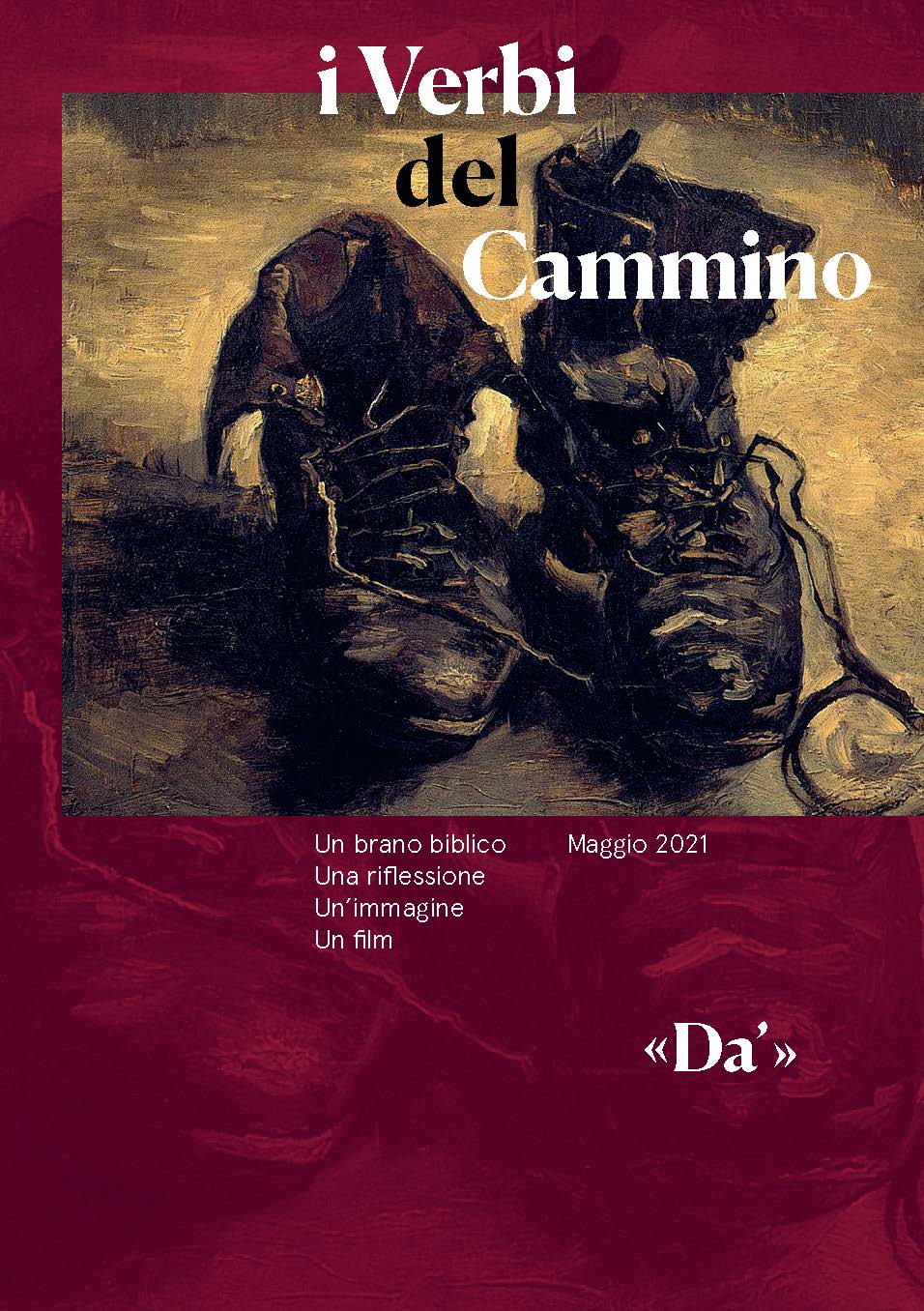
Tobia 8,4-8
4bTobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza».
5Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli!
6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui.
7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d’intenzione. Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia».
8E dissero insieme: «Amen, amen!».
Marco 6,34-44
«Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo:
“Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare”.
Ma egli rispose loro:
“Voi stessi date loro da mangiare”.
Gli dissero:
“Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?”.
Ma egli disse loro:
“Quanti pani avete? Andate a vedere”.
Si informarono e dissero:
“Cinque, e due pesci”.
E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta.
Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti.
Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci.
Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.»
Quello dei pani è l’unico segno compiuto da Gesù riportato in tutti e quattro i vangeli.
Questo dice della sua rilevanza.
Nel pane spezzato è racchiusa la vita stessa di Gesù, il senso della sua esistenza.
È il segno presente nella cosiddetta vita pubblica di Gesù, nella Passione (Cenacolo), nella risurrezione (Emmaus), nel tempo della Chiesa (Atti degli apostoli 2,42), in ogni nostra celebrazione eucaristica.
Riconosciamo Dio nel suo corpo dato per noi.
Lo stesso Vangelo è il Suo corpo e il Suo sangue dati, donati a noi: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» dice Gesù a Nicodemo (Giovanni 3,16).
Nel dare, soprattutto nel dare se stessi, si esprime l’amare.
Il brano che proponiamo costituisce un dittico col banchetto del compleanno di Erode, narrato da Marco appena prima, due banchetti che sono simboli di due diverse logiche di vita: nel palazzo di Erode si celebra l’economia del potere e del possedere, nel deserto quella dell’amare e del dare.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose /
Una grande folla: non i notabili, i “grandi”, che erano presenti al banchetto di Erode.
Il gregge senza pastore non può lasciare indifferente ‘il’ Pastore (cf. Numeri 27,16-17): lo muove a compassione («Vulnerasti cor meum», Cantico dei cantici 4,9).
Il primo nutrimento che Gesù dà è la Sua Parola.
Questo in piena linea con le parole del Deuteronomio («l’uomo non vive soltanto di pane, ma […] l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore» 8,3) e di Amos («”Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore Dio - in cui manderò la fame nel paese; non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore”.
Allora andranno errando da un mare all’altro e vagheranno da settentrione a oriente, per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno » 8,11-12).
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: “Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le campagne e i
villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare”. /
La situazione sembra sfavorevole: l’ora è tarda e il luogo è deserto.
Che sia tardi lo dice anche l’evangelista, come lo stesso evangelista, pochi versetti prima, aveva riferito del luogo deserto (cf. 6,31-32).
Eppure proprio qui, in un deserto, nasce un popolo nuovo, come Israele quando uscì dall’Egitto.
Quella dei discepoli sembra essere una semplice constatazione.
E allora ecco la soluzione da loro escogitata: Gesù congedi le persone.
Pensano che la soluzione sia il mandarle via perché possano comprarsi da mangiare.
In realtà, dietro l’apparenza del buon senso e dell’aiuto alle persone, si nasconde una mancanza di lettura di fede della realtà e il conseguente disordine nel rapporto dei discepoli con la folla.
Adesso che le persone sembrano costituire un problema, i discepoli vogliono che Gesù le mandi a casa. Dopo il compimento del segno, quando forse i discepoli desiderano volgere a loro vantaggio l’accaduto, Gesù dovrà costringere (6,45) questi stessi discepoli a risalire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, allontanandoli dalla folla.
Ma egli rispose loro: “Voi stessi date loro da mangiare”.
Gli dissero: “Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?” /
Gesù educa i suoi discepoli.
Insegna loro che ciò che nella vita nutre davvero non è ciò che viene comprato, ma ciò che viene dato, donato.
Emblematica a tal proposito è la figura del figliol prodigo.br>Messosi a servizio di un uomo che lo aveva mandato a pascolare i porci fa una esperienza drammatica: «Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla» (Luca 15,16).
Perché non si è preso direttamente le carrube? - verrebbe da chiedersi.
È molto semplice: perché ciò che sazia, ciò che fa vivere davvero è la relazione, l’affetto, non le cose.
Non è il pane, è il modo.
Al banchetto di Erode non era il pane che mancava…
Non è forse anche vero che il profumo comperato
non servirà (Marco 16,1) mentre quello donato (Marco 14,3) raggiungerà lo scopo?
Non va cambiata quindi la realtà, perché la realtà è quella che è: l’ora è tarda e il luogo è deserto
per tutti, anche per Gesù!
Ma questa realtà è da interpretare e da cambiare sono il nostro sguardo e il nostro atteggiamento verso di essa.
Per non arrivare ad affermare quello che un politico diceva, con apprezzabile autoironia, commentando la sonora sconfitta elettorale del proprio partito: «La situazione non ci ha capiti…».
Gesù invita i suoi a dare, chiamandoli a passare dall’economia del possesso a quella del dono (possiamo interpretare anche così il ‘passare all’altra riva’).
Il ‘potere’ di Gesù è di dare la vita, non di toglierla (Erode).
Il “comprare” (ancora ribadito dai discepoli, che hanno calcolato anche i costi!) va sostituito dal “condividere”: questo significa anche che devono cambiare le relazioni fra noi e gli altri, fra noi e le cose.
La conversione dello sguardo e dell’atteggiamento vincerà la sproporzione tra la necessità e le risorse.
Ma egli disse loro: “Quanti pani avete? Andate a vedere”.
Si informarono e dissero: “Cinque, e due pesci” /
È la stessa vita che va vissuta in modo diverso.
Gesù non chiede l’impossibile, esorta a partire da quello che c’è, vincendo la paura che non basti.
Gesù invita i suoi discepoli ad andare a vedere: non risolve magicamente la situazione ma, rimandandoli a loro stessi e alla fiducia nella vita e in Lui, apre a soluzioni presenti ma non ancora individuate.
Dei pesci non c’era traccia nella domanda di Gesù, eppure compaiono nella risposta dei discepoli.
La domanda di Gesù ha generato fiducia.
E si trovano risorse insperate, così come insperato sarà l’esito finale.
E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde.
E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. /
Il deserto fiorisce, diventa vivibile. Il gregge disperso diventa un popolo ordinato (cf. Esodo 18,25).
Quando si passa dall’economia del possesso a quella del dono il deserto diventa una terra promessa. In questo modo viene data risposta al dubbio che ha il sapore della mormorazione: «Sarà capace Dio di preparare una tavola nel deserto?» (Salmo 78,19).
Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. /
I verbi che descrivono l’agire di Gesù costituiscono lo statuto del Figlio, e tutti noi siamo figli in Lui.
Gesù ‘prende’ in modo diverso da quello di Adamo ed Eva: il suo ‘prendere’ non è un possedere, ma un ricevere in dono per donare a sua volta.
Gesù concepisce la propria vita, e quindi anche la propria morte, come consegna di sé.
Il Cenacolo e il Calvario ce lo insegnano: «Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”» (Marco 14,22).
Gesù non ha avuto paura di dare se stesso, trovando la realizzazione della propria vita nel donarla per amore.
È un atteggiamento che contrasta la nostra paura di perdere e di perderci, la nostra tendenza a trattenere.
Come per il respiro: trattenerlo non ci regala più vita, ce la toglie. Con gli stessi verbi possiamo costruire la nostra infelicità (Genesi 3) o la nostra realizzazione.
Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci.
Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila
uomini.» /
C’è un pane che basta per tutti (nessuno escluso): più ne dai e più ne hai.
È l’Amore, che non avrà mai fine (1Corinzi 13,8).
Basta con-dividere quello che c’è. Secondo “l’aritmetica del Regno di Dio” è dividendo che si moltiplica: non si parla infatti di moltiplicare i pani (cosa impossibile per chiunque) ma di spezzarli, cioè di condividerli (cosa a tutti possibile).
Quasi a riassumere…
(I. Silone, Vino e pane)
Da’, nella sua immediatezza è un’affermazione che dice, insieme, un’inderogabilità e una responsabilità.
Di fronte ad una richiesta, un’urgenza che si presenta, più che mai vale la regola dell’imperativo.
E qui l’imperativo suona imperioso…sarebbe il caso di dire.
Sempre e comunque, di fronte a chi chiede, colui che si spende per provare a credere non può esonerarsi dalla prerogativa di dare, di farsi presente, di esserci.
Magari non sapendo neppure bene, anzi non sapendo proprio, né cosa dare e né come dare, perché il problema non sta lì.
Prima di ogni cosa viene la scelta del dare.
È questo movimento intimo, profondo provocato dalla richiesta dell’altro che fa la differenza, e alimenta la scelta.
È questo lasciarsi muovere intimamente il cuore che dà qualità alla volontà di dare.
È questo movimento che porta alla conoscenza, alla sapienza empatica che dà valore al tutto.
È una grande prospettiva questa, soprattutto per la preziosa conseguenza che genera.
Questa circolarità tra il dare e il ricevere sradica una tentazione latente nel credente: quella del prodigarsi…per prodigarsi, del fare…per fare esasperando una logica sacrificale e unidirezionale, una logica perdente, cieca che svuota di responsabilità ogni gesto, ogni evento.
È la circolarità che ci consente di accostarci alla verità del dare, che in sé non è contrattabile e neanche è restituibile, perché non c’è restituzione che valga.
È il dare che salva perché determina un contagio, perché chi dà inevitabilmente invita l’altro all’imitazione in una correlazione infinita.
Mi piace pensare a questo: in definitiva tutta la teologia, tutti i percorsi di vita spirituale non sono altro che una preziosa, quanto faticosa, via di rieducazione per un’umanità che ha dimenticato le leggi primarie dell’arte di vivere.
Forse, soprattutto per l’oggi, questa prospettiva del dare è l’unica concretamente spendibile perché riconduce ad una comprensione esistenziale dell’evento di Gesù, perché l’abbondanza di questo tempo in cui viviamo ci ha fatto perdere di vista l’incipit iniziale e primordiale di tutto, quel tutto da cui tutto prende movimento e da cui tutti dipendiamo.
Una sola realtà si trasfigura
e si mostra comprensibile ai nostri occhi
Una realtà che intreccia e dipana
grandi simboli della vita umana
Contemplarne i segni e poterli poi comprendere
è uno scambio familiare, tra tenerezze e carezze
Spanderne e accoglierne il seme
per lasciare nel corpo, colare l’infinito
Tutto in una variabile di intensità
ma sempre in un unico movimento di vita in vita
che lì si manifesta e lì si realizza

Cos’altro più che queste mani di Dio in primo piano, aperte in segno di dono, potrebbe suggerire così bene l’immagine del dare?
L’immagine di un Dio che offre all’uomo quanto ha
di più prezioso?
Sieger Köder, sacerdote e pittore vissuto in Germania, è morto novantenne nel 2015.
La sua è una pittura simbolica, che non vuole descrivere oggettivamente gli eventi, ma che
allude, che porta ad interpretare invitando ad entrare nella situazione attraverso il dipinto.
In questo quadro rappresenta le mani del creatore protese a dare vita, che sorgono dal buio di un universo ancora primordiale e che si tendono verso le sue creature.
Sui palmi, insieme all’acqua sorgente di vita, solleva una sfera rossa, un concentrato di vita e di amore, un nucleo vitale carico di pulsione.
Da esso come un rimando ecco scaturire con la stessa forma una nuova sfera che contiene il verde dei campi e il giallo del sole.
E ancora a seguire una nuova sfera con il giardino dell’Eden che circonda la donna e l’uomo di rigoglioso verde, di fiori, di colori e profumo.
Sopra di loro infinite stelle e gli uccelli del cielo.
«Io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; e la tua discendenza s’impadronirà delle città dei suoi nemici». (Genesi 22,17)
Dio dà all’uomo e alla donna, creature che sono a sua immagine, tutto ciò che ha di più bello, quanto può loro servire per stare bene, per vivere bene, per sentirsi amati. A loro la
possibilità di cogliere sempre il meglio, il bene essenziale, libero da fuorvianti benesseri.
A loro la capacità di saper guardare in verità e sapienza al serpente che abita nelle città dei loro nemici e non lasciarsi ingannare.
A loro saper coltivare la creatività e il desiderio di ricominciare ogni giorno da un giorno nuovo, dal rosseggiare dell’alba del suo inizio fino alle luci delle stelle che ne illuminano la notte.
Guardando il dipinto nel suo insieme, si nota che tutto si basa su un unico grande fondamento, cioè il principio del dono.
Dio dà agli uomini in gratuità perché loro imparino a
donarsi gli uni agli altri con la stessa logica del dono gratuito che porta vita, insieme, intimamente uniti in un abbraccio che dà forza e fa sentire amati.
Mi fermo a osservare la sfera rossa nelle mani di Dio.
Provo a fare memoria di alcuni doni che ho ricevuto, cercando di fare non un elenco ma lasciando che ne emergano pochi
ma significativi. Li so donare a mia volta?
Li metto a disposizione per condividerli?
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
Provo ora a considerare che quella sfera rossa siano i doni che l’altro, l’altra ha ricevuto e quelle le sue mani.
Quanto sono capace di cogliere i doni che chi mi vive accanto mette a disposizione, a condividerli e aiutare a farli crescere senza prima farli passare attraverso il filtro del mio giudizio?
Infine guardo le mani. Non sono solo due, sono di più, come in un gioco di specchi.
Le penso come le mani di Dio che si mischiano e confondono con le mie mani e le mani ci coloro
che la vita mi ha messo a fianco. Insieme riceviamo, insieme diamo.

Per il verbo del cammino ‘dare’, un film molto conosciuto ma che vale la pena rivedere anche più di una volta per la sua immutata capacità di parlarci come avviene solo con i classici, è Il pranzo di Babette, un film danese del 1987, tratto da un bel racconto della scrittrice Karen Blixen.
Il film ha l’andamento di una favola che racconta qualcosa di antico e di lontano nel tempo e nello spazio: nella seconda metà dell’Ottocento, due anziane sorelle che vivono in uno sperduto villaggio dello Jutland e fanno parte di “una setta di melancolici devoti senza sale in zucca” (come li definisce ironicamente uno dei personaggi del film) accolgono nella loro casa la francese Babette in fuga dalla Comune parigina, che diventa la loro domestica; le due sorelle hanno rinunciato quando erano giovani all’amore, l’una verso un ufficiale, l’altra nei confronti di un cantante d’opera francese che la voleva trasformare in una celebre soprano, e si sono chiuse nella piccola comunità religiosa fondata dall’autorevole padre, comunità che, nel corso degli anni e dopo la morte del fondatore, si è irrigidita in regole fragili e asfittiche che non hanno impedito divisioni e ostilità.
In occasione dell’anniversario di nascita del decano della comunità luterana, Babette, grazie alla vincita di una lotteria e alle sue straordinarie abilità di chef, offre alle sorelle e agli altri confratelli – i quali hanno forti pregiudizi e temono per la loro integrità spirituale – un pranzo squisito e miracoloso che diventa per tutti loro un modo di riconciliarsi con la vita e con gli altri, di fare pace col passato e di abbassare le difese perché la fede è prima di tutto gioia condivisa, grazia inattesa, che passa anche attraverso il nostro corpo.
Babette riesce a trasformare un pranzo “in un’avventura amorosa in cui non si è più capaci di fare una distinzione tra l’appetito del corpo e quello dell’anima”, donando tutta se stessa, la propria creatività e ciò che possiede a coloro che l’hanno accolta, e riuscendo addirittura a trasformare lo spirito e il corpo di chi ha ricevuto questo dono.
Nel film si va in profondità: il dono non è solo, come è ovvio, un gesto d’amore verso gli altri ma anche – come dice la stessa Babette alla fine – qualcosa che fa per sé stessa perché in quel modo lei si esprime ed è quello che fanno gli artisti (il cui grido è “Consentitemi di dare tutto il meglio di me”), in una visione del gesto del donare che nasce in primo luogo da una consapevolezza della propria persona e del proprio valore come essere umano e che poi diventa il gesto del donarsi, un modo di comunicare profondamente la propria anima e la propria essenza all’altro.
E non è necessario essere degli artisti per capire e vivere questo donarsi pieno e consapevole, che non è vissuto come un depauperamento o un sacrificio (nell’accezione deteriore
del termine), ma anzi come l’unico modo di esistere.
Come dice Papa Francesco nell’Amoris Laetitia: “Le gioie più intense della vita nascono quando si può procurare la felicità degli
altri, in un anticipo del Cielo.
Va ricordata la felice scena del film Il pranzo di Babette, dove la generosa cuoca riceve un abbraccio riconoscente e un elogio: «Come delizierai gli angeli!».
È dolce e consolante la gioia che deriva dal procurare diletto agli altri, di vederli godere.
Tale gioia, effetto dell’amore fraterno, non è quella della vanità di chi guarda sé stesso, ma quella di chi ama e si compiace del bene dell’amato, che si riversa nell’altro e diventa fecondo in lui.”
Maria Grazia e Umberto Bovani,
Lucia e Giacomo Lopez,
Beppe Lavelli SJ
Grafica
Davide Cusano
«… domandiamo al Signore nostro che … »
Quante domande attraversano la nostra vita.
Sembra una frase ovvia, un po’ scontata,
ma non lo è.
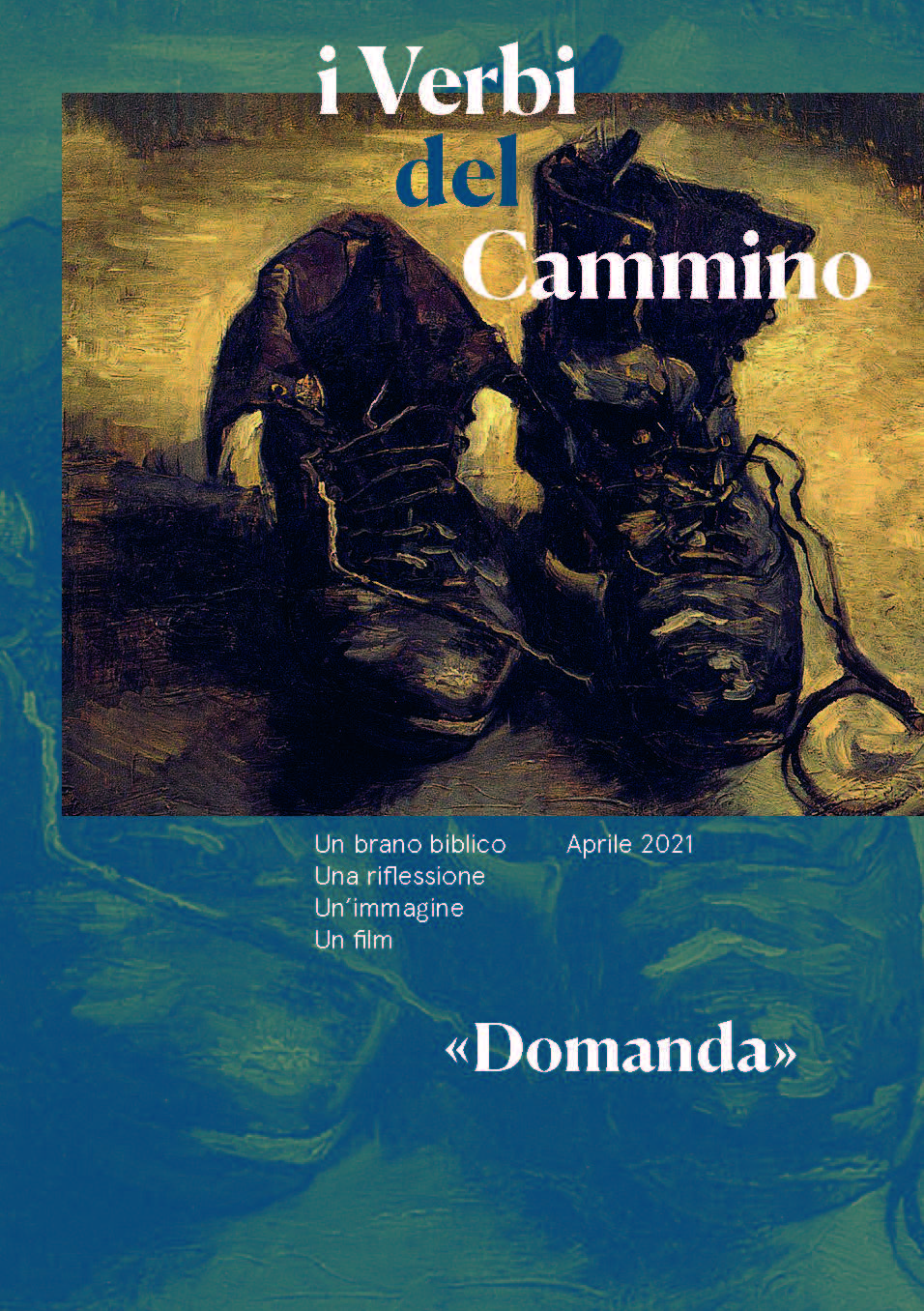
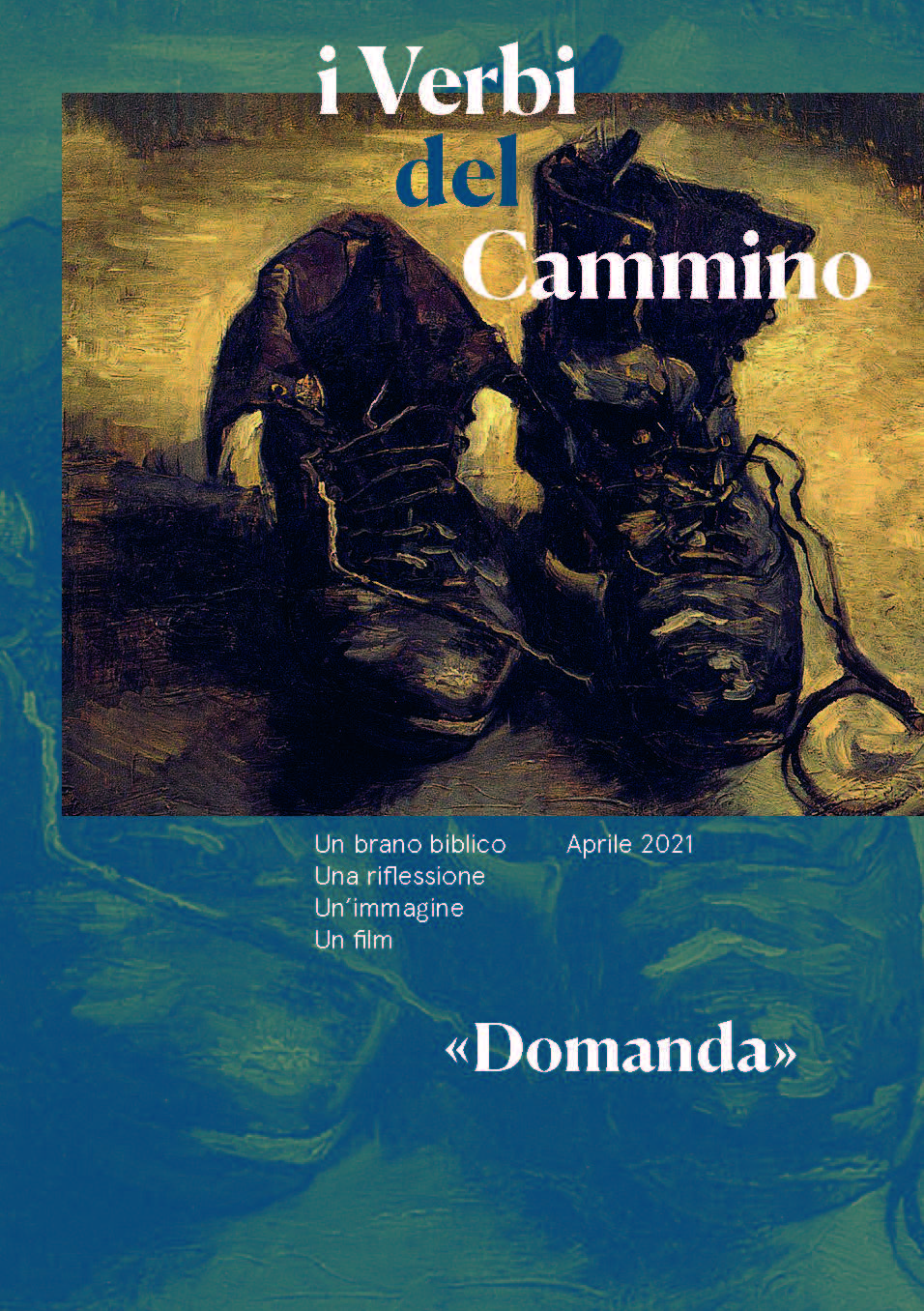
Tobia 8,4-8
4bTobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza».
5Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli!
6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui.
7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d’intenzione. Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia».
8E dissero insieme: «Amen, amen!».
Matteo 15,21-28
«Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.
Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: “Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio”
Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono:
“Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!”
Egli rispose: “Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele”.
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: “Signore, aiutami!”.
Ed egli rispose: “Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”.
“È vero, Signore - disse la donna -, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”.
Allora Gesù le replicò: “Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri”.
E da quell’istante sua figlia fu guarita.»
Sembra che Tobia e Sara abbiano fatta propria la fiducia a cui Gesù inviterà i suoi discepoli: «In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà » (Matteo 18,19).
Con questo spirito veniamo al brano proposto.
Partito di là… L’iniziativa è di Gesù. È lui che rende possibile l’incontro. Ogni nostro domandare
è sempre una risposta a Colui che si rende presente sempre e dovunque, anche nelle nostre “terre pagane”.
Gesù lascia un luogo e una discussione con scribi e farisei che onorano Dio con le labbra ma che tengono il cuore lontano da Lui (15,8). E forse la prima cosa che possiamo chiedere è una piena comunione con noi stessi.
Una donna cananea, che veniva da quella regione… Due persone s’incontrano. Il verbo che descrive il movimento della donna è lo stesso di quello usato per Gesù al versetto precedente (pur tradotto in modo diverso nelle due circostanze). All’uscire di Gesù corrisponde quello della donna cananea. Ogni vero incontro ha il sapore della reciprocità.
Si mise a gridare… Prima ancora di riportare il contenuto della domanda, l’evangelista ci dice che sarà una richiesta gridata. La donna vuole essere certa che la sua domanda raggiunga l’interlocutore.
Pietà di me, Signore… Mia figlia è molto tormentata da un demonio Nella voce di questa donna c’è grande forza, nelle sue parole grande sofferenza. Questa donna si rivolge a Gesù chiamandolo sempre ‘Signore’. Qui, al versetto 25 («Pietà di me, Signore») e al versetto 27 («È vero, Signore»). Sa a chi domandare. La donna sa anche cosa domandare.
Il suo grido non è inarticolato: chiede vita e la chiede al Signore («Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto la richiesta delle sue labbra…Vita ti ha chiesto, a lei l’hai concessa» Salmo 21,3.5). La richiesta della madre nasce dalla sofferenza della figlia.
Ma egli non le rivolse neppure una parola… Questa donna sperimenta un ostacolo nel silenzio che Gesù le oppone. Può venire la tentazione di arrendersi. Perché continuare a chiedere?
I suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: “Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!” Quello dei discepoli non è un vero ascolto della donna. Non vogliono liberare la figlia dal male: vogliono liberarsi della madre! Infatti, più che con “esaudiscila” sarebbe meglio tradurre con “mandala via”.
Gesù si trova così a essere raggiunto da una ulteriore richiesta: oltre a quella della donna, quella dei suoi discepoli. E mentre la donna domanda per la figlia, i discepoli domandano per loro stessi.
Signore, aiutami! La donna persevera, chiede aiuto a Gesù nonostante il suo silenzio e l’incomprensione
dei suoi discepoli.
Anche se non presente presso la montagna dove Gesù ha pronunciato il discorso, la cananea dà spazio alle parole dette da Gesù: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono!» (Matteo 7,7-11).
Non è bene … il pane dei figli… i cagnolini Meglio il silenzio di Gesù di queste sue parole? La donna viene “ricondotta” alla sua realtà di pagana (i pagani erano chiamati “cani” dagli ebrei).
È vero, Signore… La cananea insiste, non si scoraggia. Ha fiducia in Gesù e nella sua volontà di vita.
Quella della donna è una domanda, non una pretesa: la cananea non accampa diritti, anzi riconosce di non avere nessun diritto, di non poter vantare alcun merito a sostegno della propria richiesta. Ma sa anche che chiede amore all’Amore e, se è tale, esso si offre gratuito e senza condizioni. Il pane dei figli, cioè la vita dei figli, come l’amore, non lo si merita: lo si accoglie. È puro dono e grazia. Ma se è un dono, perché va chiesto? Perché la richiesta è segno del desiderio. E allora il dono è da chiedere? Sì. Proprio così. Nella sua sapienza, sant’Ignazio di Loyola invita l’orante a «chiedere a Dio nostro Signore quello che voglio e desidero» (Esercizi spirituali, n. 48).
Le briciole… Nessuna pretesa, nemmeno del pane. Sono parole di umiltà e di fiducia.
Questa donna domanda le briciole. Sa che anche nei frammenti c’è tutto l’amore del Donatore. È una donna pagana, ma nel suo modo di porsi mostra di essere degna erede di quell’Abramo, nostro padre nella fede, che, nella sua intercessione in favore di Lot e della sua famiglia, non ha avuto timore di rivolgersi al suo Dio in questo modo: “Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?”» (Genesi 18,27-28).
La donna domanda a partire da una duplice verità: la propria, che non viene nascosta o camuffata, e quella del Signore, che può e vuole
donare vita. Non è un modo semplice ma molto efficace di sperimentare l’autenticità di quelle parole che Gesù pronuncia nel vangelo di Giovanni: «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi… Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (8,32.36)?
Grande è la tua fede! La distinzione cani/figli è abbattuta dalla fede.
La fede di questa donna sopravanza quella dei discepoli (8,26; 14,31). È una fede grande come quella del soldato pagano, le cui parole (8,8.10), non a caso, ripetiamo in ogni Eucaristia prima di ricevere il pane dei figli!
Meraviglia in un Dio che scorge la fede dove non ce l’aspetteremmo e non la trova dove invece l’attenderemmo (Matteo 13,58); libertà di un Dio che riconosce il bene dovunque si trovi
e di questo bene gioisce.
Avvenga per te come desideri Il domandare che la donna ha posto in essere è stata anche la risposta alla sua domanda.
Ciò che domandiamo al Signore è già la Sua risposta: «Tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete» (Matteo 21,22).
Gesù compie la volontà di vita di questa donna.
Quasi a riassumere…
(D. Bonhoeffer, Lettera a Eberhard Bethge, 21 agosto 1944, in Resistenza e resa).
Quante domande attraversano la nostra vita. Sembra una frase ovvia, un po’ scontata, ma non lo è.
Le nostre domande ci tengono in vita, ci danno la vita, perché noi umani ci alimentiamo di interrogativi nella speranza di avere risposte … pur sapendo che in buona parte molte risposte non arriveranno mai. È una tensione, un’attesa che ci tiene in vita. Diciamo però una cosa: spesso poniamo domande sapendo che una risposta, girasse pure il mondo al contrario, non la troviamo.
Domande troppo grandi per avere risposte e allora le nostre speculazioni filosofiche qui vanno a nozze…infiniti punti interrogativi, spesso conditi con tanto di verve dialettica per un’infinità di parole…e poi ancora parole. Insomma nulla di nuovo si muove là dove la ricerca finisce sul nascere.
Ma davanti a questo verbo, oltretutto potenziato nella sua modalità imperativa, un pensiero mi ha attraversato. Quante sono le domande che nella nostra vita non abbiamo posto temendo di ricevere una risposta? Pensiamoci un attimo, forse anche più di un attimo.
Quali sono quelle domande che non poniamo? Quelle domande che cadono nel silenzio ben sapendo che una risposta ci sarebbe, ma che non vogliamo ascoltare, domande cucite dentro una verità che non vogliamo vedere.
E andiamo avanti, facciamo finta di niente. Ogni tanto servirebbe fermarsi e provare a non girare la faccia dall’altra. Ci sono grandi questioni sospese che rivendicano una nostra domanda. Questioni di cui non desideriamo sapere, preferiamo essere confermati dentro presunte verità e rimanere così…come sospesi.
Eppure, dentro di noi, ogni tanto queste domande riaffiorano, fanno capolino nella nostra vita a ricordarci che a forza di rimuovere, andare oltre, non voler sapere rischiamo che l’ingranaggio della nostra esistenza si inceppi e allora sono storie amare. Se ci pensiamo queste domande silenti che soggiornano dentro di noi molto spesso riguardano le nostre relazioni affettive e soprattutto persone verso le quali c’è un legame forte, molto forte. Una moglie, un marito, un compagno di vita, una convivente… un figlio, una figlia.
Anzi, proprio le nostre esperienze di massima prossimità custodiscono in sé uno spazio di domande non dette, non espresse. Quante domande ci censuriamo verso i figli, verso l’amata, verso l’amato. Domande di cui non desideriamo avere risposta.
Se proviamo a fare un piccolo elenco… presto diventerà un grande elenco, un infinito elenco. Che ne facciamo di queste domande? Le teniamo lì in attesa di tempi migliori? Ma poi ad un certo punto il tempo scade e non ci sono, almeno su questa terra, tempi supplementari.
Credo che sia un’esperienza di vita importante, bella, trovarci di fronte ad una persona dalla quale siamo tristemente chiamati a congedarci e intimamente percepire che il campo è libero, non vi sono domande non dette, sospese.. Soprattutto con chi abbiamo amato per una vita intera prima o poi è giusto che ci raggiunga il tempo delle domande nascoste, rimosse.
Non possiamo separarci così. Siamo sempre in tempo per fare domande, senza la fretta di avere risposte, tanto le risposte già abitano in noi.
Riuscire a liberarci da domande per anni sopite alleggerisce la nostra vita e ci regala un pezzetto di felicità tutt’altro che trascurabile.

Il riquadro de La preghiera in San Damiano è il quarto in ordine di sequenza delle ventotto scene del ciclo di affreschi sulla storia di San Francesco che si trova sulle pareti laterali della Basilica Superiore di Assisi, attribuiti a Giotto.
La piccola chiesa viene rappresentata non solo diroccata così come era quando Francesco vi si recava a pregare, ma ulteriormente priva di alcune porzioni, perché vi si potesse vedere all’interno. E quel che si vede è un Francesco ancor giovane, ancora vestito con gli abiti di lusso della sua ricca famiglia. E’ sproporzionato, è grande rispetto all’architettura, come se fosse reso grande da ben altre proporzioni, quelle che guardano non alla fisicità dei corpi umani e materiali, ma alla grandezza di uno spirito che sta attraversando una dura esperienza di deserto e di fede, di tenebre e di ricerca della luce, di ricerca di senso. Ancora non ha scelto la via della spoliazione e della povertà. Si reca in quella piccola cappella per stare alla presenza del crocifisso e fargli delle domande, per chiedere illuminazione: “Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre de lo core mio”.
Alla domanda di questo giovane poco più che ventenne, il Crocifisso, che rappresenta il Christus Triumphans, un Cristo già risorto che annuncia nuova vita, risponde con una domanda: “Vai Francesco, ripara la mia casa che sta cadendo in rovina”. Una richiesta che indica un percorso da seguire per trovare risposta alla sua sete di senso.
Cristo risponde alla domanda di luce con una domanda di azione: vai e ripara. Si dice che il Crocifisso abbia ripetuto tre volte la frase; forse Francesco, preso dal suo chiedere, non si è accorto subito che a lui veniva chiesto qualcosa. Un bell’insegnamento per la nostra preghiera!
Spesso quando preghiamo abbiamo dentro di noi il desiderio di comunicare a Dio tanti nostri pensieri, preoccupazioni, intenzioni… parole insomma che gli riversiamo addosso… senza neanche accorgerci che solo se facciamo silenzio riusciamo a sentire ciò che lui ha da dirci.
Provo ad immedesimarmi nella figura di Francesco. Qual è oggi la domanda che farei al Crocifisso?
Ne individuo una. Posso anche immaginarmi di essere in due, uno a fianco dell’altra come lo erano Tobia e Sara quando tenendosi per mano hanno detto “domandiamo a Dio…”.
Cosa domandiamo a Dio oggi? Dopo aver domandato provo/proviamo a fare silenzio, lasciando scorrere via i pensieri senza che diventino parole da riversare ai piedi della croce.
Riesco/riusciamo a percepire in noi la domanda che Dio ci pone, la strada di vita che ci indica qui ed ora?
Provo in seguito a pensare al mio modo di pormi nelle relazioni affettivamente più significative, quelle che mi coinvolgono di più nel profondo. Sono capace di fare silenzio per sentire la domanda che l’altro mi sta facendo?

Cercare e porre domande può essere più importante del trovare le risposte che si stanno cercando. Perché ci possono essere anche domande alle quali non si potrà mai dare una risposta specifica ma esse saranno comunque in grado di generare un movimento, saranno capaci di suscitare una trasformazione – in chi chiede e in chi è interpellato – al punto di rendere meno urgente quella iniziale domanda e più vitale accogliere il cambiamento che essa ha comunque determinato.
A Ebbing, piccola cittadina di provincia del Missouri, una ragazza (Angela) è stata stuprata, bruciata viva, uccisa. Un delitto terribile per il quale, dopo mesi, la polizia locale non è riuscita a trovare nemmeno una minima pista da seguire per le indagini. Mildred, la madre di Angela, decide di affittare tre grandi cartelloni pubblicitari, che si trovano a pochi metri
da dove sua figlia è stata trucidata, affiggendo tre frasi:
- Stuprata mentre stava morendo
- E ancora nessun arresto?
- Come mai sceriffo Willoughby?
Bill, lo sceriffo chiamato in causa, è ben voluto dalla propria comunità, è sinceramente addolorato per la morte di Angela ma altrettanto impotente di fronte al vicolo cieco delle indagini sulla morte della ragazza: non può dare a Mildred le risposte che lei si ostina a chiedere.
I tre manifesti di Mildred innescano una serie di reazioni sempre più violente da parte della popolazione e in particolare da parte di Jason, un poliziotto violento e razzista che considera lo sceriffo Bill come un mentore, una figura paterna. Al centro del film quindi esplode un campo di tensioni nel quale tutti i personaggi (compresa Mildred) condividono la violenza come linguaggio, come modo di vita. Sono catturati tutti in una rete di rabbia che si autoalimenta.
Ma è proprio il soggetto dello scandalo, lo sceriffo Willoughby, che con un gesto estremo, costringe Mildred e Jason a prendere coscienza del meccanismo nel quale sono catturati.
In un contesto di figure genitoriali del tutto inadeguate, lo sceriffo agisce come una figura di padre amorevole nei confronti della propria comunità in cerca di risposte. Quella domanda, che tutti hanno considerato offensiva nei suoi confronti, per lo sceriffo invece è l’occasione per rivelare e per rivelarsi, in un sorprendente capovolgimento delle solite dinamiche di offesa e risposta. Come nel brano di Tobia, quella domanda iniziale, per Mildred e Jason, si trasformerà in una richiesta implicita di «grazia e salvezza».
Consigliamo la visione a un pubblico adulto.
«Quando pregate» (Mt 6, 5–8)
Mi piace riflettere sul senso della preghiera.
Mi piace perché non so dove una riflessione su questa esperienza mi potrebbe portare.
Mi piace perché mi sfuggono letteralmente dalle mani i pensieri ancor prima di iniziare ad ordinarli.
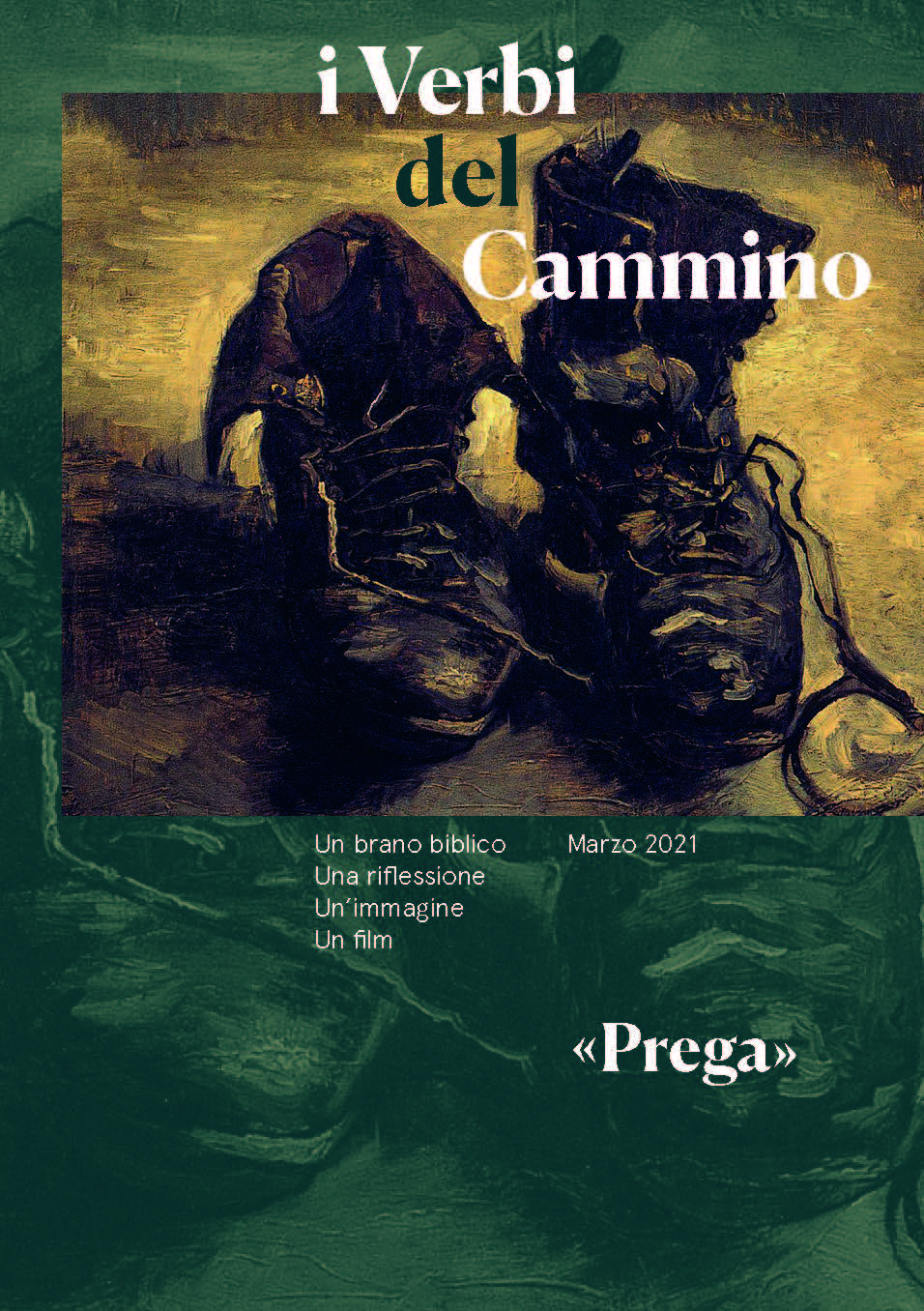
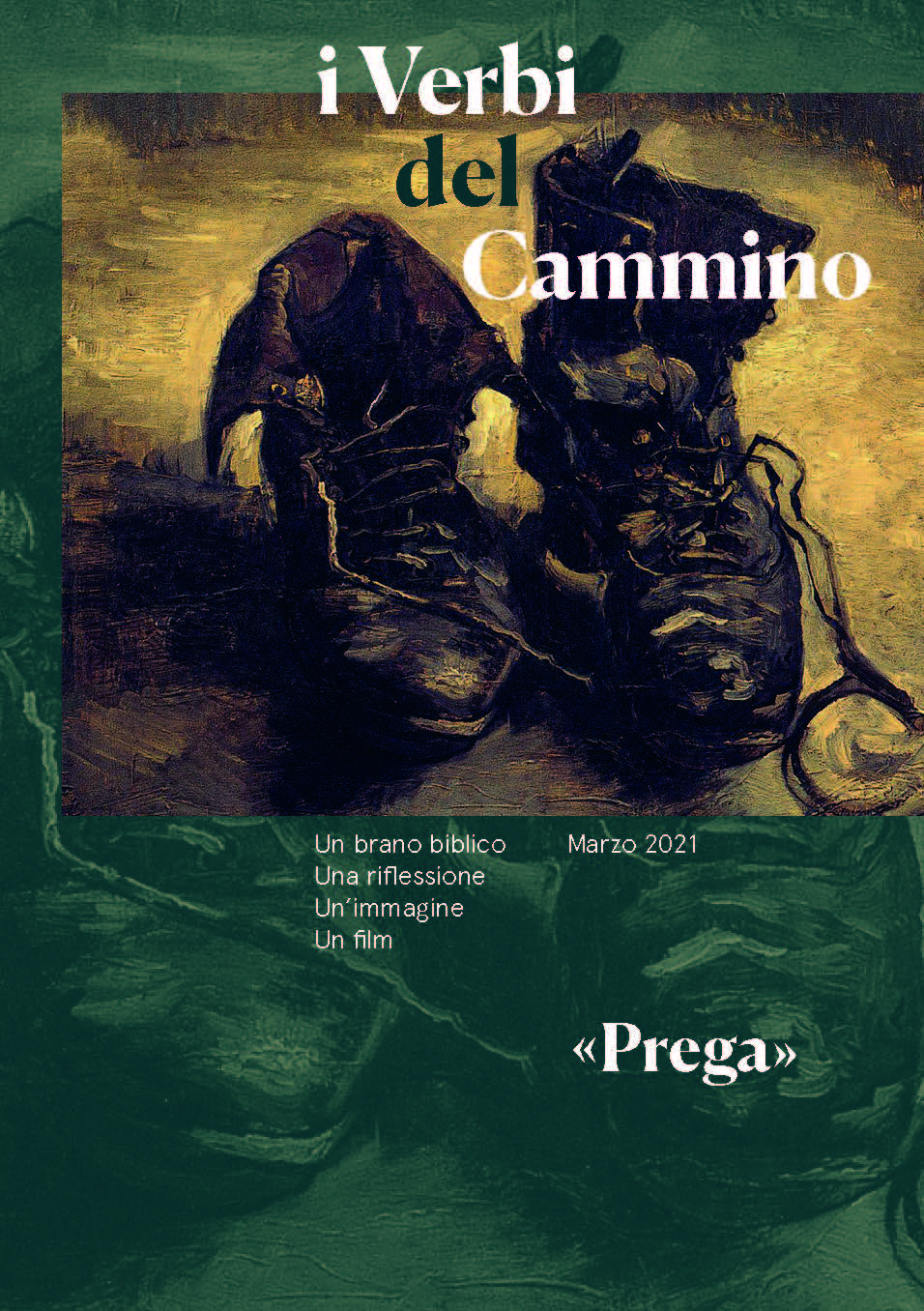
Tobia 8,4-8
4aGli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza».
5Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli!
6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui.
7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d’intenzione. Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia».
8E dissero insieme: «Amen, amen!».
Matteo 6, 5–8
«Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente.
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti icompenserà.
Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole.
Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli… »
Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare con l’esempio e con le parole (Lc 11,1-4).
In questo brano del vangelo di Matteo, che fa parte del Discorso della Montagna, Gesù, prima di donarci anche le parole, quelle del Padre Nostro, ci illustra l’atteggiamento da assumere rivelandoci che il modo con cui entriamo nella preghiera è decisivo. Come dire: prima il come, poi il cosa.
E allora vediamo alcune caratteristiche di questo atteggiamento.
Quando pregate… / È importante decidere il tempo, il quando pregare: prevedere tempi espliciti per la preghiera.
Ognuno conosce le proprie giornate e le proprie settimane, con tutto il loro carico di imprevisti, unico punto immancabilmente presente...Ma ognuno sa anche che le cose importanti sono quelle a cui si riesce a dedicare del tempo. Dal canto suo Gesù ha pregato in ogni momento: prima di compiere scelte significative (Lc 6,12-13), dopo eventi importanti (Mt 14,21-23), nel cuore delle situazioni (Mc 14,35-36; Lc 23,34.46).
Non siate simili agli ipocriti… amano pregare per essere visti … / Il brano, prima di dirci come pregare, ci dice come non pregare: non dobbiamo cercare noi stessi nella preghiera, in una sorta di “narcisismo orante”, in cui gli altri o il Signore stesso (Lc 18,11-12) fanno solo da specchio alla nostra vanagloria che ama assumere tante maschere. Pregare per essere visti è non pregare e, ancora più a fondo, è non credere che siamo amati.
Siamo invitati, invece, a pregare rivolgendoci a un Tu, in verità e trasparenza: verso noi stessi, anzitutto, e verso il Signore, sapendo di essere amati.
Entra nella tua camera, chiudi la porta / È vero: non c’è bisogno di luoghi particolari. Può andare bene anche la propria casa. Per Sara e Tobia, la loro stanza.
È comunque importante il luogo, sia fisico, sia interiore. Una bella sintesi di questa “duplicità di luogo” ci è offerta dalla «sala al piano superiore » di cui parla Luca (Lc 22,12; At 1,13): una sala che non ci estranea dalla realtà di tutti i giorni, ma che ci consente di immettere in questa realtà la vita dello Spirito. C’è in tutti noi un piano superiore che è fuori dal nostro fare ordinario. Bisogna salire su quel piano, come su un monte, per poter scendere dentro di noi e lì incontrarci e lasciarci incontrare.
La porta chiusa custodisce il silenzio necessario all’ascolto, allontana le chiacchiere che ci circondano e che ci abitano, ci aiuta a scendere in profondità, ma non ci rinchiude in noi stessi: è una porta destinata ad aprirsi a Colui che, con discrezione e instancabilmente, in tanti modi bussa (Ap 3,20) chiamandoci all’intimità e all’amicizia con Lui.
Prega il Padre tuo… / Forse la prima cosa che siamo chiamati a riconoscere è che non sappiamo pregare ma, contemporaneamente, possiamo avere piena fiducia: «Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio» (Rm 8,26-27).
Il Padre è già lì, così come era già presente nel roveto a cui Mosè si avvicina (Es 3,4).
La preghiera è dentro a una relazione e nutre questa relazione: pregare il Padre significa riconoscersi suoi figli e «fratelli tutti» (Papa Francesco).
…che vede nel segreto / Siamo sotto lo sguardo di un Padre, uno sguardo che arriva lontano (Lc 15,20) e che anche da lontano ci attende. Sant’Ignazio invita l’esercitante, che si accinge a pregare, a considerare «come Dio nostro Signore mi guarda» (Esercizi spirituali, n. 75): momento fondamentale per entrare in preghiera con un cuore riconciliato e riconciliante.
Non sprecate parole … / Il Padre ci conosce, ci ama e, prima ancora che glielo chiediamo, sa ciò che ci sta a cuore, perché gli stiamo a cuore. E allora non sprechiamo parole, non ce n’è bisogno. Ne bastano davvero poche: «Avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13), «Sia fatta la tua volontà» (Lc 22,42). Per pronunciare queste poche parole bastano pochi secondi; per farle proprie può non bastare una intera vita.
Forse, più che a pronunciare (tante) parole nostre, possiamo dedicare il tempo della preghiera ad ascoltare quelle che il Padre vuole dirci, lasciando che prendano sempre più dimora dentro di noi.
Voi dunque… / La preghiera è comunitaria, sempre. Il Padre tuo, che vede nel segreto, è il Padre nostro al quale mi rivolgo, anche nella preghiera solitaria, preghiera che comunque pronuncio da fratello/sorella di ogni persona.
Quasi a riassumere … / «Di nuovo m’inginocchio sul ruvido tappeto di cocco, con le mani che coprono il viso, e prego: Signore, fammi vivere di un unico, grande sentimento – fa’ che io compia amorevolmente le mille piccole azioni di ogni giorno, e insieme riconduci tutte queste piccole azioni a un unico centro, a un profondo sentimento di disponibilità e di amore. Allora quel che farò, o il luogo in cui mi troverò, non avrà più molta importanza. Ma non sono ancora affatto a questo punto»
(Dal Diario di Etty Hillesum).
Mi piace riflettere sul senso della preghiera.
Mi piace perché non so dove una riflessione su questa esperienza mi potrebbe portare. Mi piace perché mi sfuggono letteralmente dalle mani i pensieri ancor prima di iniziare ad ordinarli. Forse perché non si dovrebbe parlare della preghiera e se tentiamo di ragionarci su ci mancano le parole, balbettiamo se va bene qualche mezza frase magari rapita qua o là.
La preghiera come ogni esperienza importante si capisce praticandola e più proviamo a praticarla e meno ci viene da parlarne. E già su questo ci sarebbe da pensare non poco!! Tanto più se ci accostiamo a esperienze di altri.
Ricordo che alcuni anni fa ero molto animato dal desiderio di conoscere “modalità” di pregare: esperienze di monaci, religiosi, comunità eremitiche. Ricordo per esempio i “tempi di preghiera” della Comunità di Bose o dei Trappisti di Monastero Vasco o della Città dei Ragazzi di Don Gasparino. Ero profondamente affascinato dalle loro “pratiche” e più mi affascinavano e più percepivo in me una profonda lontananza. Mi sentivo spettatore di un qualcosa di cui non si può essere spettatori.
Nella preghiera non possiamo stare sugli spalti a tifare per una modalità piuttosto che per un‘altra. Devo dire che questa percezione di estraneità ha generato in me non pochi pensieri.
Mi è sembrato di capire, per esempio, che la preghiera deve essere conforme alla mia storia, assumerne la figura, per poter alimentare dall’interno senso, valore, orizzonte a ciò che già c’è, senza necessariamente aggiungere altro. La preghiera non si contrappone al reale ma è senso di appartenenza al reale. La preghiera è ritrovare un senso ad un’esperienza di intimità non solo con le persone ma anche con le cose. La preghiera come intima partecipazione alla infinità del nostro essere qui adesso, in questo tempo e soprattutto nelle cose di questa vita.
Ma c’è un altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore. La questione del corpo, la materia di cui siamo costruiti. Gambe, mani, fegato, cuore…organi che danno corpo alla preghiera e che la rendono possibile e quindi credibile. È il mio corpo che mi conduce alla preghiera, che mi accompagna ad essa e che mi indica la strada da percorrere. Spesso constato che se anche solo per un breve tempo dimentico questo allora la mia preghiera si riduce a inutile sforzo intellettuale senza radici. Non può che essere il mio corpo a darmi la misura della preghiera. Tutto attraverso me e nulla al di fuori di me. “Allora il Signore plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”. Solo apparentemente la preghiera è immobilità, staticità.
L’essere vivente è movimento e la preghiera ha a che fare con qualcosa di estremamente concreto come il movimento. La preghiera non solo genera movimento ma è movimento. Spesso ritorno su questo pensiero.
Preghiera e movimento hanno la stessa matrice, la stessa capacità di azzerare pensieri pesanti, soffocanti, ingombranti per ridare aria, leggerezza, senso dell’essenziale. Lo dico sperando di non essere frainteso. Per me l’esperienza che si avvicina di più alla preghiera è il camminare, il correre. Ritrovo e riconosco la stessa identica forza liberante, lo stesso impulso rigenerativo, lo stesso desiderio di alleggerire l’io e riuscire così a dare voce all’oltre che abita il mondo e che abita in noi.

Pochi dipinti rappresentano con così tanta intensità una coppia in preghiera come è riuscito a fare Millet in questo quadro. Il suo intento era di esaltare il valore morale degli umili, dei più semplici, che nonostante il faticoso lavoro nei campi, non perdono di vista il loro legame con il trascendente.
Il tridente in primo piano affonda appena le punte, segno di un terreno duro e faticoso da lavorare. I colori terrosi degli abiti dei due contadini quasi li confondono con il paesaggio della campagna, inserendoli in completa sintonia fisica e spirituale con la natura che li circonda e che ricambia il loro lavoro con i suoi frutti. In mezzo ecco infatti il cesto con le patate già raccolte che costituiranno i loro semplici pasti. Ma quando le campane del lontano campanile suonano i rintocchi dell’Angelus, si fermano e cercano ristoro non per le mani indurite dalla terra, non per la schiena sempre china, ma per la loro anima.
Hanno capito che alla fine è nell’incontro con Dio, ancor più insieme uno a fianco dell’altra, che si trovano la forza e le energie per continuare a sostenere la quotidianità e rinnovarne il senso… sia quando essa richiede fatica perché il terreno si fa più duro… sia quando se ne raccolgono i frutti, che per quanto semplici possano essere, non sono sempre scontati, ed è bello saperli riconoscere come dono e saper ringraziare.
Provo a fermarmi come i due contadini. A fermarmi. Perché serve fermarsi per poter mettere a fuoco le cose, per vederle, riuscire a distinguerle, dar loro un nome. Serve fermarsi per entrare in relazione con consapevolezza con ciò che sta sulla terra e con il cielo. Serve fermarsi per entrare in contatto con il nostro io più profondo. E di lì poi affidarci, come hanno fatto Tobia e Sara prima di affrontare la prima notte, i loro vissuti, le loro paure.
Provo ad ascoltare… riesco a cogliere il suono del campanile lontano? È abbastanza lontano, devo saper far silenzio per sentirlo mentre mi affaccendo, ma non così tanto lontano ché io non possa scorgerlo come presenza discreta che rientra nell’orizzonte delle mie tante faccende ordinarie.
Qual è il campanile delle mie giornate? Provo ad individuare un elemento del mio quotidiano da cui si emanano rintocchi che riesco a riconoscere, che mi portano ad alzare lo sguardo per poi chinarlo in raccoglimento ed interiorizzazione. Se lo so individuare, se imparo a riconoscerlo, so che lo saprò riconoscere sempre, anche nei giorni a venire.
Provo a guardare e a dare un nome a quel terreno di lavoro e ai frutti raccolti nel cesto. Cosa affido del mio oggi e per cosa ringrazio?
Mi congedo dal quadro dando un ultimo sguardo al campanile.

Il film che vi proponiamo per il verbo ‘prega’ è l’ultimo lavoro del regista americano Terence Malick (“La sottile linea rossa”, “The Tree of Life”) che s’intitola “La vita nascosta – Hidden Life” (2019).
È il racconto biografico del contadino austriaco Franz Jägerstätter che scelse di non arruolarsi nell’esercito nazista e quindi di non giurare fedeltà a Hitler e per questo venne imprigionato e ucciso. Il film ripercorre la vita esteriore ma soprattutto interiore di Franz e di sua moglie Franziska che si conobbero e innamorarono in mezzo alle montagne verdi e incontaminate dell’Austria, una sorta di paradiso perduto, dove irruppe la violenza della guerra e della sopraffazione, ponendo a Franz una domanda radicale: partecipare alla guerra e soprattutto giurare fedeltà a un dittatore sanguinario ma continuare a vivere e a occuparsi della sua famiglia oppure restare fedele a ciò in cui credeva, mettendo però in gioco la propria vita e quella dei propri cari?
Il primo aspetto interessante del film è che a questa domanda se ne aggiungono altre non meno importanti: ne vale la pena? Una scelta individuale di una persona qualunque non avendo alcun peso sulla Storia, non rischia di essere un gesto egoista e ideologico che non tiene conto del dolore inferto ai propri cari? Questi sono i dubbi istillati ai protagonisti dagli Altri (la gente del paese, gli inquisitori, addirittura il parroco) ma nel film c’è un’altra presenza misteriosa, quella di Dio, apparentemente il grande assente in un momento così buio della storia, ma la cui presenza aleggia nella natura e si incarna appunto nella vita dei due protagonisti.
E infatti l’altro aspetto importante è che il protagonista non è solo Franz ma anche sua moglie Franziska, e il percorso che conduce all’azione e poi la fase in cui i due affrontano le conseguenze riguarda la coppia, che si confronta dialetticamente ma che poi giunge a una scelta condivisa e vissuta fino in fondo: una scelta di Amore.
Oltre al racconto esterno, il film entra nell’anima dei personaggi, grazie a una strabordante voce fuori campo, spesso tratta dalle lettere scritte da Franz alla moglie. Nel momento in cui il protagonista è in prigione e sta arrivando il momento di andare fino in fondo, inizia una lunga preghiera di accettazione e affidamento del protagonista alla quale fa eco la preghiera di sua moglie Franziska. Questo è il cuore del film: i protagonisti si fanno accompagnare dal dialogo con Dio, dove ci sono istanze diverse, richiesta di aiuto, comunicazione di un tormento e di una sofferenza, ma anche lode, ringraziamento, affidamento totale
Il film stesso – molto lontano dal cinema di intrattenimento ma comunque nell’alveo del cinema narrativo – richiede tempo (è lungo poco meno di tre ore) e un atteggiamento di apertura perché è un film doloroso, come se fosse una preghiera esistenziale: la visione vale la pena perché «Il bene a venire del mondo dipende in parte da azioni di portata non storica; e se le cose per voi e per me non vanno così male come sarebbe stato possibile, lo dobbiamo in parte a tutti quelli che vissero con fede una vita nascosta, e riposano in tombe che nessuno visita» (George Eliot, Middlemarch).
«Àlzati e cammina”» (Lc 5,24)
Un invito, oppure un imperativo?
Un’imposizione oppure un atto d’amore?
Difficile capire, certamente dipende dal contesto, là dove ci troviamo e soprattutto chi abbiamo accanto, perché detto così … àlzati…richiama comunque ad
una presenza.
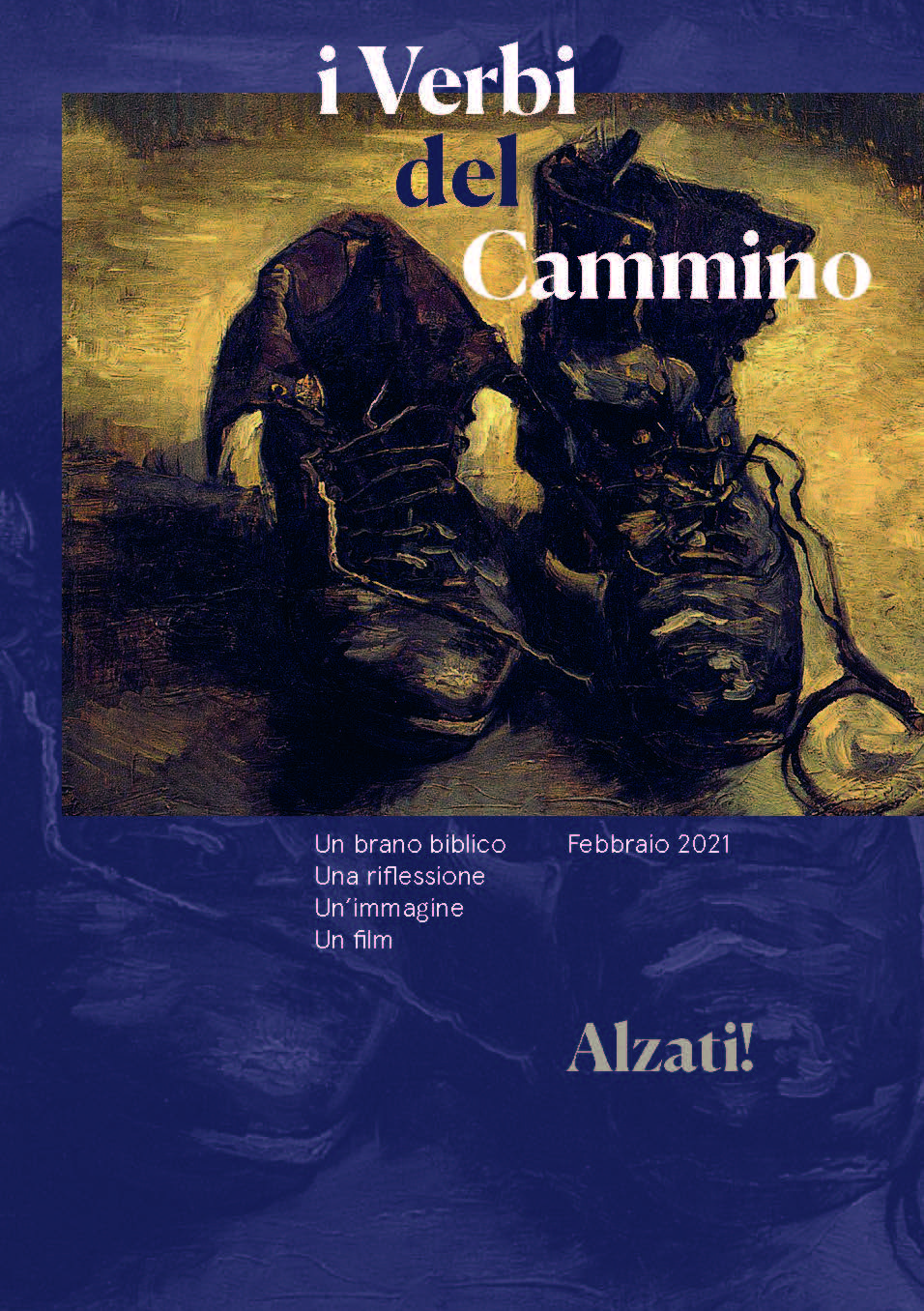
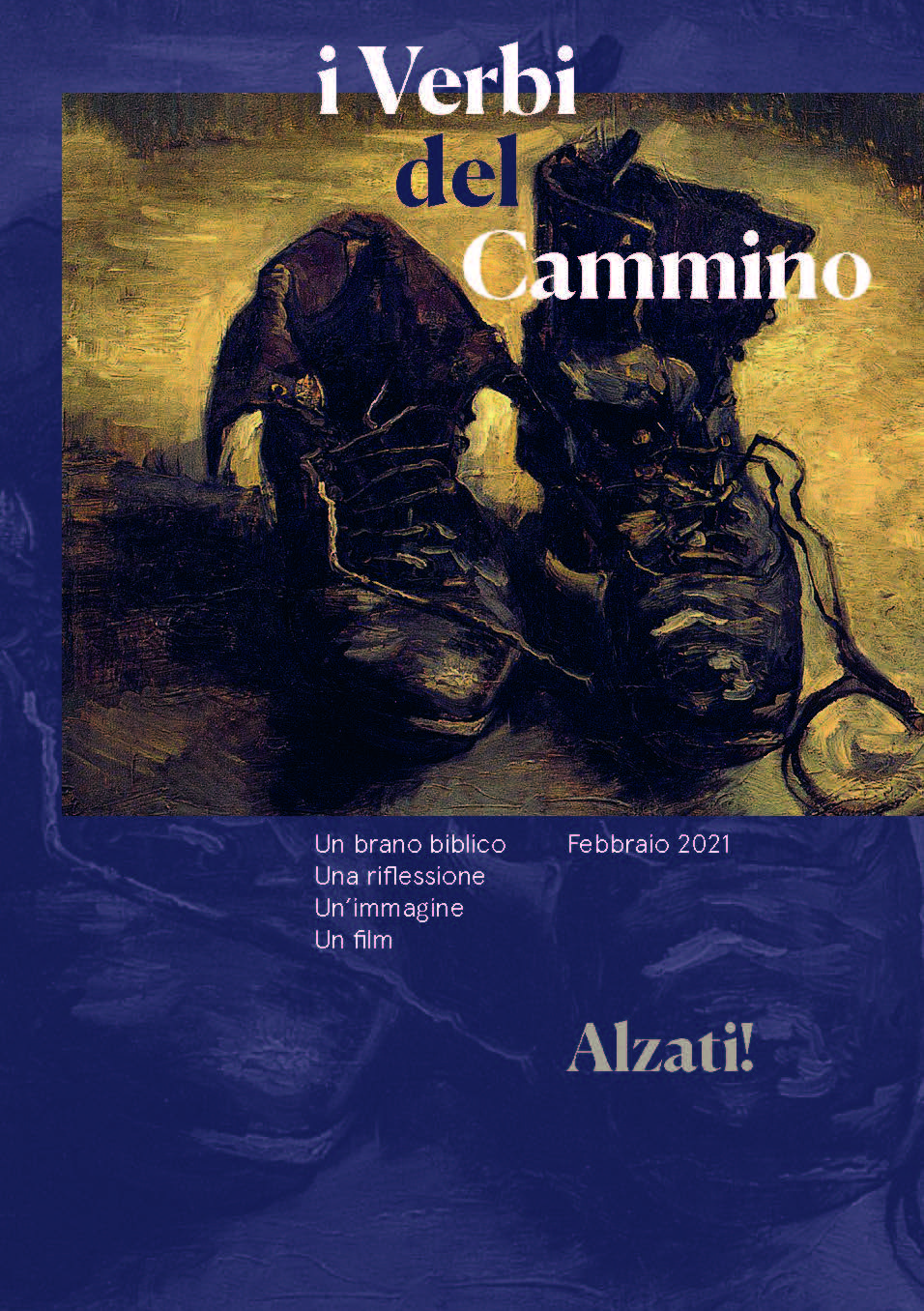
Carissime e Carissimi,
qualche tempo fa, sulla scia degli incontri di Selva continua … Famiglie avevamo dato inizio a un percorso che avevamo intitolato I verbi del cammino. Voleva essere un aiuto per la riflessione e la revisione del cammino di crescita individuale e di coppia.
Circostanze di diverso tipo, non ultima la pandemia, ci avevano portato a sospendere questo percorso che ora però desideriamo riprendere anche perché ci sembra che possa costituire un aiuto per sentirci in comunione gli uni con gli altri e in un cammino comune pure in questo tempo così delicato.
Abbiamo quindi deciso di ripartire da capo, aggiungendo un’ulteriore finestra rispetto alle tre precedenti, e impegnandoci a mettere sul sito (www.gesuiti-selva.it) e a farvi arrivare le nostre riflessioni per l’inizio di ogni mese.
Ci lasciamo ispirare dalla preghiera che pronunciano insieme Sara e Tobia affacciandosi alla loro prima notte insieme, dopo essersi uniti in matrimonio. È l’unica “preghiera di coppia” che compare nelle Scritture; è semplice e ricca nella sua essenzialità.
Ogni tappa del nostro percorso sarà scandita da un verbo di questa preghiera, visto a partire da diverse prospettive: una pagina della Bibbia con un commento, una riflessione, un’immagine artistica, una proposta cinematografica.
L’invito è quello di dedicare del tempo alla preghiera e alla meditazione su questo verbo, a quello che può dire alla nostra vita personale e di coppia.
Insomma, queste riflessioni desiderano semplicemente essere degli strumenti che aiutino e accompagnino il nostro cammino, costituendo una specie di sosta salutare, analoga a quella di cui parla il salmista: «lungo il cammino si disseta al torrente, perciò solleva alta la testa» (Sal 110,7).
E allora buona sosta per un miglior cammino!
Tobia 8,4-8
4aGli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza».
5Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli!
6Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a lui.
7Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d’intenzione. Dègnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia».
8E dissero insieme: «Amen, amen!».
Luca 5,17-26
Un giorno stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: “Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati”. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: “Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?”. Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: “Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire”Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico
-: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua”. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano:“Oggi abbiamo visto cose prodigiose”.
Io ti dico / Come nel caso di Sara, moglie di Tobia, l’invito ad alzarci ci viene dalla parola di un altro. Non è detto infatti che riusciamo sempre a trovare in noi le risorse o le forze. Già questo paralitico si era lasciato portare da altri e dalla loro fede (cf. Lc 5,18.20). Possiamo dunque aver fiducia: non siamo soli. In tanti modi e da tante parti una parola di rinascita, di risurrezione, ci può raggiungere: ed è sempre una parola d’amore (cf. Cantico dei cantici 2,10.13)
Esclamò rivolto al paralitico / Quante paralisi si possono opporre al nostro alzarci! Pochi versetti più avanti, Luca presenterà Levi “paralizzato” al banco delle imposte. Un passato lo inchioda lì. Eppure anche lui, in forza della parola di un altro, da seduto che era (Lc 5,27) si rialzerà (cf. Lc 5,28). Diversamente dai farisei e dai maestri della legge che rimarranno seduti (Lc 5,17) sulle loro presunte certezze, Levi procederà a un nuovo inizio che gli è stato reso possibile. C’è un passato che, in tanti modi, può paralizzarci: nel male e nel (presunto) bene. A Gesù non interessa tanto il passato delle persone: gli sta a cuore il loro futuro.
Àlzati / Siamo invitati a (ri)sorgere, a lasciare una situazione per andare incontro con fiducia al futuro. L’alzarsi non è evento magico e può non essere istantaneo (cf. Abramo in Genesi 13,14-17) e ci porta a vedere e a vivere le cose in maniera diversa. La stessa Maria di Nazaret, dopo aver accolto la Parola, si alza (Lc 1,39) e si mette in cammino.
Va’ a casa tua / Il poter alzarci e camminare ci riporta … a casa nostra! La guarigione, la liberazione operata dalla Parola ci restituisce a noi stessi, alla nostra verità e alle nostre relazioni più profonde.
Si alzò davanti a loro / La parola ascoltata e accolta trasforma la nostra interiorità, ma porta un cambiamento che anche gli altri possono constatare e accogliere. «Il comportamento esterno fece conoscere al fratello e a tutti gli altri di casa la trasformazione che si era compiuta dentro la sua anima» (Ignazio di Loyola, Autobiografia, n. 10)
Oggi / La possibilità di alzarci è e sarà sempre oggi, perché oggi questo Gesù, fedelmente, ci rivolge questa sua parola, ci ridona nuovamente questa possibilità. Il brano che comincia narrando di un giorno in apparenza qualunque (letteralmente: In uno di quei giorni) si conclude con l’oggi della salvezza (espressione cara all’evangelista Luca: 2,11; 4,21; 19,5.9; 22,34; 23,43). Nella sua sapienza, la Chiesa pone questa invocazione nel tempo cosiddetto ordinario: «Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno, fa’ che segni l’inizio di una vita nuova» (dalle Lodi del venerdì della seconda settimana del salterio).
Un invito, oppure un imperativo? Un’imposizione oppure un atto d’amore? Difficile capire, certamente dipende dal contesto, là dove ci troviamo e soprattutto chi abbiamo accanto, perché detto così … alzati…richiama comunque ad una presenza.
È la voce di chi ci ama e che tiene a noi, ad ogni costo. È la voce di chi sa che le fatiche maggiori ad alzarci e dare movimento alla nostra vita abitano dentro di noi e sa soprattutto che la presenza è indispensabile, mai banale ed inutile.
Alzati, allora risuona come un’attenzione, forse una dedizione per ricordarci dove siamo e quali scelte oggi sono da raccontare nuovamente affinché non perdano di significato e di intensità. Se non ci alziamo rischiamo che la vita rimanga lì dove un giorno l’abbiamo incontrata, sempre lì ferma ed immobile.
Ma viene anche da pensare a quante infinite volte come genitori abbiamo urlato dietro ai figli questo verbo. Spesso non certo con benevolenza.
Se penso ai miei primi due figli, se ripenso alle fatiche inumane per destarli dal sonno e poi accompagnarli a scuola mi verrebbe da dire che è stato, senza alcun dubbio, uno dei verbi più usato nel contesto della nostra famiglia.
Mi risuona ancora nella testa…Alzati… e ancora mi sembra di ascoltarne gli echi. Sappiamo bene che non basta metterli al mondo i figli, serve ogni giorno ridestarli alla vita perché scegliere la vita non è tra le cose più scontate. Oggi la scuola domani altre sfide.
Bisogna volerlo di alzarsi e bisogna alzarsi per volerlo. Perché alzarsi è un’azione che determina in sé un dinamismo, un movimento a favore delle ragioni che ogni giorno ci fanno dire sì la vita.

“Il compleanno” è una tela che Marc Chagall dipinse appunto il giorno del suo ventottesimo compleanno, nel 1915.
È il 7 luglio e, dopo aver fatto una passeggiata per Vitebsk, sua città natale, si ritira a casa, al di là del ponte. Là lo raggiunge Bella, la sua giovane fidanzata, che, contravvenendo agli obblighi di brava figlia di una borghese famiglia ebrea osservante, non rincasa per cena ma invece corre dal suo amato per sorprenderlo in un improvvisato festeggiamento.
Racconta la stessa Bella nel suo libro “Come fiamma che brucia”: “Mi affrettavo a raccoglierne altri (fiori) direttamente nei campi, con erbe e radici, perché si conservasse più a lungo per te il profumo della terra.
E una volta a casa radunai tutti i miei scialli colorati, i miei scampoli di seta.
Mi impadronii persino del mio copriletto ricamato e, in cucina, di una pagnotta, e pezzi di pesce fritto, visto che ti piacevano tanto. Con indosso il mio vestito della festa, carica come una mula, mi incamminai verso casa tua”.
Ecco allora che è proprio la forza dirompente dell’amore che lei prova per il suo amato che li solleva entrambi in un appassionato reciproco trasporto verso l’altro...e verso l’alto. Quello che muove Bella è la capacità di abbandonare ogni possibile calcolo di cosa sia conveniente o sconveniente fare per lei, di chiedersi se e come il suo desiderato Marc potrà accogliere o no lo slancio d’amore profondo e gratuito che la sospinge a festeggiarlo il giorno della sua nascita. Non importa. Lo fa. La priorità è quella.
Festeggiare qualcuno nel giorno in cui ricorre il suo compleanno, significa riconoscerlo ed accoglierlo per come è, per quella che è la sua storia, la sua origine.
A ben guardare il quadro... se non si conosce la storia di quel giorno, è difficile capire chi festeggia chi. Così come in definitiva guardando il dipinto è difficile immaginare chi sia stato il primo a coinvolgere l’altro in uno slancio di desiderio d’amare, e di essere amati. Sicuramente però si può vedere che alla fine sono entrambi ad essere sollevati da terra, accomunati da un unico istintivo desiderio di lasciarsi elevare dall’esperienza dell’amore.
Può essere allora interessante provare a immedesimarci in questo dipinto per riflettere sul verbo alzarsi, e scorgere in noi come e quanto siamo capaci di lasciare fardelli, calcoli e fuorvianti sensi del dovere, per andare verso l’altro con il solo desiderio dell’incontrarlo.
Provare a porsi nello stesso orizzonte di revisione riguardo alla propria capacità di accogliere, liberi da pesi, preconcetti e a volte anche rancori verso l’altro/’altra/gli altri che un giorno abbiamo scelto per una vita fianco a fianco.
Quel che ci suggerisce questo quadro, è che a volte per riuscire a farlo è necessario che siamo capaci di capovolgerci un po’ cambiando direzione al nostro punto di vista, e così, distogliendo mente, occhi e passi da incrostate certezze, siamo davvero capaci di lasciare che l’incontro sia occasione per alzarci, per sollevare i piedi da terra e così facendo far desiderare di alzarsi anche chi ci è vicino, ponendoci in una nuova prospettiva che porti ad incontrare veramente il volto dell’altro.

La proposta cinematografica per il verbo àlzati è Paterson: un film del 2016 scritto e diretto da Jim Jarmusch, uno dei più importanti e rinomati autori del cinema indipendente americano, interpretato, nel ruolo del protagonista, da Adam Driver, attore che l’anno prima era diventato noto al pubblico mondiale interpretando un ruolo di grande notorietà nella trilogia sequel di Guerre Stellari.
In un tempo scandito dai giorni della settimana, a Paterson, nel New Jersey, vive un uomo che si chiama come la sua città: Paterson.
A ogni giorno della settimana sono dedicati i sette capitoli del film che iniziano sempre dal momento in cui, la mattina presto, Paterson si alza dal letto, che condivide con sua moglie Laura, per andare a lavorare.
Paterson guida gli autobus nelle vie di Paterson, tutti i giorni attraversa le stesse strade, incontra gli stessi colleghi di lavoro: però, diversamente da ciò che si potrebbe immaginare, la vita di Paterson (interpretato da Adam Driver – cognome che significa ‘autista’) è tutt’altro che una routine alienante. Perché ogni volta che Paterson apre gli occhi sul suo letto e si alza, il mondo si rivela a lui in modi sorprendenti.
Ogni volta che ne ha la possibilità, nelle pause dell’orario di lavoro o nei momenti di inattività, Paterson trascrive le sue visioni, intuizioni o ispirazioni sulle pagine di un taccuino sotto forma di poesia. Paterson attraversa ogni giorno Paterson, città nativa del poeta da lui amatissimo William Carlos Williams, che alla sua città ha intitolato uno dei suoi più importanti poemi: Paterson, questa parola ricorre quindi in un gioco di nomi che è un gioco di specchi ma che non è solo un gioco, bensì è anche un esercizio di attenzione – nostro e del protagonista del film – che ci fa notare, per esempio, la presenza di alcune comparse di coppie di gemelli.
La ritualità dei gesti che si ripetono (l’uscita serale con il cane) sempre uguali suggerisce una celebrazione naturale del quotidiano che in questa cornice poetica si eleva a sacro.
Il film procede come il racconto di un’anima lirica e contemplativa che, viaggiando nella propria omonima città, coglie l’essenza di sé e della vita. Ogni giorno Paterson si alza e formula con una contemplazione poetica una sorta di preghiera laica, dove trovano cittadinanza onoraria i frammenti del suo mondo, a volte i più banali (come una scatola di fiammiferi), capaci d’ispirare uno sguardo sensibile, intelligente, al
quale non manca l’ironia.
In uno dei suoi primi risvegli, quasi come un elemento antifrastico, sul comodino di Paterson s’intravede un’opera di Melville, scrittore in lotta con la realtà, alla ricerca drammatica di una rivelazione, sovente tragica. Paterson è agli antipodi dei personaggi melvilliani, è un uomo che contempla il mondo e lo accoglie così com’è, senza bisogno di conquistare qualcosa, nemmeno la pubblicazione delle sue poesie, è un uomo senza ambizioni che gli avvelenino la vita, neppure quelle sia pure innocenti di sua moglie.
Paterson non ha bisogno di rivelazioni perché si è già alzato e svegliato, e i suoi occhi sono aperti. Aspetta solo di poter contemplare con amore il paesaggio che già conosce, e tanto gli basta: la sua vita non necessita di altro, essa è già poesia così com’è.